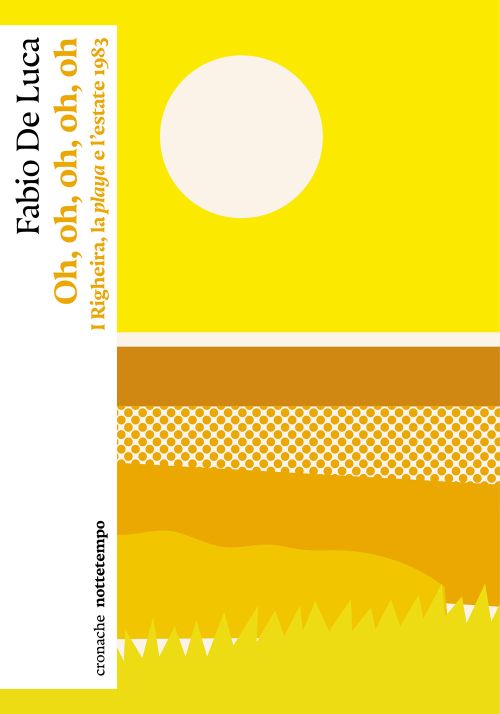
Parafrasando quella vecchia lenza di Federico Fiumani, “dov’eri tu nel 1983?”. Anzi, più precisamente: dov’eri tu nell’estate del 1983, la prima delle trentamila volte che hai sentito Vamos a la playa? Rispondo alla mia stessa domanda: avevo 15 anni e ero in Sardegna con i miei, in un villaggio vacanze chiamato Il Califfo (Califano non c’entrava niente, purtroppo). Sì, proprio il classico, archetipico, terrificante – intonazione fantozziana – villaggio vacanze anniottanta, quello con task force di milanesi arricchiti-ma-non -così-tanto (se no non sarebbero stati lì), corsi di windsurf/tiro con l’arco/yoga/ping pong, giochi-caffè, balli di gruppo in piscina e tutto il resto del depliant Valtur. Un posto che ho odiato ferocemente dal primo minuto in cui ci ho messo piede fino a quando la Lancia Beta di mio padre è uscita dal parcheggio in direzione traghetto, e ancora oggi mi stupisce che i miei sforzi mentali per farlo esplodere, tipo Daria Halprin in Zabriskie Point, non avessero avuto successo. Mia madre e mio padre, invece, che all’epoca avevano rispettivamente diciassette e dieci anni meno di quanti ne abbia io adesso, si divertivano molto. Retrospettivamente, un po’ li capisco: gli orrendi anni 70 erano finiti anche per loro.
Sta di fatto che fu lì, nella atroce canicola post-prandiale a bordo piscina in quell’inizio di luglio 1983, che per la prima volta ascoltai prorompere da una radio quel riff di synth e quel refrain che lo senti una volta e non lo dimentichi più per tutta la vita. Oggi lo chiamano “earworm”, io preferisco attenermi al più classico “trapano”. Ricordo due cose: la prima è che come probabilmente milioni di altri ho pensato automaticamente che quelli che cantavano fossero spagnoli (e invece erano due formidabili cazzoni di Barriera di Milano e Settimo Torinese, pensa un po’), e la seconda è il “ma che è stammerda??” sibilato dall’insegnante di chitarra del fetido villaggio vacanze, un milanese (e come ti sbagli?) simpatico come la scabbia che vessava tutti quotidianamente con Wish You Were Here, La canzone del sole e Generale. Forse è anche per quello che quei due pisquani finto-spagnoli mi furono immediatamente simpatici e che quarant’anni dopo penso ancora che Vamos a la playa sia una canzone pop immortale.

Tutto questo per dire che ho iniziato Oh, oh, oh, oh, oh – I Righeira, la playa e l’estate 1983 di Fabio De Luca (edizioni Nottetempo) con la certezza che mi sarebbe piaciuto. Per tre motivi, sostanzialmente. Il primo, appunto, è che ho sempre avuto un debole per Vamos a la playa ma soprattutto per i Righeira orgoglio-de-sta-città. L’estate sta finendo mi commuove tutte le volte che la sento e penso sia una delle più belle canzoni italiane di sempre, Luciano Serra pilota la trovo geniale (Amedeo Nazzari + New Order!), lo spleen urbano di Vivo al 139 mi intenerisce, mentre mi piace un po’ meno No tengo dinero che mi è sempre sembrata una Playa riuscita peggio. E poi quei due mi facevano morire dal ridere quando li vedevo in televisione. Mi mettevano allegria. Non c’entrano niente quegli stupidi e paraculissimi concetti tipo “guilty pleasure” o “scheletri nell’armadio”: no, a me i Righeira sono sempre piaciuti davvero, così come mi piacevano davvero Ivan Cattaneo, Sergio Caputo, i Matia Bazar, il Gruppo Italiano, tutta gente che nel libro sfila doverosamente al banco dei testimoni. Laddove invece di tanti altri nomi citati nelle stesse pagine posso solo dire che mi facevano paura e dai quali mi sentivo minacciato fisicamente, ma di questo dopo.
Il secondo motivo è che adoro la scrittura di Fabio De Luca. A mio parere, una delle tre-quattro migliori penne italiane in ambito giornalistico-musicale, uno così bravo che gli ho persino perdonato l’aver fatto a pezzi i Ramones in quel leggendario speciale di Rumore di venticinque anni fa, “La corazzata Potëmkin” (idea sua, mi pare di ricordare), lo stesso in cui i Groovers, cioè il sottoscritto e Pierpaolo Vettori, brutalizzarono Henry Rollins. Conoscendo le rispettive fanbase, non so chi dei due avesse rischiato di più la pelle. Comunque: De Luca a scrivere è un fuoriclasse assoluto, e siccome negli ultimi anni lo fa con molta parsimonia bisogna cogliere l’occasione al volo.
Terzo e ultimo motivo: come è evidente, un argomento del genere srotola tutto un reticolato di riferimenti generazionali e localistici nel quale non potevo non finire avviluppato. Ci sono decine di inneschi che appena ci cammini sopra fanno esplodere memorie su memorie, anche quelle che ti eri sforzato di seppellire tipo detriti tossici. Insomma, ero sicuro che questo libro mi sarebbe piaciuto. Quello che non immaginavo è che mi sarebbe piaciuto così tanto.

Con sprezzo della banalità, mi viene da definire Oh, oh, oh, oh, oh in parte indagine, in parte oral history, in parte saggio storico-sociale (non sociologico) su una canzone e su un periodo. Ma soprattutto indagine. E infatti è proprio un cliché cinematografico che mi viene in mente fin dalle prime pagine: l’autore come il Christian Bale/Arthur Stuart di Velvet Goldmine, giornalista- misto-Philip Marlowe, quello che si mette cocciutamente sulle tracce del fantasma pop di un’epoca lontana. Analogia che forse sarà passata per la mente anche a De Luca, che infatti all’inizio si descrive/immagina così: “seppellito in un sottoscala umido e male aerato, di fronte a un muro mezzo scrostato sul quale svolazzano dozzine di fotografie, date e ritagli di giornali (…) uno di quei protagonisti di serie tv true crime – in genere ex detective in pensione oppure caduti in disgrazia – ossessionati da un’indagine della quale non sono venuti a capo e che gli consuma la vita”.
Come in tutte le indagini sfilano prove, reperti, indizi, “si dice”, ricostruzioni oggettive e soprattutto testimonianze di persone informate dei fatti. Alcune di queste vorresti durassero il doppio o il triplo, tanto sono vive e coinvolgenti. Dagli inevitabili Linus, Cecchetto, D’Agostino, Massarini ai ricordi scintillanti di glitter e arguzia di Raffaella Riva e Patrizia di Malta del Gruppo Italiano (la cui Tropicana è forse la hit 1983-ina più assimilabile, per gusto, tema e ispirazioni, a Vamos a la playa), dalla sempre radiosa Antonella Ruggiero a Carmelo La Bionda, purtroppo scomparso poco dopo l’intervista, a personaggi assolutamente incredibili come Claudio Casalini, discografico e dj del bel mondo romano anni 70-80 (“sono il primo a aver suonato Barry White in Italia: la gente mi chiedeva ma chi è, Alberto Lupo?”) la cui vita alla Manuel Fantoni – così rappresentativa di quella che De Luca definisce “disco-commedia all’italiana” – andrebbe raccontata da uno Zampa o un Monicelli dei tempi d’oro.
Come ogni detective che si rispetti, l’autore viaggia molto per andare a raccogliere le sue testimonianze. Lo vediamo prendere un sacco di treni, trenini, tram e metropolitane per andare ad appuntamenti in bar, barucci, dehors, caffè, stabilimenti balneari (ovviamente, visto l’argomento). Da Cervia (per i N.O.I.A.) a Milano, da Riccione al comprensorio per ricchi dell’Olgiata (con tanto di guardiani armati), dalla Torino righeiriana percorsa in lungo e in largo a posti improbabili come Vimodrone. Tutto ciò dà ritmo – tunz tunz tunz, o forse meglio ciuf ciuf ciuf – alla narrazione, ma allo stesso tempo suggerisce paralleli tra epoche diverse nei quali sono protagonisti i luoghi, come sono oggi ma con lo spettro incombente di come erano allora, in quell’Italia da secondo boom economico eppure ancora irriducibilmente provinciale. Una specie di hauntology all’italiana. Come quando vai a cercare una sala prove in via Accademia Albertina – quella dove nel dicembre del 1981 è nato il germe di Vamos a la playa – e ci trovi un negozio di tappezzeria.
Ed è proprio in quell’Italia e in quella industria discografica ancora provinciale e naif, per quanto popolata di personaggi smagatissimi e con l’istinto ferino riguardo a “cosa può funzionare” – che prende corpo in un periodo di tempo abbastanza lungo e vari stop and go la creatura Vamos a la playa. Il termine “creatura” può suggerire qualcosa prodotto in vitro, secondo la tradizione consolidata della hit-factory. In parte un po’ è stato così, ma molto di più è stato il risultato di incastri fortuiti, coincidenze, incontri (il demo industrial-wave della versione originaria che grazie a Susanna, amica di Johnson e Michael Righeira, finisce nelle mani dei fratelli La Bionda, gli Svengali del duo sabaudo con i quali tuttavia si costituisce un rapporto quasi paritario). E naturalmente della follia sgangherata ma a modo suo lucidissima di due ventenni della periferia torinese appassionati di punk, new wave, discomusic, Marinetti, drum machine e cravatte disegnate da Ettore Sottsass. Dalla mescolanza di tutto ciò – e il libro lo racconta benissimo – è venuto fuori quel miracolo di Vamos a la playa. Una canzone che ha fatto ballare e fischiettare milioni di persone nonostante parlasse del fall out dopo-bomba (ma quanti se ne rendevano conto? Io no per esempio, l’ho scoperto solo anni dopo). Una canzone che tutti, ma proprio tutti, conoscono. Anche chi nel 1983 era una lontanissima ipotesi. Ho fatto la prova con mio figlio di otto anni. Gliel’ho fatta ascoltare e gli ho chiesto “ma senti un po’, questa la conosci?”, lui ci pensa per tutta la intro poi quando parte il refrain mi dice “ah sì, certo!”. Ora, io sono sicuro che non l’avesse mai sentita fisicamente prima. Ma Vamos a la playa è quel genere di canzone: quella che entra nel dna di una nazione e si trasmette geneticamente.

Poi c’è tutto il discorso del contesto, dello sfondo e della cornice. Non a caso il sottotitolo del libro è “I Righeira, la playa e l’estate del 1983”. Eccolo: il 1983. Secondo De Luca, col quale sulla base dei miei ricordi credo di concordare, è quello il primo vero anno degli Ottanta. O almeno di quei mitici, famigerati anni Ottanta le cui rievocazioni infinite ce li hanno fatti uscire dagli occhi e soprattutto dalle orecchie. Logica vuole, dunque, che il 1982 fosse invece l’ultimo dei Settanta, decennio lungo per antonomasia (era cominciato nel 1968) chiuso definitivamente dalla voce di Nando Martellini che scandisce per tre volte “campioni del mondo!”. Chiunque abbia avuto l’età della ragione all’epoca, soprattutto se proprio in quel periodo si affacciava all’adolescenza dopo una infanzia scandita da terrorismo e crisi economica, oltre che da Giochi senza frontiere, piste Scalextric e Novantesimo minuto, non può che essere d’accordo. Proprio in quel lasso di tempo, tra l’82 e l’83, si avvertì per la prima volta un cambiamento di scenografia e di clima. Nel libro, Roberto D’Agostino (nell’83 non ancora lookologo arboriano) sostiene invece che tutto era cominciato nel ’78, con la gente che tornava a uscire e aveva di nuovo voglia di divertirsi dopo quell’eterna assemblea extraparlamentare che erano stati gli anni 70. Sarà, forse lui che è di un’altra generazione ha avuto quell’impressione. Chi ha la mia età invece ha troppi ricordi da bambino di lenzuola sull’asfalto in qualunque telegiornale del ’79 o dell’80 per essere d’accordo. Personalmente, avanzo un’altra interpretazione cronologica. E cioè che il 1983 in realtà fu una chiusura anch’esso. Nello specifico, di quella breve finestra temporale nella quale in Italia – a livello inizialmente underground ma, come Vamos a la playa testimonia, con ricadute decisamente overground – la creatività dei giovani, la sincera voglia di qualcosa che fosse nuovo e diverso da quel tunnel degli orrori appena attraversato, le mille influenze che arrivavano dall’estero ma anche quelle autoctone, potevano dare inizio a un decennio molto diverso da quello che poi sarebbe diventato. Molto più libero, gioioso, anarchico anche da un punto di vista pop. A un certo punto c’era di tutto, nell’alambicco: il punk e il postpunk, l’elettronica, le nuove tecnologie, il situazionismo, l’onda lunga del post-’77, il citazionismo intelligente degli anni 50 e 60 (ma pure dei 30 e dei 40, senza connotazioni sospette) non ancora preda della tediosa nostalgia stile Anima mia, nuovi scrittori, nuovi artisti, nuovi designer, nuove riviste, nuovi locali, una rete di etichette indipendenti. E soprattutto non c’era più quella mostruosa palla al piede della politica e dell’ideologia ad appesantire tutto. Tempo un anno, e dal 1984 circa tutto ciò degenererà – con le solite dovute eccezioni – in disimpegno, rampantismo, paninari, musica in gran parte orrenda e vestiario ancora peggiore. Il bisogno di leggerezza e il gusto sano per il lato frivolo della vita diventeranno obbligo di divertirsi per decreto, kitsch che non ha più nulla di creativo e surreale ma si riduce al puro e semplice cattivo gusto. Ovvero: gli anniottanta che tutti ricordiamo e che io ho odiato quanto quell’accidente di villaggio vacanze in Sardegna.
Lo ammetto: faccio ancora oggi molta fatica a confrontarmi con quel mondo. Per sfuggire al quale mi ero rifugiato in un altro, fatto di…va beh, sostanzialmente di quello di cui ho sempre scritto come giornalista che si occupa di musica. Ci sono nomi e argomenti, in Oh, oh, oh, oh, oh, nei confronti dei quali mi avvicino tuttora con scafandro e contatore geiger. Tutto quell’universo di Festivalbar, disco remix, Radio DJ, stilisti, Fiorucci, Armani, darkettoni, wannabe berlinesi, Videomusic, balearic pop, e così via. Ma non solo: ho delle difficoltà – su un piano decisamente più nobile – anche con personaggi degnissimi e giustamente molto amati come Pier Vittorio Tondelli, com’è ovvio qui citato più volte. Non ho mai sfogliato un numero di “Frigidaire”, e della mitologica Firenze new wave credo non me ne sia mai fregato niente. Eppure, paradossalmente, i miei momenti preferiti nel libro di De Luca sono quando si immerge in argomenti a me alieni. Per esempio c’è una chiacchierata con Francesca Delogu, ex direttrice di Cosmopolitan Italia, tutta incentrata sul lato “fashionista” della questione Righeira – e 1983, e tutto il resto – che mi ha letteralmente rapito. Ecco, questa è una capacità che invidio all’autore. Quella di saper guardare in certi abissi estetici, essendone chiaramente attratto, ma senza farsene risucchiare e traendone sempre considerazioni illuminanti. Se si vuole parlare di cultura pop in modo davvero interessante e fertile, forse non è una buonissima idea pensare che non valga la pena soffermarsi su tutto ciò che esula dai bootleg dei Feelies, dal catalogo SST, dalle antologie della Sarah Records e dei primi sette volumi di Back from the Grave (tutte cose che peraltro credo De Luca conosca perfettamente).

Competenza, passione per il soggetto di cui si tratta ma soprattutto scrittura fanno sempre la differenza. Tremo al pensiero di cosa avrebbe potuto diventare questo libro in altre mani. Per fortuna De Luca è uno che non giudica, non filosofeggia, non monta in cattedra, non si lancia in funambolismi post-moderni e se si abbandona a qualche inevitabile nostalgia quanto meno è di prima mano. Lo stile è inappuntabile, e godibilissimo. Ho il sospetto che per lui abbia contato molto più Arbasino che Lester Bangs, e se a volte è evidente il debito di riconoscenza verso maestri come Tommaso Labranca, e nel gusto per il gioco di parole addirittura verso il già citato D’Agostino, c’è da dire che non c’è mai la minima ombra di cinismo. Anzi, esattamente l’opposto. La chiave emotiva con cui si racconta l’argomento è quella dell’affetto. Per quel periodo, quei personaggi, quella musica. Il che permette di evitare tanto l’agiografia retromaniaca quanto la pallosa freddezza della dissertazione da cultural studies. Con in più, un contrappunto di malinconia perfettamente adeguato all’oggetto. Perché non c’è dubbio che nei Righeira, in quel mondo e in diverse di quelle canzoni ci fosse un lato profondamente malinconico, magari inconsapevole. Forse perché avevano già intuito che certi futuri possibili e sognati non si sarebbero mai avverati. E cosa può esserci di più malinconico di Blue Monday che risuona in una casa appena svuotata e che ci si sta per chiudere alle spalle definitivamente?

A proposito di stile, malinconia e capacità di evocare tempi e luoghi passati. Ci voleva un genovese trapiantato a Milano per raccontare così bene la Torino di quel periodo. Attraverso i ricordi di Stefano Righi/Johnson Righeira, certo, ma anche nei sopralluoghi dell’autore sul posto. In certi passaggi ho avuto proprio la sensazione di rivederla e riannusarla, quella Torino del 1983 (che è stato l’anno di Vamos a la playa ma anche quello del rogo dello Statuto). Una città molto più classista e a compartimenti stagni di oggi. Per me, piccolo borghesuccio di Cit Turin, la Barriera di Milano di Johnson, così come altri quartieri di periferia, semplicemente non esistevano. Mi ricordo di una volta in cui andammo a casa di un nostro compagno di scuola che stava alla Falchera, e mentre viaggiavamo sul 71 con lo stesso spirito di Fitzcarraldo sul Rio delle Amazzoni diedi un ulteriore botta alla mia già non irresistibile popolarità dicendo “beh, speriamo che i nativi non siano ostili”. Oggi per una battuta del genere verresti crocifisso via social, allora per fortuna ci si limitava alle cinghiate in faccia, che erano comunque un metodo più onesto e genuino di mostrare disappunto. Era comunque una città che, con tutti i suoi difetti, in modo carsico vedeva nascere delle cose. Mentre oggi, per citare De Luca, “come la Londra di Burial, Torino è una città perseguitata non tanto dal passato, quanto dai suoi futuri perduti”. Questa me la rivendo, sicuro.
La Torino appesa per il collo a mamma Fiat. La Torino con più di un milione di abitanti, in cui l’ondata migratoria interna si era conclusa da qualche anno e quella esterna non era ancora cominciata. La Torino in cui Juve e Toro non abitavano ancora galassie diverse (nel 1983 uno dei due stranieri granata era il “vice-Maradona” Patricio Hernandez: segnalo a De Luca l’assonanza con Patrick Hernandez). E visto che si parla di estate la Torino che ad agosto si desertificava, letteralmente. Una delle pagine più belle del libro racconta proprio quando Johnson Righeira ebbe l’ispirazione, in quel vuoto cosmico ferragostano, per una strofa di L’estate sta finendo, quella che recita “è tempo che i gabbiani ritornino in città”. Era lì che viaggiava sul 3 – ah, l’odore delle foglie secche e di gomma bruciata dei vecchi tram torinesi! – e mentre passa sulla Dora all’altezza del ponte Bologna vede uno stormo di gabbiani sorvolare il fiume. C’è tutto, lì dentro: Gozzano, Fruttero & Lucentini, Gipo Farassino, Fred Buscaglione & Leo Chiosso.

Stefano Righi alias Johnson Righeira viene fuori esattamente come ti immagini che sia. Simpatico, gaglioffo, casinaro, a volte inaffidabile (la parte iniziale in cui De Luca narra i tentativi di mettersi in contatto con lui via whatsapp è impagabile), geniale, appassionato, di cuore. E 101% torinese. Pur essendo concittadini e con presumibilmente molte conoscenze in comune, gli ho parlato di persona solo una volta, per circa trenta secondi. Era seduto davanti a me sull’aereo che ci stava portando a Barcellona per il Primavera (lui come spettatore, anche se un “Righeira play the hits” all’Auditori sarebbe stata un’idea mica male). Non parlammo di new wave e synthpop, ma della qualità pessima del servizio di Easy Jet. Finito, questa è la mia esperienza con Johnson Righeira. Però, ripeto, mi è sempre sembrato istintivamente simpatico, uno di quelli con cui potevi fare le cinque di mattina a chiacchierare alle Cantine Risso, e il libro conferma l’impressione. Manca invece la voce di Michael Righeira/Stefano Rota, che non ha voluto essere interpellato. Come viene specificato fin dalla prima pagina, i due “stanno litigati” da qualche anno. Sui motivi si sorvola con molta delicatezza e rispetto. C’è però un punto in cui Johnson parla di Michael, su esplicita domanda di De Luca, e colpisce la somiglianza con quello che George Michael disse di Andrew Ridgeley: “Senza Michael, tutto quello che ti ho raccontato in questi mesi non sarebbe mai potuto succedere. Anche se sono stato io il motore iniziale della cosa, senza la sua energia e la sua forza nulla di tutto questo ci sarebbe mai stato: il mondo dei Righeira lo abbiamo immaginato insieme”. Chissà se un giorno si riappacificheranno, magari al chiosco di qualche playa, fosse anche quella del Sangone. Magari succederà, magari no. Quello che dovevano fare insieme, comunque, lo hanno fatto.
Non riesco a trovare appunti da fare a Oh, oh, oh, oh, oh. Tranne due, ma sono sciocchezzuole da nerd. Il primo è un errata corrige, ovviamente non musicale (come potrei?) ma calcistica: a Messico 86 l’Italia venne sbattuta fuori negli ottavi, non nei quarti. Il secondo invece è la delusione per non aver visto citato – ma forse me lo ricordo solo io – uno dei miei aneddoti preferiti Righeira-related. Quando cioè i due vennero menati dai Marillion. Pensateci un attimo. I-Righeira-menati-dai-Marillion. Non è un crash in grado di creare un cortocircuito logico e spaziotemporale assoluto? Io ho questo netto ricordo di averla sentita raccontare da Johnson a Red Ronnie in una puntata di Be bop a lula, o quel che era. Credo fosse l’85, in qualche modo c’entrava l’Heysel (e qui purtroppo non c’è niente da ridere), le due parti si erano incrociate in qualche albergo e Johnson e Michael avevano pensato bene di urlare “english animals!”, con quegli altri che anche giustamente si erano un po’…risentiti. Comunque la parte più divertente è quando Johnson nominava il cantante della band inglese: “sai, il tipo che canta, come si chiama..Fish…(pausa)….FISH”. Il modo in cui pronuncia il nome (come a dire: “cioè, ma come cazzo fai a farti chiamare Fish?”) era purissimo umorismo e understatement da piola di corso Giulio Cesare.

Ci sarebbero diversi altri aspetti interessanti del libro su cui soffermarsi – dalle riflessioni su “che cos’è davvero un tormentone” al “quanto si guadagnava con un tormentone?” – ma ho già fatto fin troppi spoiler e non vorrei rovinare ulteriormente il piacere a chi non l’ha ancora letto. Avendo iniziato con una parafrasi, chiudo con un’altra parafrasi che cita direttamente proprio gli eroi di questa storia: “l’estate sta finendo, un anno se ne va, sto diventando vecchio, anche se non mi va”. Negli ultimi tempi mi sono sorpreso più di una volta con la guardia abbassata rispetto a certi babau della mia adolescenza. Mi sono divertito con Pop Life di Luca De Gennaro, mi sono commosso con il documentario sugli Wham, adesso questo libro. Cos’altro devo aspettarmi? Comprerò la discografia degli Alphaville? Mi scioglierò con un biopic su Howard Jones? Divorerò una autobiografia di Nik Kershaw? Meglio non pensarci. Either I’m too sensitive or else I’m getting soft, come diceva un tizio. Il concetto di “memoria condivisa” in genere è applicato a cose infinitamente più serie e drammatiche della music pop. Ma anche qui può avere un suo senso.
Non ce la farò probabilmente mai a dire “formidabili quegli anni”. Quello no. Magari in una prossima vita. Ma questo libro formidabile lo è sul serio. Ah, nel caso non si fosse capito: io e l’autore nell’estate del 1983 avevamo la stessa età. Anche adesso, suppongo.
