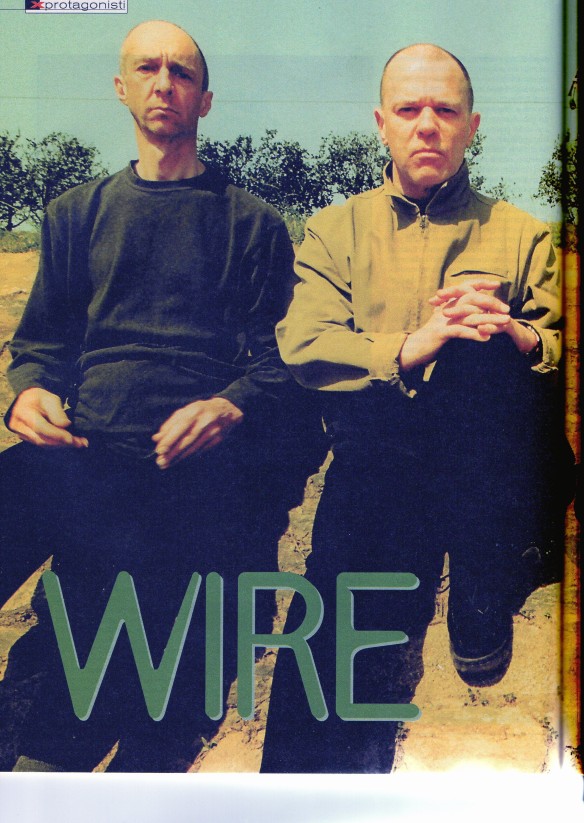















IL GIALLO DELL’ESTATE – Oh oh oh oh oh, i Righeira, la playa e il 1983
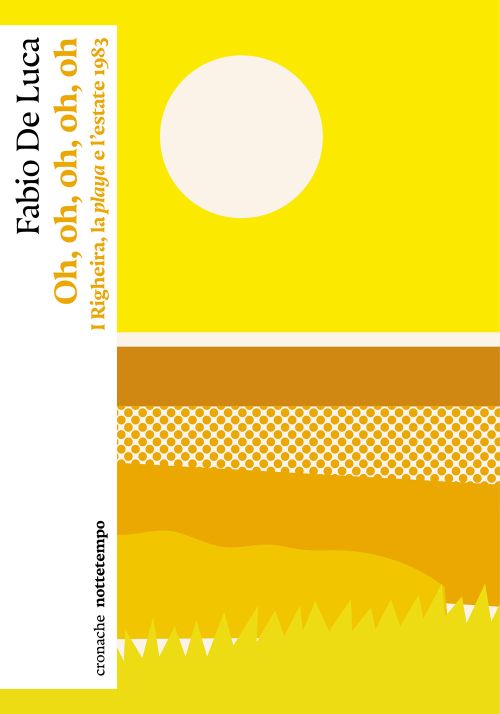
Parafrasando quella vecchia lenza di Federico Fiumani, “dov’eri tu nel 1983?”. Anzi, più precisamente: dov’eri tu nell’estate del 1983, la prima delle trentamila volte che hai sentito Vamos a la playa? Rispondo alla mia stessa domanda: avevo 15 anni e ero in Sardegna con i miei, in un villaggio vacanze chiamato Il Califfo (Califano non c’entrava niente, purtroppo). Sì, proprio il classico, archetipico, terrificante – intonazione fantozziana – villaggio vacanze anniottanta, quello con task force di milanesi arricchiti-ma-non -così-tanto (se no non sarebbero stati lì), corsi di windsurf/tiro con l’arco/yoga/ping pong, giochi-caffè, balli di gruppo in piscina e tutto il resto del depliant Valtur. Un posto che ho odiato ferocemente dal primo minuto in cui ci ho messo piede fino a quando la Lancia Beta di mio padre è uscita dal parcheggio in direzione traghetto, e ancora oggi mi stupisce che i miei sforzi mentali per farlo esplodere, tipo Daria Halprin in Zabriskie Point, non avessero avuto successo. Mia madre e mio padre, invece, che all’epoca avevano rispettivamente diciassette e dieci anni meno di quanti ne abbia io adesso, si divertivano molto. Retrospettivamente, un po’ li capisco: gli orrendi anni 70 erano finiti anche per loro.
Sta di fatto che fu lì, nella atroce canicola post-prandiale a bordo piscina in quell’inizio di luglio 1983, che per la prima volta ascoltai prorompere da una radio quel riff di synth e quel refrain che lo senti una volta e non lo dimentichi più per tutta la vita. Oggi lo chiamano “earworm”, io preferisco attenermi al più classico “trapano”. Ricordo due cose: la prima è che come probabilmente milioni di altri ho pensato automaticamente che quelli che cantavano fossero spagnoli (e invece erano due formidabili cazzoni di Barriera di Milano e Settimo Torinese, pensa un po’), e la seconda è il “ma che è stammerda??” sibilato dall’insegnante di chitarra del fetido villaggio vacanze, un milanese (e come ti sbagli?) simpatico come la scabbia che vessava tutti quotidianamente con Wish You Were Here, La canzone del sole e Generale. Forse è anche per quello che quei due pisquani finto-spagnoli mi furono immediatamente simpatici e che quarant’anni dopo penso ancora che Vamos a la playa sia una canzone pop immortale.

Tutto questo per dire che ho iniziato Oh, oh, oh, oh, oh – I Righeira, la playa e l’estate 1983 di Fabio De Luca (edizioni Nottetempo) con la certezza che mi sarebbe piaciuto. Per tre motivi, sostanzialmente. Il primo, appunto, è che ho sempre avuto un debole per Vamos a la playa ma soprattutto per i Righeira orgoglio-de-sta-città. L’estate sta finendo mi commuove tutte le volte che la sento e penso sia una delle più belle canzoni italiane di sempre, Luciano Serra pilota la trovo geniale (Amedeo Nazzari + New Order!), lo spleen urbano di Vivo al 139 mi intenerisce, mentre mi piace un po’ meno No tengo dinero che mi è sempre sembrata una Playa riuscita peggio. E poi quei due mi facevano morire dal ridere quando li vedevo in televisione. Mi mettevano allegria. Non c’entrano niente quegli stupidi e paraculissimi concetti tipo “guilty pleasure” o “scheletri nell’armadio”: no, a me i Righeira sono sempre piaciuti davvero, così come mi piacevano davvero Ivan Cattaneo, Sergio Caputo, i Matia Bazar, il Gruppo Italiano, tutta gente che nel libro sfila doverosamente al banco dei testimoni. Laddove invece di tanti altri nomi citati nelle stesse pagine posso solo dire che mi facevano paura e dai quali mi sentivo minacciato fisicamente, ma di questo dopo.
Il secondo motivo è che adoro la scrittura di Fabio De Luca. A mio parere, una delle tre-quattro migliori penne italiane in ambito giornalistico-musicale, uno così bravo che gli ho persino perdonato l’aver fatto a pezzi i Ramones in quel leggendario speciale di Rumore di venticinque anni fa, “La corazzata Potëmkin” (idea sua, mi pare di ricordare), lo stesso in cui i Groovers, cioè il sottoscritto e Pierpaolo Vettori, brutalizzarono Henry Rollins. Conoscendo le rispettive fanbase, non so chi dei due avesse rischiato di più la pelle. Comunque: De Luca a scrivere è un fuoriclasse assoluto, e siccome negli ultimi anni lo fa con molta parsimonia bisogna cogliere l’occasione al volo.
Terzo e ultimo motivo: come è evidente, un argomento del genere srotola tutto un reticolato di riferimenti generazionali e localistici nel quale non potevo non finire avviluppato. Ci sono decine di inneschi che appena ci cammini sopra fanno esplodere memorie su memorie, anche quelle che ti eri sforzato di seppellire tipo detriti tossici. Insomma, ero sicuro che questo libro mi sarebbe piaciuto. Quello che non immaginavo è che mi sarebbe piaciuto così tanto.

Con sprezzo della banalità, mi viene da definire Oh, oh, oh, oh, oh in parte indagine, in parte oral history, in parte saggio storico-sociale (non sociologico) su una canzone e su un periodo. Ma soprattutto indagine. E infatti è proprio un cliché cinematografico che mi viene in mente fin dalle prime pagine: l’autore come il Christian Bale/Arthur Stuart di Velvet Goldmine, giornalista- misto-Philip Marlowe, quello che si mette cocciutamente sulle tracce del fantasma pop di un’epoca lontana. Analogia che forse sarà passata per la mente anche a De Luca, che infatti all’inizio si descrive/immagina così: “seppellito in un sottoscala umido e male aerato, di fronte a un muro mezzo scrostato sul quale svolazzano dozzine di fotografie, date e ritagli di giornali (…) uno di quei protagonisti di serie tv true crime – in genere ex detective in pensione oppure caduti in disgrazia – ossessionati da un’indagine della quale non sono venuti a capo e che gli consuma la vita”.
Come in tutte le indagini sfilano prove, reperti, indizi, “si dice”, ricostruzioni oggettive e soprattutto testimonianze di persone informate dei fatti. Alcune di queste vorresti durassero il doppio o il triplo, tanto sono vive e coinvolgenti. Dagli inevitabili Linus, Cecchetto, D’Agostino, Massarini ai ricordi scintillanti di glitter e arguzia di Raffaella Riva e Patrizia di Malta del Gruppo Italiano (la cui Tropicana è forse la hit 1983-ina più assimilabile, per gusto, tema e ispirazioni, a Vamos a la playa), dalla sempre radiosa Antonella Ruggiero a Carmelo La Bionda, purtroppo scomparso poco dopo l’intervista, a personaggi assolutamente incredibili come Claudio Casalini, discografico e dj del bel mondo romano anni 70-80 (“sono il primo a aver suonato Barry White in Italia: la gente mi chiedeva ma chi è, Alberto Lupo?”) la cui vita alla Manuel Fantoni – così rappresentativa di quella che De Luca definisce “disco-commedia all’italiana” – andrebbe raccontata da uno Zampa o un Monicelli dei tempi d’oro.
Come ogni detective che si rispetti, l’autore viaggia molto per andare a raccogliere le sue testimonianze. Lo vediamo prendere un sacco di treni, trenini, tram e metropolitane per andare ad appuntamenti in bar, barucci, dehors, caffè, stabilimenti balneari (ovviamente, visto l’argomento). Da Cervia (per i N.O.I.A.) a Milano, da Riccione al comprensorio per ricchi dell’Olgiata (con tanto di guardiani armati), dalla Torino righeiriana percorsa in lungo e in largo a posti improbabili come Vimodrone. Tutto ciò dà ritmo – tunz tunz tunz, o forse meglio ciuf ciuf ciuf – alla narrazione, ma allo stesso tempo suggerisce paralleli tra epoche diverse nei quali sono protagonisti i luoghi, come sono oggi ma con lo spettro incombente di come erano allora, in quell’Italia da secondo boom economico eppure ancora irriducibilmente provinciale. Una specie di hauntology all’italiana. Come quando vai a cercare una sala prove in via Accademia Albertina – quella dove nel dicembre del 1981 è nato il germe di Vamos a la playa – e ci trovi un negozio di tappezzeria.
Ed è proprio in quell’Italia e in quella industria discografica ancora provinciale e naif, per quanto popolata di personaggi smagatissimi e con l’istinto ferino riguardo a “cosa può funzionare” – che prende corpo in un periodo di tempo abbastanza lungo e vari stop and go la creatura Vamos a la playa. Il termine “creatura” può suggerire qualcosa prodotto in vitro, secondo la tradizione consolidata della hit-factory. In parte un po’ è stato così, ma molto di più è stato il risultato di incastri fortuiti, coincidenze, incontri (il demo industrial-wave della versione originaria che grazie a Susanna, amica di Johnson e Michael Righeira, finisce nelle mani dei fratelli La Bionda, gli Svengali del duo sabaudo con i quali tuttavia si costituisce un rapporto quasi paritario). E naturalmente della follia sgangherata ma a modo suo lucidissima di due ventenni della periferia torinese appassionati di punk, new wave, discomusic, Marinetti, drum machine e cravatte disegnate da Ettore Sottsass. Dalla mescolanza di tutto ciò – e il libro lo racconta benissimo – è venuto fuori quel miracolo di Vamos a la playa. Una canzone che ha fatto ballare e fischiettare milioni di persone nonostante parlasse del fall out dopo-bomba (ma quanti se ne rendevano conto? Io no per esempio, l’ho scoperto solo anni dopo). Una canzone che tutti, ma proprio tutti, conoscono. Anche chi nel 1983 era una lontanissima ipotesi. Ho fatto la prova con mio figlio di otto anni. Gliel’ho fatta ascoltare e gli ho chiesto “ma senti un po’, questa la conosci?”, lui ci pensa per tutta la intro poi quando parte il refrain mi dice “ah sì, certo!”. Ora, io sono sicuro che non l’avesse mai sentita fisicamente prima. Ma Vamos a la playa è quel genere di canzone: quella che entra nel dna di una nazione e si trasmette geneticamente.

Poi c’è tutto il discorso del contesto, dello sfondo e della cornice. Non a caso il sottotitolo del libro è “I Righeira, la playa e l’estate del 1983”. Eccolo: il 1983. Secondo De Luca, col quale sulla base dei miei ricordi credo di concordare, è quello il primo vero anno degli Ottanta. O almeno di quei mitici, famigerati anni Ottanta le cui rievocazioni infinite ce li hanno fatti uscire dagli occhi e soprattutto dalle orecchie. Logica vuole, dunque, che il 1982 fosse invece l’ultimo dei Settanta, decennio lungo per antonomasia (era cominciato nel 1968) chiuso definitivamente dalla voce di Nando Martellini che scandisce per tre volte “campioni del mondo!”. Chiunque abbia avuto l’età della ragione all’epoca, soprattutto se proprio in quel periodo si affacciava all’adolescenza dopo una infanzia scandita da terrorismo e crisi economica, oltre che da Giochi senza frontiere, piste Scalextric e Novantesimo minuto, non può che essere d’accordo. Proprio in quel lasso di tempo, tra l’82 e l’83, si avvertì per la prima volta un cambiamento di scenografia e di clima. Nel libro, Roberto D’Agostino (nell’83 non ancora lookologo arboriano) sostiene invece che tutto era cominciato nel ’78, con la gente che tornava a uscire e aveva di nuovo voglia di divertirsi dopo quell’eterna assemblea extraparlamentare che erano stati gli anni 70. Sarà, forse lui che è di un’altra generazione ha avuto quell’impressione. Chi ha la mia età invece ha troppi ricordi da bambino di lenzuola sull’asfalto in qualunque telegiornale del ’79 o dell’80 per essere d’accordo. Personalmente, avanzo un’altra interpretazione cronologica. E cioè che il 1983 in realtà fu una chiusura anch’esso. Nello specifico, di quella breve finestra temporale nella quale in Italia – a livello inizialmente underground ma, come Vamos a la playa testimonia, con ricadute decisamente overground – la creatività dei giovani, la sincera voglia di qualcosa che fosse nuovo e diverso da quel tunnel degli orrori appena attraversato, le mille influenze che arrivavano dall’estero ma anche quelle autoctone, potevano dare inizio a un decennio molto diverso da quello che poi sarebbe diventato. Molto più libero, gioioso, anarchico anche da un punto di vista pop. A un certo punto c’era di tutto, nell’alambicco: il punk e il postpunk, l’elettronica, le nuove tecnologie, il situazionismo, l’onda lunga del post-’77, il citazionismo intelligente degli anni 50 e 60 (ma pure dei 30 e dei 40, senza connotazioni sospette) non ancora preda della tediosa nostalgia stile Anima mia, nuovi scrittori, nuovi artisti, nuovi designer, nuove riviste, nuovi locali, una rete di etichette indipendenti. E soprattutto non c’era più quella mostruosa palla al piede della politica e dell’ideologia ad appesantire tutto. Tempo un anno, e dal 1984 circa tutto ciò degenererà – con le solite dovute eccezioni – in disimpegno, rampantismo, paninari, musica in gran parte orrenda e vestiario ancora peggiore. Il bisogno di leggerezza e il gusto sano per il lato frivolo della vita diventeranno obbligo di divertirsi per decreto, kitsch che non ha più nulla di creativo e surreale ma si riduce al puro e semplice cattivo gusto. Ovvero: gli anniottanta che tutti ricordiamo e che io ho odiato quanto quell’accidente di villaggio vacanze in Sardegna.
Lo ammetto: faccio ancora oggi molta fatica a confrontarmi con quel mondo. Per sfuggire al quale mi ero rifugiato in un altro, fatto di…va beh, sostanzialmente di quello di cui ho sempre scritto come giornalista che si occupa di musica. Ci sono nomi e argomenti, in Oh, oh, oh, oh, oh, nei confronti dei quali mi avvicino tuttora con scafandro e contatore geiger. Tutto quell’universo di Festivalbar, disco remix, Radio DJ, stilisti, Fiorucci, Armani, darkettoni, wannabe berlinesi, Videomusic, balearic pop, e così via. Ma non solo: ho delle difficoltà – su un piano decisamente più nobile – anche con personaggi degnissimi e giustamente molto amati come Pier Vittorio Tondelli, com’è ovvio qui citato più volte. Non ho mai sfogliato un numero di “Frigidaire”, e della mitologica Firenze new wave credo non me ne sia mai fregato niente. Eppure, paradossalmente, i miei momenti preferiti nel libro di De Luca sono quando si immerge in argomenti a me alieni. Per esempio c’è una chiacchierata con Francesca Delogu, ex direttrice di Cosmopolitan Italia, tutta incentrata sul lato “fashionista” della questione Righeira – e 1983, e tutto il resto – che mi ha letteralmente rapito. Ecco, questa è una capacità che invidio all’autore. Quella di saper guardare in certi abissi estetici, essendone chiaramente attratto, ma senza farsene risucchiare e traendone sempre considerazioni illuminanti. Se si vuole parlare di cultura pop in modo davvero interessante e fertile, forse non è una buonissima idea pensare che non valga la pena soffermarsi su tutto ciò che esula dai bootleg dei Feelies, dal catalogo SST, dalle antologie della Sarah Records e dei primi sette volumi di Back from the Grave (tutte cose che peraltro credo De Luca conosca perfettamente).

Competenza, passione per il soggetto di cui si tratta ma soprattutto scrittura fanno sempre la differenza. Tremo al pensiero di cosa avrebbe potuto diventare questo libro in altre mani. Per fortuna De Luca è uno che non giudica, non filosofeggia, non monta in cattedra, non si lancia in funambolismi post-moderni e se si abbandona a qualche inevitabile nostalgia quanto meno è di prima mano. Lo stile è inappuntabile, e godibilissimo. Ho il sospetto che per lui abbia contato molto più Arbasino che Lester Bangs, e se a volte è evidente il debito di riconoscenza verso maestri come Tommaso Labranca, e nel gusto per il gioco di parole addirittura verso il già citato D’Agostino, c’è da dire che non c’è mai la minima ombra di cinismo. Anzi, esattamente l’opposto. La chiave emotiva con cui si racconta l’argomento è quella dell’affetto. Per quel periodo, quei personaggi, quella musica. Il che permette di evitare tanto l’agiografia retromaniaca quanto la pallosa freddezza della dissertazione da cultural studies. Con in più, un contrappunto di malinconia perfettamente adeguato all’oggetto. Perché non c’è dubbio che nei Righeira, in quel mondo e in diverse di quelle canzoni ci fosse un lato profondamente malinconico, magari inconsapevole. Forse perché avevano già intuito che certi futuri possibili e sognati non si sarebbero mai avverati. E cosa può esserci di più malinconico di Blue Monday che risuona in una casa appena svuotata e che ci si sta per chiudere alle spalle definitivamente?

A proposito di stile, malinconia e capacità di evocare tempi e luoghi passati. Ci voleva un genovese trapiantato a Milano per raccontare così bene la Torino di quel periodo. Attraverso i ricordi di Stefano Righi/Johnson Righeira, certo, ma anche nei sopralluoghi dell’autore sul posto. In certi passaggi ho avuto proprio la sensazione di rivederla e riannusarla, quella Torino del 1983 (che è stato l’anno di Vamos a la playa ma anche quello del rogo dello Statuto). Una città molto più classista e a compartimenti stagni di oggi. Per me, piccolo borghesuccio di Cit Turin, la Barriera di Milano di Johnson, così come altri quartieri di periferia, semplicemente non esistevano. Mi ricordo di una volta in cui andammo a casa di un nostro compagno di scuola che stava alla Falchera, e mentre viaggiavamo sul 71 con lo stesso spirito di Fitzcarraldo sul Rio delle Amazzoni diedi un ulteriore botta alla mia già non irresistibile popolarità dicendo “beh, speriamo che i nativi non siano ostili”. Oggi per una battuta del genere verresti crocifisso via social, allora per fortuna ci si limitava alle cinghiate in faccia, che erano comunque un metodo più onesto e genuino di mostrare disappunto. Era comunque una città che, con tutti i suoi difetti, in modo carsico vedeva nascere delle cose. Mentre oggi, per citare De Luca, “come la Londra di Burial, Torino è una città perseguitata non tanto dal passato, quanto dai suoi futuri perduti”. Questa me la rivendo, sicuro.
La Torino appesa per il collo a mamma Fiat. La Torino con più di un milione di abitanti, in cui l’ondata migratoria interna si era conclusa da qualche anno e quella esterna non era ancora cominciata. La Torino in cui Juve e Toro non abitavano ancora galassie diverse (nel 1983 uno dei due stranieri granata era il “vice-Maradona” Patricio Hernandez: segnalo a De Luca l’assonanza con Patrick Hernandez). E visto che si parla di estate la Torino che ad agosto si desertificava, letteralmente. Una delle pagine più belle del libro racconta proprio quando Johnson Righeira ebbe l’ispirazione, in quel vuoto cosmico ferragostano, per una strofa di L’estate sta finendo, quella che recita “è tempo che i gabbiani ritornino in città”. Era lì che viaggiava sul 3 – ah, l’odore delle foglie secche e di gomma bruciata dei vecchi tram torinesi! – e mentre passa sulla Dora all’altezza del ponte Bologna vede uno stormo di gabbiani sorvolare il fiume. C’è tutto, lì dentro: Gozzano, Fruttero & Lucentini, Gipo Farassino, Fred Buscaglione & Leo Chiosso.

Stefano Righi alias Johnson Righeira viene fuori esattamente come ti immagini che sia. Simpatico, gaglioffo, casinaro, a volte inaffidabile (la parte iniziale in cui De Luca narra i tentativi di mettersi in contatto con lui via whatsapp è impagabile), geniale, appassionato, di cuore. E 101% torinese. Pur essendo concittadini e con presumibilmente molte conoscenze in comune, gli ho parlato di persona solo una volta, per circa trenta secondi. Era seduto davanti a me sull’aereo che ci stava portando a Barcellona per il Primavera (lui come spettatore, anche se un “Righeira play the hits” all’Auditori sarebbe stata un’idea mica male). Non parlammo di new wave e synthpop, ma della qualità pessima del servizio di Easy Jet. Finito, questa è la mia esperienza con Johnson Righeira. Però, ripeto, mi è sempre sembrato istintivamente simpatico, uno di quelli con cui potevi fare le cinque di mattina a chiacchierare alle Cantine Risso, e il libro conferma l’impressione. Manca invece la voce di Michael Righeira/Stefano Rota, che non ha voluto essere interpellato. Come viene specificato fin dalla prima pagina, i due “stanno litigati” da qualche anno. Sui motivi si sorvola con molta delicatezza e rispetto. C’è però un punto in cui Johnson parla di Michael, su esplicita domanda di De Luca, e colpisce la somiglianza con quello che George Michael disse di Andrew Ridgeley: “Senza Michael, tutto quello che ti ho raccontato in questi mesi non sarebbe mai potuto succedere. Anche se sono stato io il motore iniziale della cosa, senza la sua energia e la sua forza nulla di tutto questo ci sarebbe mai stato: il mondo dei Righeira lo abbiamo immaginato insieme”. Chissà se un giorno si riappacificheranno, magari al chiosco di qualche playa, fosse anche quella del Sangone. Magari succederà, magari no. Quello che dovevano fare insieme, comunque, lo hanno fatto.
Non riesco a trovare appunti da fare a Oh, oh, oh, oh, oh. Tranne due, ma sono sciocchezzuole da nerd. Il primo è un errata corrige, ovviamente non musicale (come potrei?) ma calcistica: a Messico 86 l’Italia venne sbattuta fuori negli ottavi, non nei quarti. Il secondo invece è la delusione per non aver visto citato – ma forse me lo ricordo solo io – uno dei miei aneddoti preferiti Righeira-related. Quando cioè i due vennero menati dai Marillion. Pensateci un attimo. I-Righeira-menati-dai-Marillion. Non è un crash in grado di creare un cortocircuito logico e spaziotemporale assoluto? Io ho questo netto ricordo di averla sentita raccontare da Johnson a Red Ronnie in una puntata di Be bop a lula, o quel che era. Credo fosse l’85, in qualche modo c’entrava l’Heysel (e qui purtroppo non c’è niente da ridere), le due parti si erano incrociate in qualche albergo e Johnson e Michael avevano pensato bene di urlare “english animals!”, con quegli altri che anche giustamente si erano un po’…risentiti. Comunque la parte più divertente è quando Johnson nominava il cantante della band inglese: “sai, il tipo che canta, come si chiama..Fish…(pausa)….FISH”. Il modo in cui pronuncia il nome (come a dire: “cioè, ma come cazzo fai a farti chiamare Fish?”) era purissimo umorismo e understatement da piola di corso Giulio Cesare.

Ci sarebbero diversi altri aspetti interessanti del libro su cui soffermarsi – dalle riflessioni su “che cos’è davvero un tormentone” al “quanto si guadagnava con un tormentone?” – ma ho già fatto fin troppi spoiler e non vorrei rovinare ulteriormente il piacere a chi non l’ha ancora letto. Avendo iniziato con una parafrasi, chiudo con un’altra parafrasi che cita direttamente proprio gli eroi di questa storia: “l’estate sta finendo, un anno se ne va, sto diventando vecchio, anche se non mi va”. Negli ultimi tempi mi sono sorpreso più di una volta con la guardia abbassata rispetto a certi babau della mia adolescenza. Mi sono divertito con Pop Life di Luca De Gennaro, mi sono commosso con il documentario sugli Wham, adesso questo libro. Cos’altro devo aspettarmi? Comprerò la discografia degli Alphaville? Mi scioglierò con un biopic su Howard Jones? Divorerò una autobiografia di Nik Kershaw? Meglio non pensarci. Either I’m too sensitive or else I’m getting soft, come diceva un tizio. Il concetto di “memoria condivisa” in genere è applicato a cose infinitamente più serie e drammatiche della music pop. Ma anche qui può avere un suo senso.
Non ce la farò probabilmente mai a dire “formidabili quegli anni”. Quello no. Magari in una prossima vita. Ma questo libro formidabile lo è sul serio. Ah, nel caso non si fosse capito: io e l’autore nell’estate del 1983 avevamo la stessa età. Anche adesso, suppongo.
HIS EVER CHANGING MOODS – Intervista a Paul Weller

Paul Weller è uno che intimidisce. Per almeno quattro ragioni. La prima è il carisma. La seconda è che non sta mai fermo, si muove a scatti e quando parla ti guarda direttamente negli occhi. La terza è la sua fama di mangia-giornalisti. La quarta vale solo per scrive, ed ha a che fare con il vecchio adagio che non si dovrebbero mai incontrare i propri eroi personali perché eccetera eccetera. Il risultato è che il registratore, intimidito pure lui, si inceppa dopo mezzo minuto, e mentre il sottoscritto si arrabatta per farlo ripartire cercando nel contempo di fare il disinvolto con la star – “una sigaretta, Paul?” “No, non fumo mai prima di un concerto.”. “Ah, giusto, ci mancherebbe altro.” – la prima domanda la fa proprio lui, l’intervistato.
Are you nervous, mate?
Figurati. Non c’è motivo. A parte il fatto che mi trovo davanti a un mio mito ultraventennale e che proprio ieri ho letto di una tua vecchia intervista nella quale già alla terza domanda minacciavi il giornalista di spaccargli la faccia…
Ah, ma quella è roba di dieci anni fa. Altri tempi. Le interviste oggi quasi mi divertono, contrariamente a quello che succedeva in passato. E poi si trattava di un giornalista inglese, altra razza. Qui siete più civili. Gran parte della stampa lassù da noi è inqualificabile. Quella musicale poi è anche peggio della media: si danno un sacco di arie intellettuali, poi però mantengono sempre questa maledetta impronta da “tabloid”, non se la toglieranno mai. Si cerca lo scandalo, la si butta sul personale. Ma a chi gliene frega della mia vita privata, o di quante pinte bevo al pub? A me interessa solo parlare di musica, e credo che a chi legge debba interessare soprattutto quella. Per cui non ti preoccupare. Al massimo, alla prima domanda non gradita.. (accenna una mossa di pugilato, fortunatamente aggiungendoci una risata, NdI)
Fantastico, ora sì che sono rilassato. Bene, allora parliamo di… musica? Il tuo nuovo disco mi pare decisamente più tonico degli ultimi due in studio.
La penso anch’io così.
Meno male.
No, davvero. Penso che sia in assoluto la cosa migliore che abbia mai fatto. Meglio anche di Stanley Road o del mio primo album da solista, che per motivi diversi sono i lavori ai quali mi sento più affezionato. In As Is Now ho messo dentro tutto quel che mi piace, è come se avessi compresso i miei grandi amori musicali. A little bit of funk, a little bit of soul, a little bit of folk, a little bit of… whatever. Le canzoni sono dirette, alcune come Come On Let’s Go o From The Floor Boards Up sono rock’n’roll e ti arrivano dritte in faccia, pensa ai primi pezzi degli Stones, ai singoli dei Sex Pistols, Holiday In the Sun … bang! …quel feeling lì, insomma. E poi ci sono quelle più sottili, con le melodie che puntano al cuore, proprio come… non so, ti ricordi certe ballate di Otis Redding? …ecco, As Is Now è quello che un disco pop dovrebbe sempre essere. Illumination e Heliocentric avevano canzoni troppo lunghe, forse mi ero fatto prendere la mano. Ascoltate singolarmente funzionano, ma tutto l’insieme alla fine suona un po’ ridondante. Non che ci sputi sopra, sono due buoni album, ma a posteriori mi accorgo che non mi rappresentano del tutto. Questo invece è venuto fuori esattamente come volevo.
Le canzoni di As Is Now, rock’n’roll o ballate che siano, hanno in effetti un’immediatezza formidabile. La produzione è eccellente, ma c’è quella frenesia un po’ sporca da “buona la prima” che fa sembrare il disco quasi un live non dichiarato…
È così. Lo abbiamo registrato in meno di due settimane, con pochissimo lavoro di post-produzione. Credo che si avverta la freschezza tipica di un’incisione dal vivo. C’è quel senso di urgenza, quasi come se il disco si fosse creato da solo. Guarda, è andata in questo modo: avevo una ventina di canzoni pronte, il venerdì ho finito il tour, durante il weekend ho scelto i pezzi, il lunedì eravamo in studio, dieci giorni dopo il disco era finito. That’s rock’n’roll.

Hai detto che è un disco che ti rappresenta alla perfezione. Quindi immagino che il titolo sia una specie di dichiarazione auto-pubblicitaria: “eccovi il Paul Weller di oggi, enjoy him!” Mi ha fatto venire in mente, forse anche per il lettering del titolo e la foto di copertina, una vecchia usanza dei Sixties. Penso a dischi come Rolling Stones Now! o Here Are the Sonics. Il prodotto artistico e l’advertising insieme, un concetto molto pop-art…
Hai centrato abbastanza bene la questione. La copertina è davvero ricalcata su una serie di cartoline pubblicitarie degli anni Sessanta, opera di un cartellonista piuttosto famoso all’epoca. Ma è più per il gusto della citazione che per altro. Il grosso delle mie influenze viene sempre da quel periodo, sarebbe stupido negarlo, ma il giorno che mi accorgessi di fare del revival appenderei la chitarra al muro e mi dedicherei a qualcos’altro. Adoro i Sixties, lo sanno tutti, la ma nostalgia non mi interessa. Quello che voglio è fare musica che suoni contemporanea, che sia importante oggi. È il concetto che mi ha sempre guidato nella mia carriera di musicista, trent’anni fa come adesso. Le canzoni dei Jam erano giuste per il 1979, quelle degli Style Council per il 1985. E queste sono state scritte per essere ascoltate oggi, non nel 1967, nel ‘68 o in un altro fottuto anno del secolo scorso.
A quanto pare la voglia di andare veloce non ti è passata, nonostante gli anni.
Sono un vecchio mod. Non mi passerà mai.
Già, ma mi chiedevo se la pressione che senti oggi è la stessa di quando a neanche ventitré anni spedivi regolarmente ogni singolo in cima alle classifiche.
La pressione della musica, quella sì continuo a sentirla. Tutto ciò che ci gira attorno, l’industria, la stampa, le charts, beh quella roba non mi fa più né caldo né freddo. Ho imparato a gestirla. Arrivi a un punto della tua vita in cui capisci che l’unica cosa che conta è la tua integrità come musicista, il resto sono cazzate. All’epoca dei Jam si viveva talmente veloce che all’inizio non me ne rendevo neanche conto, poi quando mi fermavo un attimo montava tutta l’angoscia che proviene dal sentirsi intrappolato nel music-business. A vent’anni è difficile fronteggiare l’insuccesso, ma ti assicuro che confrontarsi con il successo è infinitamente più dura. Ti può stritolare. È una droga che agisce a due livelli, ti rifila euforia e depressione con la stessa intensità. Da un lato hai realizzato tutto ciò che sognavi la prima volta che hai preso una chitarra in mano. Immagina di avere dodici anni e di iniziare a suonare. Mentre sei lì che imiti le tue canzoni preferite alla radio, la tua massima aspirazione è formare una band. Poi quando ce l’hai, vorresti che fosse una band che incide un disco. E dopo ancora vorresti che fosse una band che incide un disco che va al numero uno in classifica. E poi, una volta che al numero uno ci sei arrivato? Che altro puoi sognare? Era quello il problema, negli ultimi tempi dei Jam. A ventiquattro anni è un bel casino, non sei più sicuro di niente. Adesso è tutto molto più semplice: il mio unico sogno è continuare a fare quel che faccio, che è scrivere canzoni. Quello è il massimo. E poi suonare dal vivo, che è il massimo dei massimi! Adoro andare in tour. Il rovescio della medaglia è l’essere lontani dalla famiglia, ma la vita on the road, nonostante tutta la noia o la malinconia o lo squallore dei tour-bus con quelle maledette partite a carte nelle quali perdo sempre, mi piace ancora adesso.
Sembra che tu ti diverta più oggi che venticinque anni fa.
È esattamente così. Anzi, è oggi che mi diverto davvero.
Ripensando alla tua gioventù con i Jam, cosa provi?
Orgoglio. Abbiamo fatto grande musica, grandi canzoni. Ma non poteva durare all’infinito.
Forse anche perché avevate iniziato giovanissimi.
Già, io avevo sedici anni. No, aspetta, quattordici.
Come è stata la tua educazione musicale?
La stessa di quasi tutti quelli della mia generazione: la radio, i dischi, John Peel. Io poi ero particolarmente fortunato, perché c’è sempre stata musica in casa. Negli anni Sessanta mia madre era ancora molto giovane, quando sono nato io aveva solo diciotto anni. Era appassionata di pop e comprava una quantità incredibile di 45 giri. Roba buona: Beatles, Elvis, Shadows, Hollies. Mio padre invece suonava il piano, anche se solo a livello amatoriale. Ho incominciato a capire che per me la musica era una cosa seria verso il ’66, ’67. Accendevo la radio e sentivo questi singoli fantastici degli Small Faces, dei Kinks, degli Who. E poi Strawberry Fields Forever, Penny Lane, Sgt. Pepper’s… la mia venerazione per i Beatles è iniziata allora e mi ha accompagnato per tutta la vita. Ancora oggi ascoltare la voce di Lennon mi commuove, ma c’è stato un periodo, subito dopo il loro scioglimento, in cui ero totalmente ossessionato, come poteva esserlo solo un ragazzino a cui hanno portato via la sua automobilina preferita. Non potevo credere che non ci sarebbe stato mai più un nuovo 45 dei Beatles. Ero talmente disperato che per anni ho comprato i peggiori dischi di Ringo Starr per consolarmi (risate, NdI).

L’amore per i Beatles è sempre stato piuttosto evidente nella tua scrittura. A volte, forse, persino un po’ troppo evidente.
Ah, ok, so dove vuoi andare a parare. Start!, giusto? Sì, è vero, assomiglia tantissimo a Taxman, ma se ho sempre negato che fosse una scopiazzatura di quella canzone c’è un motivo. Ed è che in realtà stavo cercando di copiare il suono di chitarra di Syd Barrett, non di George Harrison!
Syd è un’altra delle tue grandi passioni.
Assolutamente. Ricordo ancora quando ascoltai Arnold Layne e See Emily Play alla radio. Non avevo neanche dieci anni, ma mi si accese una luce nel cervello. Non avevo la minima idea di che diavolo stessero cantando, chi fosse questa Emily o perché questo Arnold si vestisse come una donna, ma il suono mi si conficcò nella mente all’istante.
E la musica nera quando l’hai scoperta? Immagino che da bravo mod tu fossi un fanatico del Northern Soul…
No, quello me lo sono perso. Quando andava forte quel genere di serate, verso il ’71, ’72, ero ancora troppo giovane per spostarmi da Woking fin su a Manchester o Wigan. Ne ho sentito parlare dopo, quando tutto era finito. Ma non avevo bisogno del northern soul per avvicinarmi alla musica nera. Ero già perso nella Motown, nella Stax, nella Atlantic. E poi il northern era un movimento di puristi, e io non sono mai stato un purista in fatto di black music. A me piace tutta la musica nera. Tutta. Oggi come ieri. Il soul, il jazz, il blues, l’r&b, il reggae, l’afro-beat. Adoro allo stesso modo Fela Kuti e Curtis Mayfield, John Coltrane e James Brown. Per un certo periodo, all’inizio degli anni ’90, ho ascoltato anche molto hip-hop, gruppi come i Tribe Called Quest o gli Arrested Development avevano un sacco di soul. Ho perso interesse quando il rap è diventato un fenomeno commerciale e basta.
Tu sei una delle persone ideali a cui rivolgere la fatidica domanda, ovvero: cosa è che rende così speciale la musica nera?
Credo che abbia a che fare con qualcosa di ancestrale. È il suono che abbiamo dentro, perché tutti veniamo dall’Africa. Forse è una teoria un po’ usurata, ma non saprei spiegarlo diversamente. Poi, chiaro, c’è tutta la storia della sofferenza e del riscatto del popolo nero, ma quello viene dopo. Ti rapporti a quella vicenda e questo ti fa apprezzare ancora di più quei suoni che ne sono l’espressione, ma all’origine di tutto c’è un ritmo primordiale che hai sentito migliaia di anni fa in Etiopia o nel Mali o dio sa dove, laggiù in Africa.
Ovunque fosse, comunque molto lontano da Woking. Crescere in una realtà così piccola e provinciale ha accentuato il tuo bisogno di distinguerti?
Quando vivi in un posto così è facile emergere dalla massa, farsi notare a causa dei tuoi gusti musicali o del tuo modo di vestire. Insomma, non è come vivere a Carnaby Street. Ma non ho nulla contro Woking. Non sono di quelli che odiano le proprie radici, tanto è vero che ci torno spesso, ho ancora una casa laggiù. Woking non è un posto così terribile, è una nice little town, la classica realtà suburbana tipicamente inglese, ma certo è molto, molto noiosa. Soprattutto quando sei teenager e sogni di diventare musicista e girare il mondo. Il punto non è che volessi scappare da Woking o dalla mia famiglia. La ribellione era contro tutto il mondo che avevo attorno: la scuola, le uniformi, il conformismo sociale, la musica oscena che ti propinavano le radio e la televisione a metà degli anni ’70. Fossi cresciuto a Londra avrei provato la stessa voglia di scappare. Ovviamente, avrei avuto tutto più a portata di mano. A Woking potevi giusto ubriacarti al pub e fare a botte con qualcuno il sabato sera, quello era il top del divertimento. Così nei week-end si prendeva il treno e si andava a Londra. Hai presente In The City, la canzone? Beh, parla di quello. Era un tributo alla magia che esercitava su di noi provinciali la metropoli. Lì c’era tutto: i locali, i mercatini di dischi, le boutique alternative come Sex, il negozio di Malcolm McLaren e Vivienne Westwood su King’s Road. Che tra l’altro era maledettamente caro, credo di non aver mai comprato niente lì dentro.
L’attenzione maniacale per il look, l’adesione totale allo stile mod, anche quelli sono espressione di quella voglia di scappare dalla noia e dal conformismo di cui parlavi?
In parte sì. Ma in realtà ha più a che fare con la cultura pop, nella quale mi riconosco da sempre. In Inghilterra i due aspetti – musica e stile – sono sempre andati di pari passo. L’ossessione per l’abbigliamento è un tratto costante della pop-culture. Forse dipende dal fatto che molti musicisti provengono dalla working class, la ricerca della camicia o del paio di scarpe giuste è importante come quello di una Rickenbacker d’epoca. È un segno distintivo, vuol dire che ce l’hai fatta, che ti sei lasciato dietro il grigiore dei quartieri-dormitorio in cui sei cresciuto. Non a caso gli hippy erano invece quasi tutti di famiglie ricche o borghesi: vestirsi da pezzenti era il loro modo di distinguersi, loro facevano il percorso inverso rispetto a noi (risate, NdI).

Lo stesso discorso non vale un po’ anche per il punk?
Hai ragione. Molti protagonisti della scena punk erano tutt’altro che proletari, venivano da ambienti altolocati, studiavano al college. Pensa a Joe Strummer, che era comunque una persona meravigliosa e assolutamente sincera. Il fatto è che per noi che arrivavamo da fuori Londra e non avevamo fatto le scuole d’arte, non avevamo letto Debord e tutte quelle altre stronzate, la difficoltà era doppia. Oltre a essere stati presi a bottigliate nei locali della provincia, dovevamo poi anche superare la diffidenza di chi faceva parte della “scena” e ci vedeva come dei campagnoli vestiti da damerini. Ma eravamo abbastanza duri per fregarcene, suonavamo già da parecchio rispetto della maggior parte dei punk della prima ora, e quello ci ha forgiati. Non avevamo paura di nessuno.
Uno dei temi ricorrenti, nei ricordi di tanti musicisti della tua generazione – intendo quelli emersi con il punk – è proprio il senso di isolamento provato durante l’adolescenza. L’esplosione del punk fu una specie di chiamata a raccolta per tutta una tribù di esclusi. È stato così anche per te? Ti sei sentito veramente parte di quel movimento, o quell’etichetta la vedevi come una forzatura?
Non so se è mai esistita una filosofia punk, ma se c’era io mi ci sono riconosciuto in tutto e per tutto. Parlo ovviamente del punk originario. È stata fatta troppa mitologia a posteriori su quel periodo, per me il punk è durato un anno e mezzo, forse anche meno. Ma è stata una liberazione, qualcosa di cui la nostra generazione aveva un maledetto bisogno. Tu non sei inglese e non hai l’età per ricordarti com’era la scena musicale intorno al ’76. Beh, te lo dico io: una merda. Non ne potevamo più, eravamo soffocati da schifezze americane come Fleetwood Mac, REO Speedwagon, Blue Oyster Cult…
Non siete poi andati in tour assieme, con i B.O.C.?
Lasciamo stare, ho dei ricordi tremendi di quel tour. Beh, insomma, la musica americana all’epoca era penosa, e noi dall’Inghilterra rispondevamo con quelle orribili pagliacciate glam o progressive. Non puoi immaginare quale scossa sia stata andare a vedere i Sex Pistols e i Clash al 100 Club o all’Hope & Anchor. Finalmente qualcosa in cui riconoscersi, fatta dalla gente della mia età e che si rivolgeva a gente della mia età. Musica vera, umana, anche se suonata con i piedi e cantata peggio. Nel primo album dei Jam si sente proprio quell’euforia, quel brivido che ti può dare soltanto la scoperta che tutto quello che pensavi finito per sempre era invece rinato di colpo.
Quindi tu sentivi una continuità tra la musica che amavi e i punk, nonostante la voglia di questi ultimi di fare piazza pulita del passato?
Come ti ho detto, il punk per me è durato un anno o poco più. Quello è stato il momento in cui i ragazzi si sono riappropriati della cultura pop, che aveva le sue radici nei Sixties e che è ciò che a me è sempre interessato. Dopo è venuta a galla l’etica del “destroy”, il nichilismo e tutto il resto, proprio perché si prendevano alla lettera slogan come “No Elvis, Beatles or Rolling Stones in 1977”. Ma quelli appunto erano solo slogan, non ci credevano neanche i Clash. Che infatti poi hanno pescato molto dal passato, in particolare dalla musica nera. Anche per questo sentivo molta affinità con loro, nonostante le differenze di stile. Avevano un’attitudine positiva. Raccogliere la fiaccola e andare avanti, non distruggere tanto per distruggere.
I Jam, comunque, erano atipici non solo per quel che riguarda la musica. Nel bel mezzo di una rivoluzione come il punk, che inevitabilmente era anche una ribellione contro i genitori, tu ti sei scelto come manager tuo padre.
Beh, ma mio padre è sempre stato il più punk di tutti! È un vero personaggio, quello che si può definire un “good fella”. Per certi versi è il manager ideale. Ti dà entusiasmo, ti supporta, all’epoca poteva anche fare da guardia del corpo visto che da giovane era stato pugile. Senza contare che in fatto di bevute sotterrava chiunque.
Qual è il disco dei Jam che riascoltato oggi ti sembra più attuale?
Mi piacciono ancora tutti, anche se mi capita di metterli su molto di rado. Non c’è un solo album del quale non sia soddisfatto, neppure This Is The Modern World che probabilmente è il più debole di tutta la mia discografia. Forse di qualche canzone, retrospettivamente, si può dire non sia granché, ma ogni album aveva qualcosa di buono per l’epoca. Forse il mio preferito rimane Sound Affects, che probabilmente è quello che oggi sembra meno datato. Credo dipenda dal fatto che aveva questo suono di chitarra angolare, distorto, un po’ stridente. A quel tempo ero influenzato dallo stile di gruppi come i Gang Of Four o gli Wire, che adesso stanno tornando di moda.
Si sono addirittura riformati, eventualità che temo possiamo escludere per i Jam.
No way. Sarebbe come resuscitare un cadavere. Quella storia si è esaurita con The Gift. Tutto quello che potevamo dare come band lo abbiamo dato in quei cinque o sei anni. Io volevo muovermi in altre direzioni, Bruce e Rick avevano dei limiti ben precisi e preferivano accontentarsi di riscrivere altre venti o trenta Going Underground. Perfetto. È stato bello, addio. Non aveva senso continuare allora, ne avrebbe ancora meno ricominciare adesso.
Quando è stata l’ultima volta che hai incontrato gli altri due Jam?
Quando ho detto loro che il gruppo era finito. Da allora non ci siamo più incrociati, che motivo ci sarebbe? Non so cosa facciano oggi. Qualcuno mi ha detto che Rick Buckler suona in una tribute–band dei Jam.
Oh, mio dio.
Sì, è triste. Ma ognuno vive la sua vita come crede.

Il passaggio dai Jam agli Style Council coincise con un cambiamento nella tua musica, ma non solo. Improvvisamente emersero anche altri riferimenti culturali ed estetici. I Jam erano una quintessenza di “inglesità”, gli Style Council citavano Sartre, l’internazionale socialista e il cappuccino. Cos’era, una svolta esistenzialista?
No, non mi spingerei a tanto. Diciamo che era un mutamento più estetico che culturale, per usare le tue parole. È vero, uno ascoltava i pezzi dei Jam e si immaginava sempre questa Union Jack gigantesca, poi arriviamo io e Mick Talbot fotografati con la Torre Eiffel alle spalle, i café bleu, le Vespe d’epoca… Vedi, è il solito discorso della cultura pop. Noi inglesi contribuiamo con la musica, ma per tutto il resto siamo un disastro. Le cose migliori le prendiamo dall’estero, che siano i vestiti, il design o il caffè espresso. Negli ultimi quindici anni la situazione è migliorata, Londra si è europeizzata, siamo diventati trendy anche noi, ma nei primi anni ’80 c’era un’atmosfera di chiusura totale verso l’esterno. Non ne potevo più di quella mentalità insulare. Andando in tour con i Jam avevo scoperto la qualità della vita di paesi come la Francia, l’Italia, la Spagna. Poi tornavo in Inghilterra, con in mente quei bar favolosi di Roma o Parigi e mi ritrovavo nel solito pub puzzolente del cazzo. Il legame con la Francia, comunque, era anche di carattere musicale. Quando ho iniziato con gli Style Council ero nel mio periodo Blue Note, e in Europa i veri cultori e custodi del jazz sono sempre stati i francesi.
Con Our Favorite Shop però tornasti a esibire la tua britannicità. A parte la copertina che raffigurava la bottega dei sogni di qualsiasi mod, le canzoni commentavano con parole inequivocabili la situazione inglese del periodo. In Come To Milton Keynes, dove ti scagli contro i piani edilizi che trasformano il volto dei piccoli centri, sembra quasi di riascoltare l’elogio della “cara vecchia Inghilterra” del Ray Davies di Village Green Preservation Society.
Può essere. Ho sempre sentito molta affinità con Davies, che ritengo uno dei più grandi autori inglesi nella storia del pop. Nel senso che è stato uno dei pochi a parlare di realtà inglesi, come il sistema di classe o la decadenza della piccola borghesia, quando tutti scimmiottavano l’America. In realtà, per quanto ami i Kinks e in particolare quell’album, credo che ci siano delle differenze. L’Inghilterra per cui Ray ha nostalgia è idillica, non è mai esistita se non in cartolina, e lui intelligentemente se ne serve come metafora. In Our Favorite Shop volevo parlare di questioni reali, della situazione sociale di quegli anni. La crisi delle Trade Unions, l’impoverimento della classe lavoratrice…
Infatti in quel periodo toccasti l’apice del tuo impegno politico. Che giudizio dai oggi dell’esperienza Red Wedge, con la quale cercaste di mobilitare il mondo musicale contro il governo della Thatcher?
Absolute bullshit.
Ah.
Non fraintendermi. Giudico i risultati, non le intenzioni dei musicisti coinvolti. Gente come Billy Bragg o i Madness era sincera, credevano davvero di aiutare i minatori in sciopero e che si potesse dare un contributo all’abbattimento della Thatcher con qualche concerto gratuito e degli sticker sulle copertine dei dischi. Abbiamo visto come è andata. Eravamo troppo ingenui a sperare di poter cambiare le cose. Per carità, ci credevo anch’io. In quei giorni non potevi non schierarti, o stavi con i tories e la loro politica ultraliberista, o li odiavi a morte e avresti fatto qualsiasi cosa per mandarli via. Il problema è che gli artisti hanno l’illusione di poter incidere sulla realtà, ma l’industria dello spettacolo è in grado di svuotare di senso e di strumentalizzare qualsiasi iniziativa. Per la politica, oggi, o almeno per quel tipo di politica, non ho alcun interesse.
Ti definiresti ancora socialista?
Se proprio devo riconoscermi in una tradizione ideologica, sì, non ho nessun problema a dirmi ancora socialista. Ma non ha nulla a che vedere con la politica di oggi. Pensa alle opzioni che hai a disposizione: conservatori e laburisti sono indistinguibili, Blair è una Thatcher con il filtro. No, non me ne frega più niente della politica. La lascio agli altri, io scrivo canzoni.

Verso la fine dell’esperienza con gli Style Council ci fu un ennesimo cambiamento nella tua geografia musicale. Con Modernism: A New Decade cercasti di spostare il baricentro addirittura verso la house. Se quel disco, che per certi versi anticipava la fusione di tradizione rock e acid-culture, non fosse stato cassato dalla Polydor, credi che il sodalizio con Mick Talbot avrebbe potuto continuare?
Non penso. A quel punto la vicenda degli Style Council si era esaurita. Avevamo perso entusiasmo tutti. La casa discografica, il pubblico, Mick, io stesso. Sia io che lui avevamo messo su famiglia, e non eravamo così felici di farci sottrarre del tempo da dedicare ai figli per promuovere dischi che non avrebbero avuto successo comunque. Non ho idea dell’accoglienza che avrebbe ricevuto Modernism. Era un po’ troppo in anticipo sui tempi, non so quanto pubblico nuovo avremmo potuto attirare. Quanto al mio, gran parte era scandalizzata dal fatto che mi dedicassi a musica da discoteca.
A quel punto, chiusa la pratica Style Council, sei sparito per un paio di anni.
Ero senza contratto, senza un progetto, ma soprattutto senza energie. Un po’ come quando era finita con i Jam, solo che allora avevo immediatamente ricaricato le pile ed ero tornato subito in pista con Mick. Nel 1990 ero invece completamente svuotato. Per due anni mi sono preso cura della mia famiglia, ho riascoltato i vecchi dischi della mia collezione, sono tornato a rifugiarmi a Woking. Puoi chiamarlo un periodo di riflessione, se vuoi. La realtà è che pur continuando a scrivere canzoni, quelle che poi sono finite sul mio primo album da solo, mi mancava terribilmente il contatto con il pubblico. La febbre da palco, quella è una malattia da cui non si guarisce mai. Così a un certo punto mi sono detto “al diavolo, riproviamoci” e sono tornato a fare concerti. L’impatto fu terribile, mi trovai a suonare davanti a meno di cento persone per sera. Era come se qualcuno mi avesse preso per il collo e riportato ai primi tempi con i Jam, quando ci sbattevamo nei pub del Surrey.
Però hai risalito subito la china. Wildwood e Stanley Road sono diventati dei classici del rock inglese degli anni ’90. Il loro successo ti ha colto di sorpresa?
Quello di Wildwood sicuramente. Quando uscì Stanley Road ero già più preparato, anche se certo non mi aspettavo un numero uno in classifica e il disco di platino. Sono due ottimi dischi, anche se molto diversi come impostazione. Wildwood è quanto di più vicino al folk abbia mai fatto, ha delle eccellenti canzoni ma una produzione che non mi ha mai esaltato più di tanto. Su Stanley Road invece ha funzionato tutto alla perfezione, ho potuto concentrarmi maggiormente sul suono visto che i pezzi erano già stati rodati dal vivo. Non è un album che riascolto spesso. Alcune canzoni oggi mi sembrano troppo oscure, troppo intense. Ma è sicuramente uno dei lavori di cui sono più fiero.
In un’intervista, per spiegare il tuo nuovo approccio alla scrittura, ti inventasti una frase molto divertente: “mi sono messo ad ascoltare gli artisti che odiavo da giovane, quelli con la barba”.
Era vero. Subito dopo la fine degli Style Council mi sono avvicinato a un certo rock classico dei primi anni ’70 che quando ero giovane non consideravo proprio. Non che li odiassi, quei musicisti, i nemici erano altri. È che a diciott’anni avevo troppa frenesia in corpo per fermarmi ad ascoltarli. È musica che richiede concentrazione, dedizione, e io all’epoca non potevo concedergliene. Sto parlando di Neil Young, dei Traffic, di Van Morrison, di Nick Drake. Soprattutto Drake, che per me è stata una tardiva ma bellissima scoperta. La prova che la grande musica può cambiarti la vita anche molto dopo l’adolescenza.
A proposito di adolescenza, come giudichi le giovani leve del pop inglese? C’è qualche nuovo gruppo che ti piace?
Penso che sia un momento fantastico per la musica pop, in Uk. Se accendo la radio, rispetto a dieci o quindici anni fa la percentuale di canzoni che mi piacciono si è alzata notevolmente. In giro ci sono band con un suono energico ma che sanno scrivere anche grandi melodie. I Maxïmo Park, gli Ordinary Boys, i Subways, solo per dirti i primi che mi vengono in mente.
Tutti gruppi in qualche modo influenzati dai Jam. Ma tutto questo guardarsi indietro non è contrario allo spirito del “modernismo”?
Non penso che questi ragazzi vivano nel passato. Hanno un sound contemporaneo, attuale. Poi, è chiaro, hanno le loro influenze. La cultura pop non si propaga nel vuoto. Tutti abbiamo preso spunto dalla musica che ci ha preceduto, ma non ci vedo nulla di male in questo.
Compri ancora molti dischi? Oppure ti sei convertito anche tu alle nuove tecnologie?
Non parlarmi di i-pod, mp3 e roba del genere. Non la capisco, non voglio capirla. Sarà anche diventato tutto molto più comodo e veloce, ma per me l’ascolto della musica non ha niente a che fare con la velocità. Sono di un’altra generazione, quella di chi i dischi li ascoltava davvero, non si limitava a sentire un pezzo e poi se non gli piaceva lo cancellava dal computer. Sì, continuo a comprare tonnellate di dischi, quando ho tempo per andare nei negozi. È una droga, non posso farci niente.
Se dovessi partire per un viaggio lunghissimo e potessi portare con te solo un disco, un libro e un film, quali sceglieresti?
Wow, queste sono le domande che mi mandano in crisi. Allora, vediamo. Il disco sarebbe Odessey And Oracle degli Zombies. Il libro… oh God, non sono mai stato un grande lettore… potrei portarmi un libro fotografico, magari. Richiederebbe meno concentrazione. Al cinema vado pochissimo… senti, se ti dicessi tre dischi va bene lo stesso?
Ok, il viaggio è il tuo.
Allora aggiungi Village Green Preservation Society dei Kinks e A Love Supreme di John Coltrane. Ecco, diciamo che così potrei partire felice.
(da Mucchio Extra n.20, inverno 2006)

HUMAN SWITCHBOARD: DALL’OHIO, CON AMORE E CON SQUALLORE.

Avete presente la California? Sole, spiagge, oceano, gente (apparentemente) sana, bionda e bella. Bene, adesso provate a visualizzare il suo esatto opposto: signore e signori, benvenuti a Cleveland. Se è mai esistito un posto che ha fieramente incarnato la definizione di buco di culo degli Stati Uniti – o shithole, per dirla con le parole di quel caso umano con i capelli punk attualmente residente alla Casa Bianca – è proprio la città dell’Ohio a metà degli anni Settanta. Ma la prestigiosa qualifica si potrebbe estendere anche alla vicina Akron: nel complesso, un’area urbana in un tale stato di decadenza da far sembrare le contemporanee Manchester, Liverpool e Sheffield delle amene cittadine rinascimentali. Adagiata su un fiume che ogni tanto si incendia a causa dell’inquinamento e dal quale vengono su cadaveri di pesci avvelenati (immagine che la Radar Records utilizzò per pubblicizzare Datapanik in the Year Zero dei Pere Ubu), sventrata da una ristrutturazione edilizia selvaggia, punteggiata da tralicci in disuso e acciaierie chiuse, popolata di disoccupati per quali il no future è un’opzione tragicamente reale e inevitabile, Cleveland intorno al ’76-77 è una Zona Morta nella quale, come è sempre accaduto da che rock’n’roll è rock’n’roll, non potevano che spuntare meravigliosi fiori marci, rifiuti tossici dai quali estrarre nuova energia pulita (si fa per dire).
A ripensarci, la lista delle band locali che hanno impresso a fuoco il loro marchio sulla storia del punk e del post-punk americano è impressionante, se si considera che posto infame e senza un domani fosse quello. Ci sono ovviamente gli Ubu e la loro ascendenza Rocket from the Tombs, da cui germinano anche i futuri espatriati sulla Bowery newyorkese Dead Boys. Ci sono i Pagans e quei drop out senza speranza degli Electric Eels, ma anche delinquenti oggi dimenticati come Mirrors, Styrene, Chronics, Friction e antesignani come i bizzarri punk-funkers 15-60-75/Number Band. Da Akron, a trenta chilometri di distanza, là “dove il sogno americano finisce”, arrivano invece pesi massimi come Devo e Cramps e pesi piuma come Bizarros e Chi-Pig, senza contare nativi celebri come Chrissie Hynde, Jim Jarmusch (che in gioventù aveva una sua punk band, i Del-Byzanteens) e Robert Quine.
E poi ci sono, esattamente a metà strada tra le due città, gli Human Switchboard.

Due ragazzi e una ragazza. Distanti, almeno in apparenza, dal lercio sotto-mondo che abbiamo appena evocato: per stile, influenze musicali, suono, approccio, abitudini di vita. Eppure totalmente immersi in quell’ambiente, tramite decine di fili intrecciati che ne fanno a pieno titolo dei prime mover della scena dell’Ohio nonché uno dei suoi motori più o meno immobili. La parabola della band non è stata breve, coprendo un arco di tempo che va dal ’77 all’84, ma il nome del “centralino umano” – immagine che avrebbero potuto utilizzare i Devo, pienamente calata in quel contesto di tecnologia putrescente e umanesimo futurista e futuribile – appartiene più all’area del mito che della cronistoria punk/wave. C’è sempre stato un alone sfocato intorno a loro: in parte dipeso dalla scarsità di testimonianze dirette, articoli e interviste – ancora oggi in rete si trova ben poco – e molto da un’eredità discografica non solo smilza ma per lungo tempo pure difficile da reperire, se non a prezzi assurdi. Oggi con un paio di cliccate su Discogs ci si può portare a casa tutti gli Human Switchboard che servono senza dover accendere mutui, ma nei tardi anni Ottanta e primi Novanta un album come Who’s Landing in My Hangar? – per non parlare del bootleg dal vivo, dei singoli 7” e della famigerata cassetta della ROIR intitolata Coffee Break! – rappresentava una sorta di Sacro Graal. Fossero girati di più quei dischi, se una Edsel o una Demon qualsiasi li avesse ristampati quando era ora, sarebbero diventati un punto di riferimento imprescindibile in quel periodo cruciale posteriore agli ultimi fuochi new wave, all’incrocio temporale tra indie americano, garage revival (ah, quel Farfisa! più che un indizio, una pistola fumante) e pre-grunge. Così invece, per chi se li era persi in diretta (quasi tutti), Human Switchboard era semplicemente un nome da bisbigliare con reverenza perché citato da questo o da quell’altro dei protagonisti del rock underground di allora, ma che pochi avevano davvero messo alla prova dell’ascolto. Destino simile a band tipo Mission of Burma o Pylon, per capirsi.
La storia tra Bob Pfeifer e Myrna Marcarian inizia dove spesso iniziano le storie tra un ragazzo e una ragazza americani: al college. E prosegue dove tutte le storie tra un ragazzo e una ragazza dovrebbero proseguire: in una band e in un negozio di dischi. I due si incontrano peraltro lontano dall’Ohio, e precisamente in quella Syracuse University newyorkese frequentata quindici anni prima da Lou Reed e Sterling Morrison. Nomi non del tutto irrilevanti nell’educazione sentimental-musicale di Bob e Myrna, e tutto sommato la coincidenza ha un suo senso. Serendipity, dicono laggiù. Scoccata la scintilla tra il chitarrista dinoccolato di origine slovena e la brunetta di buona famiglia tastierista dilettante, è già ora di tornare nella Cleveland natia e mettere su una band insieme al batterista Ron Metz, vicino di casa di Pfeifer. Neanche il tempo di fare le prime prove in cantina e i tre si trasferiscono al campus della Kent State University per proseguire lì gli studi. Sì, esatto, quella Kent State. L’alma mater immortalata in Ohio di Neil Young, quella in cui sette anni prima la Guardia Nazionale aveva steso a fucilate quattro ragazzi che partecipavano a una manifestazione contro il Vietnam (manifestazione alla quale avevano preso parte anche i futuri Devo Gerald Casale e Mark Mothersbaugh, amici di una delle vittime: altre coincidenze…). Senza aver suonato neanche un concerto in birreria, i tre pubblicano subito un EP, uscito in formato 7”. All’epoca girava così: si andava di corsa. I quattro brani dello Human Switchboard EP (che altre fonti chiamano Fly-In Sessions, titolo che peraltro non appare sulla copertina del disco) vengono registrati con l’aiuto al mixer di papà Ubu, David Thomas. Uno che ha sempre avuto un testone pieno di idee, ma che non è precisamente Phil Spector. Le canzoni dell’EP sono ruvide, secche, delimitate da contorni ben definiti e bordi taglienti. Dilettantesche, ma con stile. Sul lato A Fly-In apre con passo robotico per poi distendersi verso il finale, fornendo nel testo una specie di prontuario per fare breccia nel cuore di una ragazza: poche regolette semplici, cose tipo “tell her she’s your love your dream your everything/ whisper sweet somethings in her ear anytime/don’t go too far/ it’s your first night and it’s’ your first day/ love her like a woman and you know it will be alright”. Più minacciosa e marziale Distemper, che contraddicendo i consigli di bon ton del brano precedente si rivolge con toni abbastanza grevi e lampi di erotismo nevrotico a una lei paragonata a un “jelly roll” e una “bowling ball”, con capelli “that look just right” e “pants a little too tight”. Girato il dischetto, si viene accolti da un “hey!”, una chitarra rockabilly e un giro di Farfisa che sembra preso di peso da Liar Liar dei Castaways. Shake It, Boys è la rivincita femminile sul maschilismo neanche troppo dissimulato del lato A, purissimo rock’n’roll con la voce da ragazzaccia di Myrna Marcarian a dare un tocco di soave innocenza fifties. Ancora le tastierine garage sugli scudi in San Franciscan Nights, ma qui Myrna si limita al controcanto lasciando nuovamente sazio al timbro acidulo da Lou Reed incarognito di Pfeifer, che racconta di nottate californiane passate a cazzeggiare su e giù per Frisco, “wishin I was in some bed in Cleveland” , alla ricerca di una donna qualsiasi ma purtroppo “you make down to Berkeley and find out they all went gay”. Cinismo velvettiano e orgoglio provinciale del Midwest, caratteristiche che la foto in bianco e nero in copertina sembra riassumere in una posa sottoesposta: i tre si nascondono dietro gli occhiali da sole di prammatica, la Marcarian pare una versione più giovane e ancora più asessuata di Moe Tucker mentre Pfeifer e Metz hanno in testa delle coppole che li fanno sembrare due papponi sfigati.

Immagine ripresa, questa volta però disegnata e non fotografica, sulla cover del secondo 7”, inciso nel marzo del ’78 tra un semestre e l’altro alla Kent State. I Gotta Know/No! viene messo su vinile negli studi Suma di Akron e come l’EP esce sotto l’egida della fantomatica Under the Rug Productions, “etichetta” personale del gruppo. L’attacco a passo di rumba di I Gotta Know è un falso segnale, si tratta semplicemente di un’altra asprigna caramella pop-punk doppiata sul retro da uno scaracchio settantasettino che miscela Seeds e Sex Pistols. Neanche il tempo di posare la puntina e i due pezzi sono già finiti, in ossequio al culto della concisione dell’epoca. Tutto molto fast & nice, ma per ora niente che faccia presagire la magnificenza dell’album a venire (per il quale si dovranno aspettare, peraltro, ben tre anni). Siamo sui livelli da catalogo Bomp! minore, e gli Switchboard non paiono avere artigli abbastanza affilati e neppure la cazzimma necessaria per poter fare il salto in avanti come alcuni loro illustri concittadini. Per cui, in quel ’78 che vede The Modern Dance e Q:Are We Not Man? A: We Are Devo diventare instant-classic di una “cosa nuova” che ancora non esiste, Myrna a Bob tornano a Cleveland e aprono un negozio di dischi, attività che li sosterrà economicamente (eh sì: c’è stato un tempo in cui vendere dischi ti sosteneva economicamente) mentre ponderano sul futuro, affinano il suono, scrivono canzoni e – ultimo ma non ultimo – cercano un’etichetta che li faccia uscire dal girone delle auto-produzioni da amatori. Mentre cominciano a suonare al di fuori del perimetro Cleveland/Akron/Kent, spingendosi fino a Hoboken, Boston, Washington e persino nella Grande Mela, dove diventeranno di casa in club come l’Hurrah, incidono un terzo singolo con il contributo della succitata Numbers Band. Prime of My Life, propulsa dai fiati sgangherati dei concittadini, ha un bel tiro swing-punk ma è il retro In My Room, lento ruminare notturno e psichedelico guidato dalle linee vocali sgraziatissime e singultanti di Pfeifer, a rubare la scena. Un pezzo che avrebbe fatto la sua porca figura su Blank Generation di Richard Hell e i suoi Voivoids, per dare l’idea. Si sente che i ragazzi stanno crescendo e che hanno in canna qualcosa di sorprendente, e a captare i segnali prima di chiunque altro, come spesso accadeva in quegli anni, sono oltreoceano le antenne dritte della Rough Trade. L’etichetta di Geoff Travis commissiona un singolo da tre brani, che alla In My Room di cui sopra abbina due pezzi nuovi, Who’s Landing In My Hangar? e I Can Walk Alone. Il singolo per qualche ragione non viene fatto uscire, ma intanto la band, sfruttando il passaparola e i link tra etichette, si accasa presso la Faulty Products, sussidiaria della I.R.S. Ci siamo quasi: è tutto pronto per l’esordio sulla lunga distanza. Alcuni dei brani che ne faranno parte vengono anticipati dalla scaletta del bootleg dal vivo intitolato – viva l’originalità – Livee uscito (si fa per dire: 1000 copie di tiratura semi-clandestina) nel 1980. Per chi volesse farsi un’idea di come fossero sul palco gli Human Switchboard può essere un reperto interessante e su internet si trova facilmente, ma per un’impressione veloce possono bastare anche quei due o tre video su YouTube, con il trio – in realtà quartetto: c’è anche il bassista Steve Calabria – ripreso al Peppermint Lounge nel 1981. L’anno in cui, finalmente, esce il loro primo, e disgraziatamente ultimo, lp.

Siamo nel 1981. E’ iniziato da poco un nuovo decennio, ma già se ne sta rimpiangendo un altro. La nostalgia per i Sixties fa parte del dna di molta musica underground degli Ottanta, ma la sua manifestazione più interessante non è, a ripensarci, quella del puro revival formalistico – benché divertente e per certi versi necessario – che animerà la scena garage-psych dalla metà del decennio in poi. Il vero fascino di quell’unione innaturale tra le aspirazioni di due epoche totalmente agli antipodi stava proprio nei riflessi antichi che lambivano dischi come Who’s Landing in My Hangar? Oppure quelli dei B-52’s. O l’esordio dei Feelies. O saltando dall’altra parte dell’Atlantico la psichedelia riverniciata di Teardrop Explodes e Echo & the Bunnymen. Insomma, ci siamo capiti. Musica calata nel proprio tempo, con tutte le ombre e le inquietudini e i nervi a fior di pelle e la n.o.i.a. di quel periodo, ma con quei fugaci lampi di luce e ottimismo che riportavano a momenti più felici. Bastava un accordo jangle, un giro d’organo, una melodia lineare ed eccoli lì, i convitati di pietra: i formidabili, indimenticabili, fotuttissimi anni Sessanta. Il contrasto che ne scaturiva era irresistibile. Tutti i nomi fatti più su possono essere spesi come riferimenti parlando delle dieci splendide canzoni di Who’s Landing… e molti altri se ne potrebbero citare. Gli inevitabili Velvet, Blondie (sopratutto per quanto riguarda le due canzoni cantate e co-firmate dalla Marcarian, in apertura delle due facciate: (Say No) to Saturday’s Girl e I Can Walk Alone, che nell’attacco di chitarra ricorda in modo assurdamente perfetto una canzone di qualche anno dopo, Looking for Lewis and Clark dei Long Ryders) e forse più di ogni altro i primissimi Modern Lovers. In diversi momenti del disco, tastiere alla Jerry Harrison a parte, viene a galla quella sorta di disperata innocenza che connotava il giovane Jonathan Richman, prima che diventasse un cartone animato vivente. In canzoni come (I Used To) Believe In You, In This Town, Book on Looks, ma in generale in tutto l’album c’è una dialettica costante tra corruzione e rifiuto della stessa, tra ricerca della semplicità e della purezza nei sentimenti e nelle cose della vita contrapposta all’abitudine psicotica – già molto anni Ottanta, in effetti – di complicarsela, la vita. Quello che non c’è è un attimo di respiro. La tensione non cala mai, dall’inizio alla fine, ed è un piccolo miracolo di dinamismo applicato. Nelle note sul retrocopertina, il giornalista e amico della band Tom Carson scrive: “C’è un senso di cose ridotte alla loro essenza, di disperazione da tre del mattino, esacerbata dalla furia e dal divertimento o da entrambi, qualcosa che all’inizio sembra fatalismo ma che in effetti è la più pura, glaciale forma di rabbia rispetto a come vanno le faccende nel mondo. Si può dire di loro la cosa migliore che si possa dire di una band di rock’n’roll: mentre li ascolti, ti sembra di sentire la verità”. Oppure, se non proprio la verità, quantomeno la realtà. I brani di Pfeifer sono uno studio della quotidianità, una lente solo leggermente distorta posata sulle dinamiche di coppia, sugli oggetti che ci circondano, sulle imperfezioni della vita di ogni giorno. Un approccio minimalista che tuttavia diventa strumento di riflessione su questioni più grandi e universali, e in questo si può istituire un collegamento con un altro trio formato da due uomini e una donna, musicalmente lontanissimi ma tematicamente affini: gli Young Marble Giant. Esiste qualcosa di più – ehm – new wave di questo? E tutto ciò si concentra nel punto focale – e capolavoro – dell’album: Refrigerator Door. Kurt Cobain, uno dei mammasantissima che hanno dichiarato il loro amore per gli Human Switchboard (altri iscritti al club: Mark Lanegan, Chris Cornell, Elvis Costello e i Beastie Boys) l’aveva definita “la Stairway to Heaven del punk”. Qualcuno non lo vedrà esattamente come un complimento, ma sostituendo il misticismo fricchettone con la nevrosi suburbana, e la Terra di Mezzo con un monolocale puzzolente della periferia di Cleveland, ci può stare. In un bellissimo articolo sugli Human Switchboard (uno dei pochi rintracciabili in rete), il critico Michael Baker descrive così la canzone, utilizzando immagini stranamente simili a quelle di Carson: “sette minuti e mezzo che introducono a un mondo di amore e freddezza, di transitorietà e momenti di indecisione, di aspettative infrante e promesse non mantenute. Musica che racconta di rotture sentimentali e bar squallidi e vecchio giornali e sigarette fumate alle quattro del mattino”. Tensione che monta lentamente, di nuovo, ma senza rilascio. Le due voci di Pfeifer e Marcarian sviluppano una conversazione intima che a un certo punto si avvita su se stessa e parte per la tangente della non-comunicazione assoluta, con gli “uh la la la la” di Myrna che contrappuntano in modo surreale le frasi in sloveno di Bob, nelle quali si intravede addirittura il fantasma di Psycho Killer dei Talking Heads.
Who’s Landing in My Hangar? è un UFO che attraverso il cielo dei primi anni Ottanta, lasciando una scia luminosissima e andando a schiantarsi da qualche parte nell’oceano. La vicenda degli Human Switchboard durerà ancora tre anni, ma non ci sarà un seguito su vinile. Ce ne sarà, tutt’al più, uno su nastro: la ROIR, etichetta specializzata in reperti punk-wave su cassetta (un titolo su tutti. il celeberrimo The Blow-Up dei Television) farà uscire nell’82 Coffee Break!, registrazione di un concerto tenuto all’Agora di Cleveland nell’autunno dell’anno precedente. Testimonianza interessante più che per la performance della band (la qualità sonora deficitaria non aiuta, in questo caso) per la presenza in scaletta di alcune canzoni inedite. Così come inedite sono una manciata di tracce sull’antologia Whos’ Landing in My Hangar- Anthology 1977-1984 (Bar-None, 2011), a oggi il tentativo migliore di sintetizzare su cd la storia degli Human Switchboard. Si tratta di incisioni fatte nell’83-84 in previsione di un disco per la Polydor, ovviamente abortito. Indicazioni preziose di come avrebbe potuto essere un secondo album della band, tra divagazioni country (Always Lonely For You), tentazioni funk (I’m Your Temptation), eccellenti esercizi pop (A Lot of Things). Si intravede persino un certo potenziale radiofonico che chissà, avrebbe potuto lanciare la band nella zona di confine tra l’underground e il maistream, magari sulla scia dei R.E.M. e gruppi simili. Ma il tempo ormai è scaduto: too little, too late. La parabola degli Human Switchboard si conclude a metà decennio, e poco si saprà delle successive esperienze dei tre. Pfeifer e la Marcarian in qualche modo rimarranno nell’ambito musicale, ma senza lasciare tracce significative. Tutta la loro storia, tutto quello che avevano da dire, è in quella manciata di canzoni che a distanza di quarant’anni bruciano ancora di vita, di gioventù, di urgenza. Canzoni che fiammeggiano sul crinale del tempo, come il fiume Cuyahoga nelle notti di Cleveland.

THE ARTIST FORMERLY KNOWN AS ANTICHRIST – Intervista a John Lydon (da Il Mucchio, luglio 2012)

John Lydon, ovvero l’intervista che non s’aveva da fare. Contrariamente a ciò che si può pensare, non per mancanza di disponibilità dell’intervistato. Tutt’altro. Dopo che vari contrattempi, abbastanza comici, hanno fatto slittare di un mese il nostro slot con mister PIL, il giorno prima del nuovo appuntamento telefonico ci viene chiesto di rimandare ancora di ventiquattr’ore. John ha un appuntamento con il dentista. Il dentista? John Lydon?? Siamo al trionfo del surreale: un po’ come sentirsi dire “Burzum oggi non può, deve andare a messa”.
Finalmente, il giorno dopo sentiamo esplodere nel ricevitore la voce meravigliosamente british – anzi: brrrrritish – dell’uomo che sosteneva di essere un anticristo. Il tono è sorprendentemente allegro anche se ogni tanto la dizione si fa rallentata (saranno gli effetti dell’anestesia). “Hallo, hallo-hallo-hallo, this is John Lydon speaking”. Giusto il tempo di chiedergli dove si trova – si avverte il rumore di un elicottero sullo sfondo – e di sorridere per la risposta (“Sono in spiaggia, a Malibu, questa che senti è la cazzo di polizia che gira”) che ovviamente cade la comunicazione. Capiterà quasi una decina di volte nei quarantacinque minuti di conversazione. Ogni volta penso “ok, è finita, adesso risponde con un fuck off e ciao”. E invece dopo ogni squillo John riprende a parlare imperturbabile, chiedendo alla fine con una gentilezza insospettabile se la risposta è chiara. Toh, guarda, pensavo di dover parlare con l’uomo più cattivo nella storia della musica e invece eccoti uno zio simpatico e un po’ sbiellato. Punk is dead, definitivamente. Naturalmente questo sarebbe il genere di considerazioni che lo farebbe incazzare a morte, per cui mi guardo bene dall’azzardare qualunque riferimento al ‘77, a McLaren, al nuovo giubileo della Regina (la tentazione è stata forte, però) e al solito rosario di luoghi comuni che l’ex Johnny Rotten ispira. D’altra parte, sarebbe anche piuttosto stupido. C’è un nuovo album dei PIL di cui parlare, un disco godibile e solidissimo del quale il suo autore è giustamente orgoglioso.
“È stato un divertimento totale, fare questo disco. Gioia pura. Cinque-sei settimane in studio, cercando di ottenere il suono più live possibile. Niente trucchi e sovra-incisioni. La mia voce è quella che senti nel disco, non c’è nessuna manipolazione. Canto in studio come canto dal vivo. Perché è questo che siamo oggi: vivi. Tutti credevano che i Pil fossero una storia sepolta, e invece eccoci qua, ladies and gentleman. E tutto quello che ti diciamo è vero, non c’è finzione”. Questo della “verità”, e dell’onestà nel presentare se stessi e il proprio prodotto (termine una volta molto caro a Lydon), è un tormentone che ricorre nelle risposte. Tiene moltissimo a sottolineare la trasparenza assoluta del suo rapportarsi al pubblico, il fatto di non mettersi su un piedestallo. Chiunque altro, nello showbiz e non solo, secondo Lydon è finto, ipocrita, phony. Usa talmente spesso quell’aggettivo che a un certo punto mi sembra di parlare con Holden Caulfield. E non ho mai trovato un musicista che ripetesse con così tanta insistenza la parola “valori”. “L’ho detto e lo confermo: i PIL sono i vostri unici amici nel mondo dello spettacolo. Perché sono umani. Perché non vogliono fregarti. Io non potrei mai truffare il mio pubblico, lo amo. Chiunque altro mente, tutti preferiscono l’immagine al contenuto. Phony artists, phony human beings. Io non ti vendo una falsa attitudine, non mi faccio propaganda come fossi una divinità secondaria. Sono uno di voi. Le mie canzoni parlano di ciò che condividiamo tutti quanti: la natura umana”. Per essere sicuro che capisca il concetto, mi fa anche lo spelling: h-u-m-a-n n-a-t-u-r-e.

In questo senso, dunque, si spiega anche l’inedita vulnerabilità mostrata in alcune canzoni, per esempio The Room I Am In. “Vulnerabilità, certo. Come tutti anch’io ho vissuto situazioni disperate, quando hai bisogno di attaccarti a qualcosa per non impazzire. Come quella da cui prende spunto quella canzone. Mi riferisco a quando ero in terapia di disintossicazione (non specifica da quale droga, NdI). Mi trovavo in una camera chiusa senza finestre. Desolazione assoluta. Chiusura totale verso l’esterno, e allo stesso tempo l’impulso di rompere la barriera. Un momento terribile, ma da quell’inferno se ne esce. Vedi, io voglio trasmettere quest’idea, che non ci si deve arrendere agli impulsi suicidi e alla disperazione. Sono John, un essere umano, e voglio condividere un’esperienza, non parlarti di cazzate su automobili e ragazze o della pace nel mondo”. Gli chiedo se un brano come Deeper Water tratta dello stesso argomento. “Certo. È un altro invito a trovare dentro di te la chiave per risolvere i tuoi problemi. Si deve imparare a nuotare contro la corrente: è un modo più intelligente per restare a galla, quando hai paura di annegare. Molto meglio che seguire i consigli di chi hai intorno, che ti manderebbero dritto a sfracellarti sugli scogli”. Quando si vuole trasmettere senza mediazioni la propria esperienza, come rimarca continuamente Lydon, l’autobiografismo diventa quasi inevitabile. E nei testi di This-Is Pil ce n’è parecchio. Soprattutto ricordi della Londra di quando il musicista era ragazzo – “My name is John, I come from London” è un verso che ricorre nel disco- a tratti dipinta con tonalità quasi nostalgiche. In Inghilterra più di un critico ha fatto dell’ironia su questa vena malinconico-patriottica, sottolineando velenosamente il fatto che Lydon vive da anni in California. “E quindi? Non posso parlare della mia città, o del mio paese? Sono nato e cresciuto a Londra. Devo forse negarlo? Lì sono le mie radici culturali, la mia famiglia, tutti i miei valori. Devo forse nasconderli, perché a qualche snob del Guardian dà fastidio? Chi dice queste cose è un idiota. Io parlo del cuore, e dico le cose come stanno. Sempre”.

Mi piace un sacco, gli dico, quando rimembri i tempi in cui il calcio “non faceva sbadigliare”. Sempre tifoso dell’Arsenal? “I’m recovering! (ride, NdI). Brutta annata, ma sì, sono sempre un supporter dei gunners. Il calcio oggi è diventato noioso perché sono noiosi i calciatori. Una volta li incontravi nel pub sotto casa, vivevano nella tua stessa dimensione sociale. Oggi hai questi robot miliardari con le sopracciglia rifatte che sgommano sulle loro Ferrari, non puoi avere un rapporto con loro. Quando ero ragazzo i calciatori si impegnavano di più perché potevi prenderli a calci in culo quando li vedevi per strada, ah ah ah”. Rimanendo in ambito sportivo, è vero che hai rifiutato l’invito a esibirti durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi con i Sex Pistols? “Ascolta, il mio gruppo sono i PIL adesso, non i Sex Pistols. Non capisco perché mi chiedano di fare delle cose con un gruppo che non è il mio. Mi avessero chiesto di andarci con i PIL, avrei detto sì, senza nessun dubbio. Anche se odio questo genere di celebrazioni, e penso che le Olimpiadi dovrebbero tenersi sempre in Grecia. Lì sono nate e lì devono rimanere”.
Dopo l’ennesima caduta della linea, ed aver subito l’unica frecciata di sarcasmo lydoniano (“you better adjust your spanish phone”, evidentemente per lui tutti quelli che stanno a sud di Brixton sono la stessa cosa), provo a indagare sui suoi gusti musicali attuali. Dub e reggae sono sempre grandi passioni? E l’hip hop, del quale un pezzo come Lollipop Opera sembra dare una versione quasi dadaista? “No, non ascolto più quel genere di cose. Mi hanno stufato anni fa, non ho più tempo per quella roba. Quello che non mi piace di quelle musiche, oggi, è che dipendono troppo dalle macchine. Hanno perso il contatto con la naturalità del suono, che è quello che cerco con i PIL. Usiamo anche noi un sacco di computer e di aggeggi elettronici, ovvio, ma siamo analogici nello spirito e nei risultati. Non ci facciamo dominare dalla tecnologia. L’hip hop l’ho esplorato quando ho lavorato con Afrika Bambaataa nell’84, con il progetto Timezone. Ero in anticipo su tutti. Adesso non me ne importa più niente. E comunque Lollipop Opera non c’entra con l’hip hop, è tutta un’altra cosa. Una roba tipo il primo ska mischiato a musica folk turca, ma in un contesto irlandese. Se ascolti bene ci trovi quel tipo di progressioni mediorientali, la ritmica caraibica, le cantilene da ubriaconi al pub…la musica che mi piace è quella che mischia influenze diverse, magari senza neanche volerlo fare intenzionalmente. È quella la musica che sentivo a Finsbury Park quando ero piccolo, non il merdoso rock’n’roll. Sono cresciuto in un quartiere cento per cento working class, pieno di emigrati di ogni parte del mondo. Passeggiavi per la strada e sentivi tutti ‘sti suoni fenomenali venir fuori dalle finestre, era una sensazione fantastica. Oggi tutti parlano di multiculturalità, ma io l’ho conosciuta già da bambino a Finsbury Park, era già tutto lì. Venir su in un posto così ha definito il mio sistema di valori. Lollipop Opera è un tentativo di acchiappare l’innocenza dell’infanzia. L’hai definita ‘dadaista’ e mi piace, in fondo i dadaisti cercavano di ottenere lo stesso effetto”.
Rimanendo sul tema della musica, il discorso scivola sul modo di ascoltarla. I PIL hanno fatto uscire un EP (One Drop) in edizione limitata per il Record Store Day, quindi viene da pensare che la possibile scomparsa del formato fisico sia un argomento che sta parecchio a cuore al vecchio iconoclasta. “Io amo il vinile. Lo adoro. Non è solo il modo migliore per sentire la musica. È l’unico. Tutti gli altri sono un surrogato, dal cd allo schifoso mp3. Ho cominciato ad appassionarmi alla musica con il vinile, e non ho mai smesso di comprarlo. Anche quello fa parte della mia esperienza di vita. L’unica riproduzione fedele del suono ce l’hai in quel modo, lo sa ogni dj e lo sa ogni vero amante della musica. I ragazzi di oggi entrano in contatto con la musica solo tramite Internet, non sono consapevoli della limitazione del segnale sonoro perché non hanno sviluppato una sensibilità adeguata. Non sanno quanto si perdono. Se lo sapessero, raderebbero al suolo le case discografiche che hanno provocato tutto ciò, quando hanno deciso di buttare a mare il vinile negli anni Ottanta”.

A proposito di rabbia giovanile, racconto a John di quanto sono rimasto impressionato, vedendo dal vivo i PIL a Barcellona lo scorso anno, dal modo in cui un pubblico di ventenni o poco più cantava il celeberrimo slogan di Rise. Quell’”anger is an energy” dieci o quindici anni fa non sarebbe risuonato così convinto, e così minaccioso. “Il sentimento evocato in quella canzone è radicato in ogni cultura. C’è un momento in cui la rabbia diventa l’unica forza che hai a disposizione, l’unica tua risorsa di energia. E allora devi trattenerla, non disperderla. Potrà esserti utile. Rise è una canzone che parla di ribellione e forse sì, in questo momento ha ancora più senso. Ero contento di vedere che quei ragazzi se la ricordassero, significa che i PIL hanno ancora un grande potere (risata, NdI)”. Quello contrattuale di sicuro. Considerando soprattutto che un contratto non ce l’hanno. “Finalmente! È il modo migliore per stare nel business. Indipendenza assoluta. Quando ho iniziato con i PIL ero ancora sotto il contratto che avevo dovuto accettare con i Sex Pistols, un contratto che non avevo negoziato e che mi è pesato addosso come un macigno per troppi anni. Quello che mi ero messo a fare con il gruppo era molto diverso da ciò che si aspettava la casa discografica. Eravamo in uno stato di guerra continua. Dovevo pagare per ogni cosa, e nonostante questo non mi lasciavano libero di andarmene. Ho dovuto imparare a essere paziente. Alla fine ho vinto, e oggi sono un free agent!” La libertà e l’indipendenza hanno un costo, però. E per finanziare il ritorno dei PIL, Lydon ha accettato di buon grado di comparire in programmi trash e nel commercial (strepitoso) per una marca di burro. Quando gli dico che è il testimonial che tutti i pubblicitari sognerebbero, ride come un matto: “Quello spot è la cosa più divertente che abbia mai fatto in vita mia, con le persone più corrette e rispettose che abbia mai incontrato. Altro che la gentaglia del mondo discografico. Amo i pubblicitari, amo anche i loro contabili e i loro avvocati, ah ah ah. È stato un progetto in cui mi sono impegnato al cento per cento, sapendo che i soldi che mi davano sarebbero finiti nei PIL. E poi mi piaceva l’idea di propagandare un prodotto davvero britannico. Se i danesi sono orgogliosi del loro burro del cazzo, perché non dovremmo esserlo anche noi?”.
Prima di salutarlo, cade per l’ultima volta la linea. Quando lo richiamo per ringraziarlo della pazienza, mi dice: “No problem. I deeply respect your resilience”. Credo che mi farò tatuare questa frase su un braccio.

VASHTI BUNYAN. SOLO UN ALTRO GIORNO DI DIAMANTE
Vashti Bunyan fino a cinque anni fa era un personaggio avvolto nelle brume nella leggenda. Poi, grazie alla ristampa del suo mitizzato capolavoro Just Another Diamond Day (del 1970) e all’amicizia con Devendra Banhart, è diventata un nome di culto. Lookaftering è il suo secondo disco, trentacinque anni dopo.

Mentre i sussurri eterei della Bunyan venticinquenne fanno da sottofondo all’intervista, la stessa voce con trentacinque anni in più – ma con una grazia e un fascino immutati – non fa che scusarsi per l’ora non proprio usuale (mezzanotte) nella quale si svolge la conversazione.
Nessun problema, anzi mi sembra il momento migliore della giornata per parlare della sua musica. In fondo lei è un personaggio che ha qualcosa di notturno, per non dire arcano. A partire da quel fantastico nome che si ritrova.
Lo devo alla passione dei miei genitori per i testi sacri. Vashti era una regina citata nel Vecchio Testamento. Bunyan invece è un cognome inglesissimo. Hai mai sentito parlare di John Bunyan (scrittore secentesco, autore de Il viaggio del pellegrino, uno dei capolavori della letteratura religiosa inglese, NdI)? Beh, è un mio antenato. O almeno così mi hanno sempre raccontato.
Quindi la vocazione artistica è una prerogativa di famiglia.
Un po’ alla lontana, forse (risate, NdI). Mio padre era dentista, mia madre era un’eccellente pianista che si è ritrovata a fare la casalinga abbandonando presto il sogno di una carriera musicale. Quando ero ragazza, pensavo che avrei fatto di tutto per evitare un destino simile. Giuravo a me stessa che non mi sarei mai fatta incatenare dalla vita famigliare, avrei seguito la mia musa a qualunque costo. E invece, la mia unica attività negli ultimi trentacinque anni è stato proprio la madre di famiglia. Dal 1970 in poi non ho più scritto una canzone, sfiorato una chitarra, cantato una nota. Non ho neppure ascoltato la radio o comprato dei dischi. Niente di niente. Ho cresciuto i miei tre figli, che neppure sapevano di avere una
mamma con un passato da cantante pop. A dire il vero, non me ne ricordavo neanche più io. Quella Vashti Bunyan era un’altra persona, che avevo eliminato e nascosto in cantina (ride, NdI). Per quasi trent’anni non ho voluto neanche ammettere che fosse mai esistita.
Fino a quando…
Fino a quando nel 1997 ho avuto la mia prima connessione a Internet. Sempre sia benedetta, la Rete! Per curiosità ho provato, come fanno tutti, a digitare il mio nome su un motore di ricerca. Sono rimasta di sasso quando ho scoperto il culto che circondava quelle canzoni che avevo scritto tanti anni prima. Non potevo crederci: c’era gente che offriva 900 sterline per una copia in vinile di Just Another Diamond Day! Per la prima volta ho pensato che forse c’era qualcosa di buono in ciò che avevo fatto all’epoca, e che io invece avevo odiato per così tanto tempo. Forse erano canzoni che meritavano di essere conosciute
da qualche persona in più dei cento pazzi -anzi, probabilmente erano anche meno – che avevano comprato il disco all’epoca dell’uscita. Così ho provato a cercare un’etichetta interessata a ristamparlo. Scoprire che là fuori c’erano così tante persone interessate alla mia musica è stata un’esperienza davvero formidabile, quasi come nascere una seconda volta.

Quindi fu soprattutto l’insuccesso di Just Another Diamond Day a farle abbandonare la carriera musicale?
Chiamarlo insuccesso è un eufemismo. Non è che lo ascoltarono in pochi. Non lo ascoltò nessuno. Il rifiuto del pubblico a quel punto divenne il mio rifiuto. Se nessuno aveva apprezzato il mio lavoro, quello era il segno che non valeva nulla. Non ero il tipo di artista capace di raccogliere le sfide. Ero insicura, sola, e con scarsissima fiducia nei miei mezzi. Sarebbe bastata anche un solo giudizio positivo, un piccolo incoraggiamento, e forse avrei potuto insistere. Ma non ci fu. Mi convinsi di essere un fallimento, e così mi arresi. Mollai tutto e andai a vivere in una fattoria.
Doveva avere degli standard qualitativi davvero altissimi, nel giudicare il suo lavoro. Oggi quell’album è considerato un classico del folk britannico e tra i cento dischi inglesi più belli di ogni tempo. Ha cambiato la sua opinione al riguardo?
Sì, ora posso finalmente ascoltarlo con le orecchie di altre persone, posso valutarlo attraverso le loro sensazioni. Puoi immaginare come mi sono sentita quando un giovane artista con il talento, la grazia, il coraggio di Devendra Banhart è venuto a cercarmi per dirmi che l’ascolto di Just Another Diamond Day è stata la molla che lo ha spinto a tentare l’avventura da musicista. Ma nel 1970 non c’era Devendra, o chiunque altro, a dirmi quanto erano importanti per lui quelle canzoni. Non sono comunque così sicura che sia, come hai detto tu, un “classico del folk”. Principalmente perché non mi sono mai ritenuta una
cantante folk!
Eppure i brani parlano proprio con quella lingua antica, il suo stesso modo di cantare ha le cadenze della ballata popolare...
Non ero interessata al recupero della tradizione di per sé. Ciò che mi piaceva del folk era la semplicità delle melodie e delle strutture musicali, non mi interessavano più di tanto gli argomenti classici delle folk-ballad. La mia ambizione era trasportare quella naturalezza fanciullesca nel pop, così come aveva fatto Donovan. Che, lo ammetto, è sempre stato il mio idolo.

A proposito di Donovan, è vero che c’entrava con la sua decisione di mettersi in viaggio per l’Inghilterra con un carretto trainato da un cavallo? Ci racconti come andarono le cose.
Nel ’68 la mia carriera non stava andando da nessuna parte, avevo inciso un paio di singoli per Andrew Loog Oldham ma iniziavo a pensare di non avere un futuro nel mondo del pop. Il mondo che mi circondava era sempre più caotico e violento, c’era il Vietnam e un sacco di altri orrori che non capivo e non accettavo. Volevo scappare via, come tanti altri della mia generazione. Mentre i miei amici partivano per l’India o il Marocco, io sono andata a cercare il paradiso in Scozia, e questo già ti dice quanto fossi assurda anche come hippie (risate, NdI). Allora stavo con Robert Lewis, uno studente amico di Donovan. Quest’ultimo stava mettendo su una comune di artisti sull’isola di Skye, e invitò Robert a raggiungerlo. Ci
regalò un centinaio di sterline, e con quelle ci siamo comprati un carro da panettiere e un cavallo. Il mezzo di trasporto più ecologico che si potesse immaginare! Con quello siamo partiti alla volta di Skye, ma per raggiungerla ci abbiamo messo quasi due anni. Ci spostavamo sulle statali, in piena Inghilterra industriale, con i camion che rischiavano di buttarci fuori strada e senza mai trovare un prato per il cavallo. Sembrerebbe un’esperienza bucolica, ma per la maggior parte del viaggio non lo fu affatto. In pratica eravamo degli homeless: ci sostentavamo facendo qualche lavoretto da artigiani, ma ti assicuro che fu durissima. E quando poi arrivammo finalmente sull’isola, scoprimmo che Donovan era appena partito per l’America. Addio comune. Nel frattempo, comunque, avevo scritto tutti i brani di Just Another Diamond Day.
Sulla ristampa del disco ce n’è uno magnifico che non faceva parte della scaletta originaria, I’d Like To Walk Around In Your Mind. A forza di ascoltarla, è diventata una specie di ossessione personale: credo sia una delle più delicate, elusive dichiarazioni d’amore nella storia del pop inglese. Una canzone perfetta, soprattutto la strofa che recita” I’d like you to be unaware/then I just wander away trailing palm leaves behind me/ so you don’t even know that I’ve been there”.
Era un demo di un pezzo che avrei dovuto incidere per la Immediate nel 1967. Buffo che tu mi citi proprio quella strofa, perché descrive perfettamente la mia attitudine nei confronti del mondo musicale. Che infatti, non si era neanche accorto che io fossi là intorno.
In compenso, c’è una nuova generazione che la ha eletta a musa e fa la fila per suonare con lei.
Come si sente, circondata dall’affetto di questi neo-freak?
Un sensazione meravigliosa. Sono le persone che avrei voluto avere intorno trentacinque anni fa, quegli spiriti affini che ho sempre cercato. Joanna Newsom, adorabile ragazza, che è venuta a cantare nel mio disco mentre era in tour in Scozia, quei matti degli Animal Collective che mi hanno obbligato a usare la mia voce in un modo che non immaginavo neanche, Glen Johnson dei Piano Magic, Andy Cabic, il mio arrangiatore e produttore Max Richter. E poi Devendra, per il quale non ci sono parole. Un altro personaggio a cui devo molto è Stephen Malkmus, che due anni fa volle a tutti i costi che mi esibissi durante un festival organizzato da lui alla Royal Festival Hall di Londra. Era la prima volta dal 1969,
tremavo come una foglia e non riconoscevo neanche la mia voce.
Si sente pronta per un tour?
Sì, ho molta voglia di suonare dal vivo, e ti confesso che mi piacerebbe poter fare qualche concerto in Italia.
Verrà con un carro a cavalli?
Ah ah, non credo proprio. Quei tempi sono molto, molto lontani. Ma almeno oggi posso tornare a guardarli con distacco, e confessare a me stessa che in fondo me li porto ancora nel cuore.

(dal Mucchio Selvaggio, dicembre 2005)
ELLIOTT SMITH. Lettere da nessun luogo.

Quando si apprese la notizia della morte di Elliott Smith, a tutti coloro che avevano amato la sua musica è probabilmente venuto in mente un frammento di canzone, un giro di chitarra, una frase, un’immagine. Qualsiasi cosa facesse dimenticare anche solo per un secondo l’idea agghiacciante di un uomo che si era appena tirato (o gli era stata inferta, non è ancora stato stabilito ma in fondo poco importa) una coltellata al cuore. A chi scrive queste righe, in quel momento tornarono alla memoria tre flash: tra le tante emozioni donategli da Elliott Smith forse quelle che più ne hanno toccato l’anima. Una sequenza del film Royal Tenenbaum, quando il protagonista Luke Wilson si taglia le vene davanti allo specchio del bagno e in sottofondo parte, inaspettata e straziante, Needle In The Hay; l’attacco di Waltz #2, quella strofa che recita “first the mic and a half cigarette / singing Cathy’s Clown / that’s the man she is married to now / that’s the girl that he takes around town” (che frase bellissima e misteriosa! chi è che canta al microfono? e perché proprio quel vecchio pezzo degli Everly Brothers?); infine, una dichiarazione letta in un’intervista qualche anno prima, dove Elliott diceva “se riuscissi a scrivere una canzone perfetta come Thirteen dei Big Star, potrei morire felice”. Sono solo tre ricordi personali, ognuno avrà avuto i suoi com’è giusto che sia nel caso di artisti capaci di colpire così profondamente le sensibilità più diverse. Eppure adesso, dovendo tracciare uno stringatissimo sunto della vita breve e infelice di colui che non ho alcuna difficoltà a considerare uno dei più grandi cantautori della mia generazione (era nato con il nome di Steven Paul Smith il 6 agosto del ’69, più o meno nei giorni di Woodstock, a Omaha, Nebraska) mi sembrano dei buoni punti di partenza. Soprattutto i primi due. Nella loro casualità, Introducono ad alcuni dei tratti salienti della biografia di Smith. Il malessere disperato di Needle In The Hay, dipinto però con ironica autocommiserazione e uno straordinario gusto per il dettaglio, dice dei suoi anni da junkie, tra eroina e bottiglia. Allo stesso tempo è un esempio della tecnica con cui, liricamente, Smith raccontava se stesso nelle canzoni, con tanta efficacia poetica quanta era la distanza da cui incredibilmente riusciva a osservare i suoi inferni privati, mentre il fatto che quella canzone commentasse la scena di un film permette di accennare al rapporto di Elliot con il cinema. D’ora in avanti sarà impossibile, quando si rivedrà quella meraviglia di film che è American Beauty, Trattenere la commozione ascoltando la sua versione di Because dei Beatles sui titoli di coda. Così come assumerà tutta un’altra pregnanza quella Miss Misery che, insieme ad altri brani di Smith, faceva da colonna sonora a Good Will Hunting, la pellicola dell’amico Gus Van Sant interpretata da Matt Damon e Robin Williams. Una Miss Misery che si è trasformata per incanto in una Mrs. Robinson, tanto per citare uno dei numi tutelari del songwriting smithiano. A quella canzone, infatti, è legato il momento di massima esposizione del Nostro, visto che nel 1997 gli procurò una nomination all’Oscar con tanto di esibizione surreale la notte degli Award al Dorothy Chandler Pavillion di Hollywood. Ancora oggi qualche membro parruccone dell’Academy si chiede chi fosse quel freak in giacca bianca che strimpellò mezzo ubriaco prima di Celine Dion (che, per la cronaca, vinse la statuetta con l’angosciante tormentone di Titanic). In quel periodo, la vita e la carriera di Smith stavano correndo velocissime, anche se purtroppo in direzioni opposte. La critica rock, presa in contropiede dalla storia dell’Oscar, si era finalmente accorta di lui coprendo di elogi (strameritati) il suo terzo album Either/Or. A ruota, era arrivato un contratto con la DreamWorks, la nuova super-major che aveva nel board di comando nientemeno che Steven Spielberg. Contemporaneamente, però, era riemersa la dipendenza da alcol e droga che andava ad aggravare la già patologica insicurezza dell’artista, combinandosi per di più con i postumi dei trattamenti psichiatrici degli anni precedenti (evocati poi in modo raggelante in Everybody Cares, Everybody Understands su XO: “it’s a chemical embrace that kicks you in the head / To a pure synthetic sympathy that infuriates you totally) e ai disastri sentimentali (la fine della storia con la musicista Joanna Bolmc, forse l’unico vero amore nella vita di Smith, la “ragazza che mi sta ancora intorno il mattino dopo” rimpianta in quell’abisso di struggimento intitolato Say Yes).
Le radici della sofferenza di Smith affondano del resto negli anni dell’infanzia, ed ecco che torniamo alla strofa di Waltz #2. Grazie a una dettagliatissima biografia sul sito semi-ufficiale sweetadeline.net ho finalmente scoperto chi è quella donna che cantava Cathy’s Clown: è la madre di Smith, ricordata in una esibizione improvvisata in un karaoke bar di Dallas, dove si era trasferita con il figlio dopo il divorzio dal marito. “L’uomo a cui è sposata adesso” della canzone è il patrigno di Elliott, figura odiatissima nella quale il musicista in varie interviste (e più velatamente, in alcuni testi) individua la fonte di molto del dolore che lo accompagnerà tutta la vita. Per sfuggire alla opprimente situazione familiare, il teenager nel frattempo diventato punk si rifugia a metà degli anni ’80 dal padre a Portland. Qui studia filosofia e scienze politiche al college, ma soprattutto forma una band con altri spostati del luogo. Si chiamano Heatmiser. Con loro incide, tra il ’93 e il ’96, tre album di rock sporco e arruffato, del tutto incapace di concedere il giusto spazio al fascino ombroso dei testi di Smith. Sentendosi compresso dalla formula post-grunge imposta da Neil Gust, l’altro leader, alla fine del ’94 Elliot decide di giocare da solo. Rimane nella band, che si scioglie ufficialmente solo un paio di anni dopo, ma pubblica per la minuscola Cavity Search Records un album a suo nome intitolato Roman Candle, seguito nel ’95 da Elliott Smith per la Kill Rock Stars. Sono dischi fatti di niente, se non parole spesse e corde di chitarra pizzicate (non sorprenda sapere che Smith era un grande appassionato di flamenco), carezzate o percosse a seconda dei casi. Un folk a bassissima fedeltà che tuttavia, nonostante i tratti scheletrici, taglia in profondità con le sue storie dai margini, le sue istantanee di “drugstore cowboy”, tossici, sociopatici e perdenti vari. Tutta gente conosciuta da Elliott Smith, oppure tanti Elliott Smith diversi, chi lo sa.
L’abbandono e il mal di vivere espressi attraverso la pura gioia della melodia, le strutture classicamente pop (da Brian Wilson a Paul Simon, da Harry Nillson ai Beatles, in particolare quelli versante Harrison) al servizio dei propri demoni: questa la prometeica sfida intrapresa da Elliott Smith. Non poteva durare, perché non esiste melodia pop in grado di trattenere i demoni. Elliott Smith avrebbe dovuto suonare al festival All Tomorrow Parties il 9 novembre del 2003; saranno invece amici come Lou Barlow, Beth Orton e Beck a salutarlo, due settimane dopo la tragedia, salendo sul palco di un teatro di Los Angeles per un benefit i cui proventi andranno alla fondazione per i bambini vittime di violenza, intitolata alla memoria del musicista di Omaha. Non crediamo che sia morto felice, Elliott Smith. Ma, per tornare al terzo ricordo personale di quel maledetto 21 ottobre 2003, almeno quel suo piccolo obbiettivo musicale – scrivere un brano perfetto come Thirteen – lo aveva raggiunto, più di una volta. E lo scrive uno per cui Thirteen è la canzone della vita.

(pubblicato originariamente sul “Mucchio”, autunno 2004)
GENIUS & LOVE – Yo la Tengo per noi.

L’ultimo dei sei o sette concerti che ho visto degli Yo la Tengo risale a cinque anni fa, e non lo dimenticherò mai. Non per il concerto in sé – bello, anche perché un live degli Yo la Tengo lo è ontologicamente, ma non più che in altre occasioni – quanto per quello che è successo dopo. La data era a Milano, e per un torinese fan all’ultimo stadio dei ragazzi e ragazza del New Jersey cosa vuoi che siano due orette di auto andata e ritorno? Tanto, pensavo, in questa stagione mica ci sarà la nebbia.
Infatti.
Appena lasciatisi alle spalle la capitale morale dopo il concerto, praticamente siamo entrati in Avalon. Già tanto che riuscissi a vedere il volante. Per colmo di sfiga, a un certo punto scoprimmo che l’autostrada era chiusa e di colpo io e i miei compagni di viaggio ci ritrovammo nella twilight zone da qualche parte tra Novara e Vercelli, visibilità a mezzo centimetro, bestemmie in svariate lingue morte e la speranza di essere rapiti dagli alieni pur di togliersi da lì. Nei miei incubi ogni tanto mi appare ancora il cartello indicatore al bivio di una stradina secondaria: GHEMME-ROMAGNANO. Pensai che quella fosse la sliding door definitiva. Cosa sono Ghemme e Romagnano? Esistono davvero? Dove girare? A destra c’era la morte per fame, a sinistra quella per assideramento. In ogni caso, ci avrebbero trovato in estate.
Invece, incredibilmente, alle sei del mattino facemmo il nostro trionfale ingresso a Torino sulle note di Stockholm Syndrome e con un unico pensiero in testa: ”mai più”. La cosa divertente fu tuttavia scoprire il giorno dopo, rimbalzando tra Facebook e sms, che avevamo vissuto in parecchi la stessa terrificante esperienza, che ci raccontavamo reciprocamente con il tono dei reduci dell’ARMIR. Maurizio Blatto ne ha tratto anche un capitolo formidabile nel suo libro My Tunes: in quel caso compaiono anche poliziotti della stradale, volpi e camionisti probabili serial killer. La morale del racconto, comunque, era: una cosa del genere, solo per gli Yo la Tengo. E io non potrei essere più d’accordo.
Perché il trio di Hoboken non è solo una band del cuore: in qualche modo, loro sono la parte migliore di noi. Quella che nel suo modo goffo e tenerissimo incarna, per dirla con il Kevin Costner di Fandango, quello che siamo stati, quello che siamo, e quello che saremo. Scegliere di amare un gruppo così – e gli YLT o li ami o neppure sai chi sono, non ci sono vie di mezzo – vuol dire posizionarsi nel mondo. O almeno, lo voleva dire quando queste cose avevano un senso. Sia come sia, loro c’erano trent’anni fa e ci sono oggi. Sempre uguali, sempre adorabili: Ira stropicciato e scarmigliato a grattugiare la chitarra, Georgia a battere i tamburi con il suo eterno viso da “pioniera che guida il carro verso il West, ed è bellissima” (sempre Blatto, maestro di stile); James pacioccone e rassicurante al basso. Io, da bravo ragazzo cresciuto negli anni Ottanta, li ho sempre visti come la versione indie-sfigata dei protagonisti di Cuore e batticuore, con Ira&Georgia nei ruoli di Robert Wagner e Stephanie Powers, e James in quello del fido Lionel Stander.
Il mio tributo personale agli Yo la Tengo lo espletai quasi una decina di anni fa con il lungo articolo per il Mucchio Extra che segue, costruito sulla base di una piacevolissima chiacchierata telefonica con Kaplan. Mi pare giusto ripescarlo oggi che è uscito da poco il nuovo disco, There’s a Riot Going On. Sul quale mi sento di sottoscrivere la descrizione ispirata che ne ha dato l’amico e collega Paolo Bassotti: più che suonato, sembra sognato. Una ninna nanna per adulti, e forse anche per la contemporaneità, che in comune con il capolavoro di Sly & the Family Stone del ’71 ha non solo il titolo ma pure una certa atmosfera sedata e oppiacea (anche se, al contrario del vecchio Sly, il massimo del doping che possiamo supporre per gli Yo la Tengo credo sia il tè al bergamotto). In tempi di crisi, reagire con un riot sussurrato invece che urlato può anche essere una buona strategia. Comunque, una scelta rispettabile e a suo modo radicale. Nessuna cavalcata elettrica, nessun accenno pop: solo un prolungato e benefico massaggio mentale fatto di ballate impalpabili, a volte sconfinanti nell’ambient e nell’immobilità quasi assoluta, nelle quali si possono rintracciare ombre di John Fahey così come dei Labradford, dei Free Design così come degli Stereolab o di Brian Eno, ma non è comunque questo il punto. There’s a Riot Going On esalta il concetto di musico-terapia. Abbandonarvisi significa rinunciare almeno per un’ora alle gratificazioni istantanee e pavloviane sulle quali ci stiamo adagiando nella nostra nuova natura di animali non più sociali ma social. Significa riscoprire un diverso scandire del tempo, che di per sé è già un atto di resistenza. Capisco chi può trovarlo noioso o ripetitivo, ma lo invito ad approcciarlo con le difese abbassate e la disponibilità a farsi prendere per mano, e forse cambierà idea. Per quanto mi riguarda, penso che sia un disco bellissimo. Sono di parte, lo so. E magari mi accontento solo della felicità di sapere che una band come gli Yo la Tengo ha fatto parte della mia vita, e che dopo tutti questi anni ci sia ancora.
Il15 maggio suonano a Milano, ovviamente ho già il biglietto.
Non dovrebbe esserci nebbia.
Forse.

Genio + Amore = Yo La Tengo
(da Mucchio Extra n. 37, inverno 2012)
Su quello che è, a oggi, l’ultimo album degli Yo La Tengo c’è una canzone che si chiama If It’s True. Un delizioso omaggio all’era gloriosa dei gruppi femminili, introdotto da un giro di basso che più Motown non si può, condotto da un organo meravigliosamente Sixties e avvolto in un irresistibile svolazzare di archi. Le voci di Ira Kaplan e di Georgia Hubley si alternano tra una strofa e l’altra, in un botta-e-risposta che fa sembrare il brano quasi una conversazione privata. A due terzi della durata, dopo il bridge, Georgia chiede “Wont’ you try a little bit harder”, Ira replica “I could try a little bit more”, lei insiste “If you could only stop thinking about of” e lui ammette che “maybe we’ll find just what we’re looking for”. È uno di quegli istanti di purezza assoluta in cui il pop si fa poesia. E forse racchiude il mistero del fascino che da un quarto di secolo questa piccola band indipendente dal nome buffo esercita su tanti di noi. Si può sintetizzare in due parole, le stesse che davano il titolo a una loro raccolta di inediti: genius and love.
Sinceramente, non riesco a pensare a un mondo senza Yo La Tengo. In qualche modo è come se Georgia, Ira e James ci fossero sempre stati. Vecchi amici sui quali fare affidamento, qualunque cosa succeda: puoi perderli di vista per un po’, ma hai la certezza che quando ne avrai bisogno loro saranno lì. Quando ti starai annoiando a morte ascoltando il milionesimo dischetto indie uguale agli altri milioni di dischetti indie che hai ascoltato nella vita, prova a dare un’occhiata al calendario: se ti renderai conto che sono passati tre anni dall’ultimo album degli Yo La Tengo avrai la matematica certezza che sta per arrivarne uno nuovo e ti tornerà il sorriso. Quando ti troverai a vagare come un’anima in pena tra un palco e l’altro del solito festival rock alternativo, cercando qualcosa di meglio della nuova sensazione del momento buona giusto a scopiazzare musiche di trent’anni fa (9.8 su Pitchfork!), di vecchi tromboni riciclati nell’ennesima inutile reunion (cinque stelle su Mojo!), di “sperimentatori” segaioli e dj cafonissimi, butta sempre un orecchio a quel che arriva da qualche palco minore: potrà capitarti di sentire un rumore familiare di chitarra grattugiata e rock’n’roll in feedback. Se seguirai quell’irresistibile richiamo da pifferaio magico ci sono ottime probabilità che ti troverai davanti Kaplan con la maglietta a strisce tutto ingobbito sulla sua sei corde, McNew che rumina pacioso al basso e miss Hubley nella sua eterna posa da Moe Tucker più sbarazzina, e a quel punto… beh, ti sentirai di nuovo a casa.
No, non riesco proprio a immaginare una vita da appassionato di rock senza quell’oasi di sana, rassicurante umanità e di buonissima musica chiamata Yo La Tengo. Fare riferimento a un videoclip per provare a descrivere l’anima di un gruppo è sciocco, ma nel caso dei ragazzi del New Jersey ce n’è uno che è quasi una carta d’identità. È quello di Sugarcube, nel quale i nostri eroi vengono spediti dalla casa discografica a “ripetizioni di rock” in una Alma Mater con degli orrendi professori metallari: tra una lezione di assolo, session di tatuaggi e interrogazioni sul “primo principio dei Foghat”, i tre teneri imbranati si diplomano e poi tornano a suonare esattamente come prima. A quindici anni di distanza quel video fa ancora morire dal ridere, suscitando un liberatorio impulso di identificazione. Quei tre sfigati con la foto spiegazzata di Lou Reed in tasca e i dischi dei Black Flag nascosti sotto il banco sono tutti noi.
Mi è venuto spontaneo ripensarci, durante la conversazione telefonica con Ira Kaplan. Un’ora di chiacchierata in cui abbiamo parlato della storia degli Yo La Tengo ma pure dei nostri dischi dei Kinks preferiti, di ciclismo e della crisi delle Borse (solo per accorgerci che, al contrario dei primi due argomenti, nessuno di noi due ne capiva un accidente). Non mi vengono in mente molti altri musicisti, anche di area indipendente, che avrebbero concesso fuori da ogni obbligo promozionale un’ora del loro tempo a un giornalista italiano, raccontandosi con la stessa gentilezza e la stessa passione di Ira. Riavvolgiamo il nastro, quindi, e partiamo dalle origini.

Yo La Tengo presidente!
“We stared at the sun, too long
until the shapes before our eyes
turned into the sun, in our eyes”
(The Story Of Yo La Tengo)
“Sono nato nel 1957 a New York. Georgia è del ’60, e anche lei è newyorkese doc. In casa mia la musica non è mai mancata. Mia madre suonava chitarra e piano, i miei fratelli sapevano tutti maneggiare uno strumento, quindi è toccato anche a me andare a lezione di chitarra classica e piano, intorno ai nove-dieci anni. Non che mi sia mai servito a molto. Tecnicamente rimango un chitarrista semi-analfabeta, e di come suono le tastiere non ne parliamo neanche. In compenso la passione per la musica pop, da ascoltatore, è esplosa prestissimo. Da pre-adolescente avevo dei gusti decisamente all’avanguardia! Le prime grandi infatuazioni le ho avute per le band inglesi, quelle della british invasion: Beatles, Stones, Troggs, un po’ più tardi ho scoperto i Kinks che sono diventati subito il mio gruppo del cuore. Poi andando avanti ho scoperto un sacco di altre cose, a cominciare dai Velvet Underground. Naturalmente, da newyorkese ho vissuto in pieno l’era del CBGB’s e del Max’s. Al college pensavo solo alla musica, e forse anche per questo ho ottenuto risultati disastrosi. Georgia ha frequentato la scuola d’arte, ma lei al contrario di me era una che studiava”.
Ira e Georgia, Georgia e Ira. Il leitmotiv di una vita, in musica e non. I due si conoscono intorno alla fine degli anni Settanta, e molto probabilmente in quel momento c’era qualcuno a suonare su un palco o un disco a girare su un piatto.
“Avevamo parecchi amici in comune, ci piacevano le stesse band. Ci si incrociava quasi ogni sera in qualche club, ovunque ci fosse un concerto. Frequentando quel piccolo giro di appassionati di rock sotterraneo, a New York, era inevitabile incontrarsi”. Kaplan non rivela se fu amore a prima vista, ma si suppone di sì se già l’anno successivo la coppia fugge da New York, e si trasferisce armi, bagagli e chitarre a Hoboken, nel New Jersey. La cittadina è a pochi chilometri da Manhattan, ma dal punto di vista economico e sociale – almeno all’epoca – era come se fosse in un’altra galassia. “Non potevamo più permetterci di stare a New York. Troppo cara. A Hoboken la vita costava la metà, ma soprattutto a Hoboken c’era il Maxwell’s”.

E per fortuna c’è ancora. Oggi come ieri incrollabile avamposto indie, nonostante le vicissitudini e i cambi di proprietà degli ultimi venticinque anni. Il piccolo locale si era riconvertito da tavola calda a rock-club nel 1978, grazie all’intraprendenza di colui al quale il nome del Maxwell’s (così come quello dell’etichetta da lui fondata, la Coyote Records) rimarrà legato per sempre: Steve Fallon.
“Facemmo subito amicizia con Steve. Eravamo tutte le sere al Maxwell’s, dato che c’era un’atmosfera fantastica e si ascoltava sempre grande musica. C’è da dire che era anche l’unico locale decente di Hoboken. In pratica io e Georgia vivevamo lì: io davo una mano a Steve con la programmazione, Georgia metteva i dischi. Fu un gran bel periodo”.
Naturale che ai due venga anche voglia di suonarci, al Maxwell’s. E di suonarci tanto. L’idea di formare una band però prende corpo in un secondo tempo. All’inizio è puro sfogo estemporaneo, una delle tante manifestazioni del virus rock’n’roll che ha ormai preso pieno possesso degli organismi di Kaplan e della Hubley. Si suona per il gusto di suonare, per scaricare l’adrenalina, per passare le notti con i vari amici insieme ai quali si sta creando una piccola “scena”. Roba casalinga e senza troppe pretese “artistiche”, sia chiaro. Ira e Georgia non sono mai stati tipi da loft, e con la no wave e i suoi algidi maestrini c’entravano poco o niente. Tra i personaggi a cui si legano in quel lungo periodo di riscaldamento figurano invece alcuni che hanno poi lasciato tracce importanti nella storia dell’alternative/college rock degli anni 80 e oltre. Per esempio Sue Garner (originaria di Athens, perno di band quali Shams, The Last Round Up e Run On), gli Antietam di Tara Key e Tim Harris (anch’essi marito e moglie, autori di una decina di dischi a partire dall’omonimo esordio su Homestead del 1985), i Feelies e soprattutto i dB’s.
“Il rapporto con loro è sempre stato molto stretto. Peter Holsapple ci ha incoraggiato a fondare la band, è stato uno dei nostri più grandi supporter. Si adattava persino a suonare il basso con noi, quando aveva del tempo libero. Così come ha fatto Gene Holder in President Yo La Tengo, disco che ha anche prodotto con l’aiuto di Chris Stamey. Insomma, ai dB’s siamo riconoscenti per un sacco di motivi”.
Dopo qualche anno passato a ravvivare party e serate al Maxwell’s, nel 1984 finalmente si decide che è ora di fare le cose sul serio. Mancano solo tre elementi: un chitarrista solista, un bassista e un nome. I primi due verranno trovati tramite un’inserzione con cui si cercano spiriti affini, “appassionati di Soft Boys, Love e Mission of Burma” (guarda caso sarà proprio il bassista degli ultimi, Clint Conley, a produrre l’album di debutto). Il problema è che nell’arco dei successivi quattro dischi non saranno mai le stesse persone, e fino all’arrivo di James McNew nel 1992 la line up del gruppo soffrirà di instabilità cronica. Quanto al nome… lo sapevate che Hoboken è stata la culla del baseball americano? Fu sui suoi Elysian Fields che nel 1846 venne giocato il primo incontro, tra i Knickerbockers e i New York Nine. Purtroppo l’ho scoperto dopo la chiacchierata con Kaplan, altrimenti gli avrei chiesto se “Yo La Tengo” (espressione ispanica che sta per “l’ho presa!”, a quanto pare tipica del catcher a baseball) fosse un omaggio obliquo alla loro città adottiva. Di sicuro è un colpo di genio. Una ragione sociale istantaneamente memorizzabile e diversa da qualunque altra, anche se foriera di qualche comica possibilità di fraintendimento.
“Il nome è venuto in mente a me, ma a sceglierlo fu Georgia. Non dirò neanche sotto tortura quali erano le alternative. Ci piacque fin dall’inizio, soprattutto perché era quanto di più lontano dai nomi tipici delle band di revival psichedelico che andavano forte all’epoca. Era un’espressione che non c’entrava niente con il nostro mondo, da quello che si supponeva fosse il nostro immaginario. Sembrava il nome di un gruppo di salsa. E infatti per diversi anni nei negozi non specializzati ci hanno regolarmente messo nel reparto della latino-americana”.
Nel frattempo, Ira intraprende una carriera che per breve tempo si sovrapporrà a quella di musicista.
“Iniziai a fare recensioni di dischi per New York Rocker, Village Voice, SoHo News e altre piccole testate. In realtà non mi è mai piaciuto fare il giornalista. Non amavo affatto scrivere, mentre amavo moltissimo ricevere i promo e entrare gratis nei locali. Diciamo che non ho mai avuto la vocazione dello scrittore. Il vecchio luogo comune secondo cui i critici rock vorrebbero in realtà fare i musicisti non sempre è vero, ma nel mio caso lo era di sicuro. E a parte quello, preferivo comunque di gran lunga organizzare concerti o far girare i dischi nei club. Dopo l’uscita del primo album degli Yo la Tengo ho smesso con la penna, salvo una piccola reprise nei primi anni Novanta quando un mio amico che lavorava per Spin mi propose di intervistare Neil Young, e poi di andare a Parigi a seguire un concerto del tour di reunion dei Velvet Underground. Potevo forse rifiutare? Quelli sì che sono i momenti in cui vale la pena fare il giornalista musicale: quando puoi incontrare i tuoi eroi”.
Condivido, anche se non ho mai avuto il piacere di far due chiacchiere né con zio Neil né con Lou Reed o John Cale (e manco con la buonanima di Sterling Morrison o Maureen Tucker, se è per questo). A proposito dei Velvet, il fatto che sia lo stesso Ira a citarli mi toglie dall’imbarazzo di porre la vexata quaestio che da venticinque anni tormenta il povero musicista di Hoboken. Avessero ricevuto un dollaro per ogni volta in cui Lulù e soci sono stati tirati in ballo in un articolo sugli Yo La Tengo, Ira e Georgia come minimo avrebbero una Ferrari in garage. Del resto, è una maledizione che si sono attirati volontariamente. Basti dire che già sul secondo disco, tanto per segnare il territorio, sfoggiano una cover di It’s Alrigth (The Way That You Live), oscuro demo “vellutato”. In quegli anni roba da cultori sopraffini e fan terminali.
“Non ho mai nascosto la mia passione per i Velvet Underground, e sono ben consapevole di quanto questa venga fuori all’ascolto dei nostri dischi. Il mio modo di cantare, certe parti di chitarra… lo so, lo so benissimo. Ma mi secca che i critici spesso si siano fermati a quello. Non siamo mai stati una band-fotocopia di qualcun altro, come tante altre che si trovavano in giro quando iniziammo e anche dopo. E in ogni caso nel nostro suono, anche nei primi tempi, si potevano trovare molte altre influenze, non solo i Velvet. Inoltre, c’è un fatto importante: raramente i nostri ascolti del momento si riflettono nei dischi che facciamo uscire in quel periodo. Per dire, nel periodo a metà anni Novanta in cui ci dicevano che suonavamo krautrock stavamo ascoltando quasi solo folk. Il krautrock lo avevamo ascoltato anni prima, ma è emerso come suggestione solo in quel frangente. Il punto è che siamo sempre stati degli appassionati voraci e onnivori, abbiamo assorbito tanta di quella musica diversa che poi questa è stata rigurgitata, se mi passi il termine, a distanza di anni e forse senza neppure volerlo”.
Questo concetto tornerà più volte nel corso dell’intervista, quasi come se Ira ci tenesse a negare qualunque tipo di calcolo nella genesi dei lavori firmati Yo La Tengo. Ricalcare coscientemente l’impronta artistica di qualcun altro non va d’accordo con l’ispirazione genuina e “sregolata” che, a detta del chitarrista, da sempre fa da propellente alla creatività del gruppo. Mentre invece vi si adatta benissimo la passione quasi morbosa per le cover. Una pratica nella quale indulgono voluttuosamente fin dal “pronti, via”, come testimonia la rilettura – morbida e quasi morriconiana – di A House Is Not A Motel dei Love, retro del primo singolo The River Of Water. Il lato A è un pacifico esercizio di strimpellamento folk-rock (con una irruzione di fiati vagamente incongrua), e verrà aggiunto sulle ristampe dell’esordio in lungo Ride The Tiger, pubblicato in origine nel 1986 dalla Coyote dell’amico Fallon. Non a caso, è l’unico estratto da quell’album a figurare nella scaletta di Prisoners Of Love, antologia che nel 2005 univa un cd di rarità e inediti a due dischetti riassuntivi della carriera della band. E vi compare forse più per l’affetto dovuto al primo passo discografico che per riconosciuti meriti artistici. Tutti gli altri album sono rappresentati da due o tre brani, tanto per sottolineare ulteriormente la natura di brutto anatroccolo di Ride The Tiger. Certo fa un po’ male, a chi si innamorò degli Yo La Tengo in tempo reale proprio con quel disco, dover leggere sulla All Music Guide che oggi è giusto considerarlo un “decidedly modest affair”. Sarà. Ovvio che il confronto con ciò che è seguito – a partire dall’immediato successore – risulti impietoso, ma personalmente trovo ancora gustoso il jangle-rock più (The Evil That Men Do, Screaming Lead Balloons) o meno (The Cone Of Silence) aggressivo che contraddistingue quasi tutte le canzoni, con le parziali eccezioni di qualche episodio da Velvet Underground – mannaggia – incrociati con la new wave (The Forest Green e Empty Pools, che non avrebbero sfigurato nel repertorio dei Go-Betweens o dei Felt) e di un paio di inevitabili cover (Big Sky, dai Kinks di Village Green Preservation Society, e Living In The Country, di Pete Seeger). In fin dei conti è il suono di tanto rock sotterraneo di quegli anni, e con tutto il doveroso ridimensionamento di un’operina ancora ingenua e qui e là insicura, all’epoca parve comunque già con una marcia in più rispetto alla media indie del periodo. Grazie soprattutto a un fattore, che non è la scrittura di Kaplan quanto semmai lo stile chitarristico di Dave Schramm (che con il bassista Mike Lewis completava la formazione). Solista dotato di tecnica sopraffina e di una voce miagolante e dylaniana (la si può ascoltare su The Way Some People Die e Five Years), ricomparirà soltanto su Fakebook qualche anno dopo, incidendo con il suo gruppo (chiamato con scarsa fantasia Schramms) diversi ottimi album. Soprattutto i primi due – Walk To Delphi (OKra, 1990) e Rock, Paper, Scissors & Dynamite (Okra, 1992) – non dovrebbero mancare nella discoteca di qualunque cultore di college rock a cavallo tra Ottanta e Novanta. Non sorprende che Kaplan, pur riconoscendo i meriti di Schramm, non abbia particolarmente a cuore Ride The Tiger. Stupisce piuttosto il giudizio severo sugli album immediatamente successivi.
“Il nostro esordio è davvero un disco troppo naïf. Mi correggo: io e Georgia eravamo naïf, non certo Dave che come musicista era molto più bravo di noi. Non riascolto Ride The Tiger da una vita, ma posso comunque dirti che i due dischi venuti dopo non è che siano molto meglio”.

New Wave Hot Dogs (1987) e il mini-lp President Yo La Tengo (1989) stanno ora fianco a fianco in un’unica ristampa della Matador datata 1996, a sottolinearne la continuità e una certa affinità stilistica. Oggi Kaplan ammette di non suonare praticamente mai dal vivo canzoni del primo, mentre ogni tanto si diverte a ripescare qualcosa del secondo. Nuovamente la distanza temporale e la tanta musica passata sotto i ponti non giocano a favore, e nuovamente mi tocca ammettere che sì, I Can Hear Your Heart Beating As One e And Then Nothing Turned Itself Inside Out stanno su un altro pianeta, eppure questi due lavori suonano tuttora vivaci, energici e rumorosi. Le schitarrate nervose di Clunk, House Fall Down e The Story Of Jazz sono coinvolgenti oggi come allora, se si ama un certo r’n’r “di base”, tanto ingenuo e distorto quanto eccitante. Al pari delle melodie accattivanti di Lewis e Did I Tell You, della frenesia di Serpentine (con tanto di organetto garage) e di una Shy Dog quasi alla Dinosaur Jr, dell’ipnotica quiete di Lost In Bessemer (antenata di altre, più convinte, divagazioni strumentali che la band svilupperà in futuro). Il tasso di elettricità e furore chitarristico si impenna ulteriormente in President Yo La Tengo e poco possono, per bilanciare in senso inverso, l’interpretazione devota del Dylan di I Threw It All Away , la cavalcata western da far invidia a Steve Wynn di Drug Test e la ballata Alyda (nella quale si rivelano le potenzialità della voce di Georgia, anche se qui utilizzata solo come controcanto). Sono le folate noisy di Orange Song (un brano degli Antietam), il riff circolare e ripetitivo di Barnaby Hardly Working e soprattutto le randellate dei dieci mostruosi minuti di The Evil That Men Do a dettare legge. Dell’ultima c’è anche una versione più breve, dai toni languidamente surf, ed entrambe hanno poco in comune con il brano dallo stesso titolo nella scaletta di Ride The Tiger. Mania innocente ma significativa, quella di re-incidere più volte la stessa canzone su dischi diversi: anche le citate Barnaby Hardly Working e Did I Tell You compariranno nuovamente su Fakebook.
“Non sono sicuro di cosa ci spingesse a fare una cosa del genere, ma soprattutto nei primi tempi trovavamo irresistibile tornare più volte sullo stesso brano. A volte risuonandolo nelle prove ci accorgevamo che ci portava da un’altra parte. Era eccitante, accorgersi di come potevamo far evolvere una canzone che avevamo scritto noi. Del resto, fare cover ci è sempre piaciuto: in un certo senso, era come fare una cover di se stessi”.
Ed è proprio assecondando questa tendenza alla rilettura creativa – tanto del repertorio altrui quanto del proprio – che si creano i presupposti per il disco che inaugura il decennio più intenso degli Yo La Tengo. Fakebook uscì nel 1990 (per la Bar/None) e sulle prime parve un piccolo passo indietro nell’evoluzione del gruppo, se non altro per la provenienza del materiale. In quegli anni i dischi di sole cover non erano ancora così diffusi, e qualcuno ipotizzò che il carburante nel serbatoio Yo La Tengo fosse già agli sgoccioli. Bastarono tuttavia a spazzare via i dubbi dei più cinici tra gli ascoltatori la piacevolezza assoluta, la fragranza della morbida pasta acustica di cui erano fatti i brani, l’evidente coinvolgimento dei musicisti. Non era un giocare in difesa per mancanza di ispirazione, quello di Fakebook, semmai una piccola lezione sul concetto spesso frainteso di “cover”, e su come si possano omaggiare le proprie passioni musicali senza suonare in un solo istante approssimativi, derivativi o svogliati (aggettivi che qualificano un gran numero di cover-record). Non si può neanche dire che Kaplan, Hubley e il redivivo Schramm volessero fare i furbetti, agganciandosi al traino di qualche brano famoso per guadagnare un po’ notorietà a costo zero. La scaletta sembra (no, non sembra: è) stilata dal più classico dei nerd musicofili, con il recupero di nuggets sepolte sotto strati di terra. Da veri tombaroli pop, i nostri rispolverano gioielli come Yellow Sarong, che dal disteso fraseggiare melodico si penserebbe opera di qualche sconosciuto gruppo beat dei Sixties e invece è di un ensemble sperimentale della New York di vent’anni dopo (i The Scene Is Now), oppure il rock’n’roll parodistico di Emulsified, classica novelty-song dal repertorio di Rex Garvin & The Mighty Cravers, o ancora il giocoso bluegrass di Griselda degli Holy Modal Rounders di Peter Stampfel. Per non parlare di quella Speeding Motorcycle scritta da un Daniel Johnston allora ignoto ai più e che qualche tempo dopo la canterà al telefono con la band, in uno dei momenti più geniali nella storia degli Yo La Tengo (potete ascoltarla sulla citata Genius + Love = Yo La Tengo). Appena più “famose” You Tore Me Down dei Flamin’ Groovies e Tried So Hard di Gene Clark, immaginette sacre del power pop e del folk-rock esibite con grande devozione, così come il sinuoso country-swing di What Can I Say della NRBQ, cantata dalla Hubley con quel delizioso tono “da conversazione” che sarà sempre uno sei suoi tratti caratteristici e che purtroppo è stato utilizzato con eccessiva parsimonia nei dischi della band. Detto dei brani autografi già apparsi sui dischi precedenti e qui rivisti in chiave acustica, ai quali per far buon peso vengono aggiunti un paio di inediti (Can’t Forget e The Summer), resta ancora da citare la dolcezza con cui vengono affrontati gli unici due pesi massimi, John Cale e i soliti Kinks, dei quali vengono rilette rispettivamente Andalucia e Oklahoma USA. In sintesi: album godibilissimo dalla prima canzone all’ultima, nel quale oltretutto si mette in mostra il lato più quieto e lunare del Kaplan chitarrista, altrettanto efficace di quello tutto feedback e fischi.
“Fakebook era figlio di un periodo in cui io e Georgia, a causa dell’instabilità della formazione e della nostra cronica incapacità di tenerci lo stesso bassista per più di cinque minuti, giravamo in duo per programmi radiofonici, campus, pub e piccoli locali, suonando in acustico. Piuttosto che ri-arrangiare pezzi nostri nati su presupposti completamente diversi, preferivamo divertirci con brani che abbiamo sempre amato. L’idea di un disco di cover fu una conseguenza naturale: ci piaceva da un lato far vedere che non eravamo solo una band di casinisti, e dall’altro far conoscere pezzi magari poco noti ma che personalmente ho sempre ritenuto essere classici. Amo quel piccolo disco: c’è un’atmosfera di grande intimità, un po’ come quando vai a cena da qualcuno e a un certo punto il padrone di casa tira fuori la chitarra e si mette a suonare. Magari è stonato o un po’ brillo, magari le canzoni non sono cantate proprio nella maniera giusta, ma sai che ci sta mettendo il cuore”.

Big Days Coming
We made up our minds to lose and never once looked back
We only looked back just once
We opened our hearts, it’s true
But not to any of you
(The Story Of Yo La Tengo)
C’è sempre, nella storia di qualunque grande band, un momento in cui si raggiunge l’equilibrio perfetto con l’aggiunta di qualcosa o qualcuno che prima non c’era. Il tassello che arriva a completare il puzzle, il Ringo Starr dopo il quale si può dire “ok, adesso ci siamo tutti, si può partire davvero”. Nel caso degli Yo La Tengo, questo elemento ha l’aspetto pienotto e rassicurante di James McNew. Una sorta di Lou Barlow con qualche chilo in più (e la capacità di scrivere canzoni migliori) che finalmente nel 1992 risolve l’annoso problema del bassista. Dopo l’avvicendarsi di Mike Lewis, Clint Conley, Stephen Wichnewski, Gene Holder e qualche altro carneade raccattato qui e là per suonare dal vivo, McNew sembra inizialmente solo un altro ripiego. Quasi vent’anni dopo è ancora lì, al servizio della coppia Kaplan/Hubley. Oddio, considerarlo una specie di maggiordomo di casa suona davvero offensivo. Il suo ruolo nelle dinamiche della band è essenziale, musicalmente e umanamente, e il primo a riconoscerlo è lo stesso Kaplan.
“Sottovalutare l’apporto di James agli Yo La Tengo è impossibile. La verità è che siamo diventati sul serio una band solo quando è arrivato lui. Era evidente che prima mancava qualcosa. Sul piano umano, che è quello davvero importante, rappresenta il terzo vertice di un triangolo perfetto. Quasi perfetto (ride, NdI). Prima faticavamo tantissimo a comunicare, con altri membri temporanei e a volte persino tra noi due. Con James quel problema è magicamente evaporato”.
McNew, virginiano di origine, nel 1990 suona il basso nei Christmas, il gruppo di Elizabeth Cox e Michael Cudahy che poi evolverà nei Combustible Edison, autori di un lounge-pop che riscuoterà una certa notorietà nel corso del decennio. L’unico album in cui si sente la sua mano è Vortex, pubblicato proprio quell’anno; la band ne incide un altro subito dopo, ma la casa discografica lo mette su uno scaffale impedendone l’uscita. Trovandosi professionalmente in stand by, McNew fa un colpo di telefono a quella simpatica coppia del New Jersey con cui i Christmas avevano diviso il palco più di una volta.
“Ci fa: ehi, ragazzi, guardate che al momento sono libero. Se un giorno aveste bisogno di me, fatevi sentire. Dopo Fakebook ci ritrovammo per l’ennesima volta senza un bassista, mi ricordai della sua offerta e lo cercai per reclutarlo in vista di un tour. La prima cosa che mi disse, ‘ehi, Ira, guarda che scherzavo, mica pensavo che mi chiamassi sul serio!’. Ancora adesso sostiene di essere entrato negli Yo La Tengo per sbaglio, e di essere solo temporaneamente nella band”.
McNew inizia a prestare servizio, in qualità di bassista pro-tempore più fedele nella storia del rock, con May I Sing With Me, che nel 1992 segna un ennesimo cambio di etichetta (esce per la Alias). Il suo apporto si fa notare dal punto di vista strumentale – è decisamente più un “martello”, rispetto a chi lo ha preceduto – ma non ancora da quello della scrittura né da quello dell’amalgama musicale con i suoi due nuovi compagni di avventura. È Kaplan a spadroneggiare, invece, sfogando la propria voglia di rock crudo e distorto e abbandonandosi a orgasmi con la sua sei corde un tantino eccessivi. Ululati e guaiti da far svegliare il vicinato, a tratti però francamente fastidiosi. Sotto accusa soprattutto le due maratone strumentali (quasi venti minuti in totale) Mushroom Cloud Of Hiss e Sleeping Pill: la prima stipata di noise fuori controllo, come una specie di Sister Ray suonata dai Sonic Youth un giorno in cui si sono alzati con la luna di traverso, la seconda più pachidermica, riverberata e “drogata”. Noiose e poco risolte entrambe, comunque. Non è, come abbiamo visto, la prima e non sarà l’ultima volta in cui il chitarrista – chiariamo: un buonissimo chitarrista, perfettamente in grado di sostenere tour de force come questi – si fa sviare dall’auto-indulgenza. Il primo a riconoscerlo è lo stesso Kaplan.
“Quando leggo in giro che May I Sing With Me è il nostro album più debole mi girano le scatole, perché ho sempre pensato che fosse migliore di quanto pensino quasi tutti i critici e i nostri fan. Ci sono ottime cose lì dentro, ma quando lo riascolto devo ammettere di essermi fatto prendere la mano, ogni tanto. Più per insicurezza che per presunzione: probabilmente non avevamo le idee così chiare sulla direzione da imboccare. Tieni conto che anche se James suona nel disco le canzoni erano state scritte prima del suo arrivo. Così semplicemente ho alzato il volume e mi sono lasciato andare. È una strategia che a volte funziona, altre volte no. In alcuni momenti di May I Sing With Me non funziona affatto, ma nonostante questo continuo a credere che sia un buon album. Molto meglio di Ride The Tiger, come qualità dei pezzi. Il fatto è che probabilmente Ride The Tiger rappresenta il massimo dei risultati che potevamo ottenere in quel momento, mentre lo stesso non si può dire di May I Sing With Me”.
Questa volta condividiamo in pieno la severità del giudizio, ma capiamo anche perché Ira nutra ancora affetto per questo disco, fratellino un po’ problematico dei lavori più maturi che sarebbero giunti da lì a poco. Di “cose buone”, per citare le sue parole, ce ne sono eccome, anche se messe in ombra dalla prolissità dei due brani citati. Tanto per cominciare la copertina, che non è mai un dettaglio da poco: nettamente la migliore nella discografia degli Yo La Tengo, che peraltro temiamo non verrà mai esposta al MOMA. In secondo luogo, il fatto che Georgia prenda il microfono più spesso: come in Satellite, prototipo di tante altre ballate notturne a venire, o anche soltanto quando fa la seconda voce nell’irresistibile Upside-Down. È in pezzi come quest’ultimo, oppure come l’ultra-rock’n’roll Some Kinda Fatigue (in cui Ira azzecca il riff giusto, a metà strada tra Feelies e Television) o Five Cornered Drone (Crispy Duck), che tutta quella frenesia chitarristica viene portata a buon fine.
Riassumendo: il più tipico dei lavori di transizione. Verso dove, comincerà a chiarirlo Painful, l’anno successivo. Siamo a questo punto a uno snodo fondamentale nella carriera dei ragazzi di Hoboken. Per tornare alla similitudine di prima, dopo Ringo Starr trovano anche il loro George Martin e il loro Brian Epstein. Nelle persone, rispettivamente, di Roger Moutenot e di Gerard Cosloy, uno dei patron di quella Matador che da lì in poi marchierà tutte le uscite della band. Per quanto riguarda il produttore, fino a quel momento gli Yo La Tengo avevano lavorato in simbiosi con Gene Holder, dietro al mixer negli ultimi tre album, ma l’ex dB’s a un certo punto ha altri impegni da seguire, e forse c’è anche qualche dissapore con Kaplan a causa della non perfetta riuscita di May I Sing With Me.
“Il rapporto con Roger e la Matador nacque più o meno nello stesso periodo. È importante sottolineare che la lavorazione di Painful era già più che avviata, prima che firmassimo con l’etichetta. Praticamente avevamo un album quasi finito, ma senza una casa discografica che lo facesse uscire. Eravamo disperati, poi casualmente riallacciai i rapporti con Gerry (Cosloy, NdI), che conoscevo dai tempi di New York Rocker. Lui era il corrispondente da Boston. Lo avevo frequentato parecchio nella seconda metà degli anni Ottanta, dato che ero un grande fan dei dischi che pubblicava con la Homestead. Quando entrò come socio alla Matador (l’etichetta era stata fondata nel 1989 da Chris Lombardi, NdI) mi disse ‘teniamoci in contatto, prima o poi faremo qualcosa assieme’. Non pensavo potesse accadere così presto, però. Fu proprio Gerard a lanciarci un salvagente, all’epoca. E per noi non poteva esserci soluzione migliore”.

Surreale a ripensarci, ma quello che è il primo, vero grande disco degli Yo La Tengo da più parti all’epoca venne giudicato lavoro mal riuscito. Troppo soffocante e “difficile”, si scrisse. Poco comunicativo. Ma che sono questi interminabili drone di chitarra, a che serve tutta questa ripetitività, ma dove vogliono andare a parare questi sfigati di Hoboken? Non erano contenti di suonare il loro rock’n’roll casinaro e di fare i piccoli Velvet portatili? Ennesima dimostrazione della miopia e della pigrizia di quella che pomposamente si autodefinisce “critica” rock. Quella che vorrebbe imbalsamare qualunque band, indie o meno, in uno stereotipo immutabile, precludendosi la possibilità di cogliere l’unica forza capace di far progredire la musica pop: il desiderio di cambiare. In Painful gli Yo La Tengo si mettono coraggiosamente alla prova, guardandosi dall’esterno e provando a forzare i loro limiti. La chitarra è sempre regina, ma utilizzata in modalità e contesti nuovi. La tentazione nei confronti del rumore viene incanalata in strutture più rigorose, quasi geometriche. È il meccanismo della ripetizione a dettare legge, alternandosi tra crudezza formale e violenza trattenuta (il riff spietato di I Was The Fool Beside You, le minacciose spirali elettriche che avvolgono il mormorare di Georgia in From A Motel 6) e atmosfere rarefatte, sospese in una sorta di limbo oppiaceo (Nowhere Near, Superstar Watcher). A conferire profondità e tonalità più drammatiche al suono è la maggiore interazione tra chitarra e tastiere, e non solo in Sudden Organ, deliquio psichedelico che scopre il suo gioco già dal titolo. Nella trasformazione si mantengono comunque alcune sane consuetudini. Metterci la solita cover da connoisseurs, per esempio: con l’interpretazione eterea, quasi impalpabile di Whole Of The Law degli Only Ones si conquistano per sempre il cuore del sottoscritto. Non manca neanche la doppia versione dello stesso brano, che in questo caso si chiama Big Day Coming: quella che apre il disco è un sogno a occhi aperti punteggiato da rade interferenze elettriche, come se la 4AD avesse traslocato nel New Jersey, mentre quella più breve è puro meccanicismo krautrock, con il feedback al posto del beat elettronico. E poi c’è l’appassionante cavalcata di I Heard You Looking, in cui il distendersi della chitarra, finalmente libera da costrizioni, fa esplodere lampi di melodia e apre spazi di percezione che quasi giustificano l’ardita sinestesia espressa nel titolo.
È con questo disco, che per tagliare con l’accetta delle formule preconfezionate si può definire “dream-pop” o addirittura “shoegazing” ma in realtà è qualcosa di più e di meglio, che gli Yo La Tengo cominciano a farsi grandi sul serio. Stranamente, Kaplan tende a situare il vero scarto stilistico e creativo all’altezza dell’album successivo, pur definendo Painful “estremamente sperimentale”. Forse c’entrano i ricordi non proprio piacevolissimi legati alla genesi del disco, inciso in un arco di tempo prolungato, con troppe interruzioni tra una session e l’altra e soprattutto con l’angoscia di non vederlo mai uscire.
“Fu l’ultima volta in cui registrammo in quel modo, da lì in poi le incisioni sono sempre state concentrate in un tempo ben definito, senza distrazioni. È il modo migliore per lavorare, ti permette di non disperdere le energie e di non farti cadere preda dei dubbi e dei ripensamenti. Ma nel 1993 eravamo ancora in un periodo un po’ confuso della nostra storia”.
La band suona parecchio, negli Stati Uniti e in Europa. Il primo tour nel nostro continente avviene già all’epoca di New Wave Hot Dogs, e del resto il palco è ab origine la dimensione ideale del gruppo. Naturale che a lungo andare la fatica si faccia sentire. E poi quello è un momento caotico un po’ per tutto il mondo del rock indipendente, non solo per gli Yo La Tengo. Il fallout del grunge – con il quale non c’era alcun rischio potessero essere confusi, nonostante l’estrazione fosse la stessa – ha depositato scorie di disillusione e di spaesamento creativo su quel rock che una volta era underground, per cinque minuti non lo è più stato e che a quel punto si stava preparando a ritornare nei bassifondi. Rivolgimenti, rivoluzioni mancate e riflussi che non sfiorano minimamente il piccolo mondo degli Yo La Tengo.
“Guardavamo quel che stava succedendo, ma dal di fuori. Dalla nostra tana di Hoboken, dove eravamo rinchiusi a provare e riprovare, niente sembrava avere davvero importanza. ‘Ehi, guarda, ci sono i Nirvana primi in classifica’. ‘Oh, figo, sono contento per Kurt. Dov’è finita la mia pedaliera?’ Questo non perché giocassimo a fare i cani sciolti o per snobismo, ma semplicemente perché chiudevamo fuori dalla nostra sala prove qualunque cosa non ci riguardasse. È sempre stato così, e lo è tuttora. Siamo focalizzati solo su di noi. Ci sono diversi dischi di quel periodo che mi piacciono, e non nego certo l’impatto che ha avuto il grunge, ma non mi sono mai sentito davvero coinvolto in quell’ondata. Ci accorgevamo che stava capitando qualcosa perché la gente che conoscevamo ci guardava in modo diverso, come se si aspettasse anche da noi il botto che ci facesse schizzare in classifica e il contratto major. Per noi erano prospettive semplicemente inesistenti: non che rifiutassimo l’idea del successo in sé, è proprio che era una cosa che non avrebbe mai potuto riguardarci, non rientrava nel nostro orizzonte”.
Si avverte, in effetti, una certa “insularità” nella musica della band, una tendenza ad avvolgersi nella propria coperta di Linus musicale che tocca l’apice nel periodo tra Painful e il suo successore, Electr-o-Pura. Pubblicato dalla Matador (ma distribuito dalla Atlantic) alla metà esatta degli anni 90 e inciso con Moutenot a Nashville (“Roger si era trasferito lì, e dato che ci eravamo trovati bene per Painful siamo andati da lui a registrare: tolto qualche missaggio a Boston, era la prima volta che ci spostavamo da Hoboken per fare un disco”), rappresenta l’archetipo di un certo rock alternativo dell’epoca, serrato nel mezzo tra tentazioni sperimentali e richiami al passato (psichedelia, punk, wave). Può considerarsi il gemello di Painful, ma più solido e meno sognatore. Tolta un po’ di paccottiglia noise inutilmente dissonante (Attack On Love, False Ending, False Alarm) e qualche esperimento divertente ma riuscito a metà (Paul Is Dead, con vocalizzi che vorrebbero ricordare i Residents o i Beach Boys ma finiscono per assomigliare più al Muppet Show) è un lavoro compatto e di grande fascino. I drone di chitarra di The Ballads Of Red Buckets e le atmosfere incantate di The Hour Grows Late e Pablo & Andrea (una delle ballate più intense mai scritte dalla band: a proposito, da qui in avanti sotto ogni brano ci sarà democraticamente la firma Hubley/Kaplan/McNew) sottolineano l’intenzione di ripartire dal suono del predecessore, ma con maggior fisicità e un senso più accentuato del pathos. Al posto di I Heard You Looking troviamo Blue Line Swinger, simile nella durata e nell’idea di fondo, con la differenza che qui invece che sciogliere subito le briglie alla chitarra si procede per accumulo progressivo: organo, batteria, sei corde e, proprio a metà, la voce di Georgia che sembra arrivare da un’altra dimensione e che accompagna con poetica discrezione il brano fino al suo climax. Uno dei momenti più sublimi dell’intera epopea Yo la Tengo, come del resto pensa lo stesso Ira (“se mi chiedi qual è il mio pezzo preferito tra quelli che ho scritto, beninteso puntandomi una pistola alla tempia, ti rispondo Blue Line Swinger”). Al pari di Tom Courtenay, è chiaro: un favoloso esemplare di hit possibile solo in un universo parallelo nonché gioiello power pop che inchioda fin dall’attacco nostalgicamente cinefilo come il titolo (“Julie Christie, the rumors are true…”; proseguendo con le citazioni Sixties-britanniche nel testo si fa anche il nome di Eleanor Bron, protagonista femminile in Help! di Richard Lester). Per chiudere il cerchio, al brano venne abbinato un video strepitoso, nel quale non a caso intervengono i Beatles. In spirito, almeno. Vediamo infatti i Nostri convocati da uno squaletto dell’industria discografica come band di spalla per il concerto di reunion dei Favolosi Quattro, che ovviamente non si presentano (al loro posto però arriva Marshall Creenshaw: chi s’accontenta gode…). Il clip finisce con la band che suona Twist And Shout per tenere buono il pubblico. “Il video lo ha girato Phil Morrison, che è sempre stato il nostro regista e fotografo di fiducia. C’è la sua firma anche su quelli di Big Day Coming e di Sugarcube. L’idea nacque cazzeggiando una sera a cena, lo spunto probabilmente era mio ma Phil lo migliorò, come succedeva quasi sempre. Quelli erano gli anni in cui si dava per scontato che si dovesse fare un video, era una voce di spesa fissa nella promozione di un disco, ma nella stragrande maggioranza dei casi la gente tirava fuori cose di routine, poco ispirate. Con Phil ci siamo divertiti a inventarci qualcosa di diverso, cercando di rimanere sempre dentro budget risicatissimi”.

Quando la notte scese su Hoboken
We stared at the road ahead
Closed our eyes and then
sped up to the turn, around the bend
(The Story Of Yo la Tengo)
Nel 1997 la parola d’ordine per essere invitati al festino della musica alternativa al mainstream è una sola: post-rock. Formuletta prêt-à-porter con cui un po’ tutti in quel periodo ci si riempiva la bocca, definizione multiuso che significava tutto e niente (più che altro “niente”, come si scoprirà passata la sbornia critico-ideologica). Per quelle quattro o cinque band (parliamo dei primi Tortoise, di June of 44, For Carnation e Labradford, degli esordi della Constellation) davvero in grado di sperimentare, partendo dalle recenti lezioni di Slint e Talk Talk e mischiando i detriti lasciati da quarant’anni di rock a influssi provenienti dal jazz, dall’elettronica, dal dub, c’erano altresì centinaia di pretenziosi e anemici fusionari dei quali come è giusto si è persa la memoria. Per quanto possa sembrare strano, tra i migliori interpreti di quella vaga – ma per un breve periodo sincera, e a tratti propulsiva – aspirazione a rimodellare le forme del genere più popolare del dopoguerra spiccavano proprio tre umili rockettari del New Jersey di nostra conoscenza. Gli Yo La Tengo post-rock? Sì, no, forse. Non è così importante appiccicare etichette, per di più su una band che le ha sempre rifiutate. Sta di fatto che pochissimi altri, partiti come loro da un background tradizionale e “garage” (si intenda il termine nel senso più generico possibile), hanno avuto il fegato di approdare al linguaggio contaminato, che a un certo punto si fa quasi astratto, di I Can Hear The Heart Beating As One (1997) e soprattutto di And The Nothing Turned Itself Inside Out (2000). Inevitabile, a dieci-quindici anni di distanza, considerarli quasi come la fase 1 e la fase 2 di uno stesso esperimento. Pur essendo sotto molti aspetti dischi assai diversi tra loro, segnano il momento di massima sovrapposizione del trio con la contemporaneità, per una volta in linea con lo spirito del tempo. Ira, Georgia e James non diventano delle star, ovviamente, ma se ancora oggi sono una delle pochissime band indipendenti nate negli anni Ottanta conosciute e amate dalle nuove generazioni (con la “dismissione” dei R.E.M. rimangono giusto Flaming Lips e Giant Sand) lo devono soprattutto ai paletti fissati con quei due album, nuovamente incisi in quel di Nashville con la supervisione del fido Moutenot. A tal proposito, ecco una delle pillole di saggezza firmate Kaplan: “Per il nostro modo di lavorare e di intendere la musica, o forse dovrei dire la vita, avere delle ancore di sicurezza è fondamentale. Roger e la Matador rappresentano esattamente quello. Siamo stati fortunati, ad averli incontrati a metà strada. Da lì in poi non abbiamo più voluto cambiare. Che senso ha saltare da una parte all’altra, cambiare produttori e studi di registrazione come facevamo agli inizi, per poi fare dischi che si assomigliano tutti?”.
Di sicuro I Can Hear The Heart Beating As One assomiglia a poco di ciò che gli Yo La Tengo hanno fatto in precedenza, e meno ancora vi assomiglierà And Then Nothing… Per cominciare a descrivere il primo, comunque, si può partire dalle similitudini già evidenziate in Electr-O-Pura con un altro gruppo, anch’esso iscritto di forza alla congrega post-rock e con cui i Nostri andranno anche in tour: gli Stereolab. Lasciando perdere l’attrazione per il post-modernismo pop amplificato dal gusto per le citazioni (nei titoli, nei testi, nei suoni) e il sempre più ricorrente occhieggiare a musiche fin lì considerate laterali dal rocker medio (dalla bossa – si ascolti Center Of Gravity – al lounge), basterebbe da sola Moby Octopad, con il suo pa-pa-pa-pa-pa, il campionamento di Bacharach e il modo di cantare di Georgia assai simile a quello di Laetitia Sadier, per far sorgere qualche legittimo sospetto.
“Il primo a parlarci di loro fu un nostro amico, subito dopo aver ascoltato Painful. Ci disse che gli ricordavamo questo strano gruppo inglese, gli Stereolab, ma non sapeva perché! Noi non li avevamo mai sentiti nominare. Mi procurai i loro dischi, ed effettivamente c’era un’aria di famiglia. Sono una band per cui nutro grande ammirazione e rispetto, ma non posso dire che ci abbiano influenzato durante le registrazioni di I Can Hear… Come ho detto prima, cerchiamo sempre di allontanarci dai nostri ascolti del momento. Lo stesso discorso vale per il post-rock. Potevano esserci somiglianze con altre cose di quel periodo, ma personalmente il dub o il krautrock li ascoltavo già da anni, non avevo bisogno di farmi suggestionare dai Tortoise. C’è un fatto, innegabile: da I Can Hear…, ma a ben vedere già da Electr-O-Pura, il nostro stile è cambiato. Ci siamo aperti a influenze diverse, cercando di incorporare nel nostro suono musiche che non avevamo mai esplorato prima. Le canzoni si sono fatte più lunghe, e in generale c’è stato meno ‘self-editing’: se prima ci censuravamo certe cose perché non ci sentivamo in grado, da lì in avanti ci siamo detti ‘perché no, proviamoci’”.
Un brano su tutti, nell’ottavo album della band, esemplifica questo nuovo approccio: si intitola Autumn Sweater, una delle più scintillanti tra le tante perle regalate dagli Yo La Tengo nella loro storia. Percussioni minacciose – alle quali non è probabilmente estranea l’influenza del trip hop, ma neppure quella di certa exotica richiamata dalle tablas -, basso cavernoso e un organo leggiadro costituiscono il tappeto sonoro su cui rotola un po’ assonnato il cantato di Kaplan: un brano mirabile per equilibrio, grazia, capacità di mantenere l’attenzione pur restando praticamente immobile. Un mash-up tra i Portishead e i Beatles di Tomorrow Never Knows (a un certo punto a Ira scappa un “in the beginning…” rivelativo) che solo una grande, grandissima band come questa poteva inventarsi. Zero chitarra, ma d’altro canto la sei corde si riprende il palcoscenico in pezzi furiosamente pop-gazing come Sugarcube e Little Honda (i Beach Boys fatti a brandelli dai Jesus & Mary Chain) o in ballate di straordinaria orecchiabilità come Stockholm Syndrome, cantata da McNew e da lì in poi immancabile in qualunque scaletta di concerto. In Deeper Into Movies si torna nei luoghi tormentati dei due dischi precedenti, con le voci letteralmente affondate nell’elettricità, mentre Damage getta un ponte verso quello che verrà, con un “ahhh ahhh” etereo in lontananza, drone attorcigliati al feedback, stridori di sottofondo e un beat metronomico. Altro scenario immancabile è quello agreste e notturno di delizie come Green Arrow, tra slide e frinire di uccelli, o quello da grandi spazi country di One PM Again. Tutto talmente perfetto e amalgamato che i Nostri possono permettersi la consueta sbrodolatura rumorista (i dieci minuti di Spec Bebop, proprio quel genere di cose per cui è stata inventata la funzione “skip” dei lettori cd) e la chiusura deliziosamente kitsch con la voce di Georgia – una voce da ragazzina che non viene invitata alle feste del liceo – alle prese con una cover degli Osmonds, My Little Corner Of The World.

E poi, improvvisamente, tre anni dopo calano le tenebre. Ma è un’oscurità morbida, avvolgente, benigna, quella di And Then Nothing Turned Itself Inside Out. Una coperta di suoni vellutati che ti tiene caldo per tutta la notte e ti accompagna fino al mattino, quando ti risvegli con flash di sogni confusi in mente e un senso di profondo benessere nel cuore. Un descrizione da non intendere solo metaforicamente: tanto per fare un esempio, ho un amico che per mesi ha usato questo disco per cullare e far addormentare la figlia appena nata. Qualche maligno potrebbe insinuare che musica del genere potrebbe far crollare pure gli elefanti, non solo i neonati, ma non dategli retta. Se è vero che quando uscì, ATNTIIO (perdonate la bruttezza dell’acronimo) spiazzò gli stessi fan della band per la lunghezza biblica, la densità del suono e l’omogeneità delle atmosfere, oggi sono pochi a non riconoscerlo per il capolavoro che è. La frase fatta sui dischi “che richiedono attenzione” non è mai stata così vera come in questo caso. Ci si deve abbandonare a queste canzoni, le si può ascoltare solo come ci si mette in ascolto della risacca dell’oceano o della pioggia che batte sulla finestra. Persino quando il ritmo si scuote leggermente – come nella dolcissima ballata Madeline o in You Can Have It All, cover di un vecchio pezzo disco di George McCrae (quello di Rock Your Baby) rivisto con un arrangiamento “stereolabico” che lo trasforma in una sorta di samba futuristico – l’andamento della musica è volutamente circolare e narcotico. Proprio per questo pare stridere un pezzo per altri versi fantastico come Cherry Chapstick, orgia di chitarre fuzzate e distorte che avrebbe fatto la sua porca figura su qualunque album precedente ma che in questo contesto spezza in modo un po’ troppo brutale la quiete del vicinato.
“Lo inserimmo a registrazioni praticamente già ultimate, probabilmente per movimentare un minimo una scaletta che avevamo paura potesse sembrare troppo monocorde. Riascoltando il disco oggi forse un po’ me ne pento, anche se adoro quella canzone”.
In quasi tutti gli altri brani la chitarra di Ira è un sussurro, al pari della voce. Entrambe hanno una funzione quasi paesaggistica, considerando che lo scheletro delle composizioni si regge molto di più sul basso, le percussioni, i sequencer e una scalcinata rhythm-box. Non sono l’impatto epidermico, le linee melodiche o il volume a dare profondità, ma l’intreccio di suoni, le tessiture armoniche, le tenui ma incessanti colorazioni ritmiche sullo sfondo. In un certo senso, è quasi più un lavoro di Hubley e McNew che di Kaplan. Basti ascoltare l’apertura severa di Everyday o il procedere a singhiozzo di Last Days Of Disco. Tired Hippo profuma di medio Oriente, mentre la batteria spazzolata e il contrabbasso di Our Way To Fall manifestano chiare influenze jazz, così come i tocchi sparsi di pianoforte sul beat sintetico d’antan – tra Suicide e Silver Apples – di Saturday fanno venire in mente l’astrattismo dell’amico Howe Gelb. Per raccontare della magnificenza di Tears Are In Your Eyes, cantata da Georgia in modo che si può definire solo come “angelico” e sarebbe già farle torto, mancano invece le parole. Così come mancano le parole agli ultimi tredici minuti – su diciassette in totale – di Night Falls On Hoboken, dove riverberi, clangori, soffi, sprazzi di ritmo e rumori fanno sfociare il disco nell’incorporeità.
Stranamente (o forse no), Ira mantiene un certo riserbo su questo trionfo artistico degli Yo La Tengo, quasi avesse timore di rovinarne il ricordo.
“Credo che in quel preciso momento della nostra storia volessimo provare a fare qualcosa di nuovo. È forse l’album che più degli altri rappresenta il nostro microcosmo, e contemporaneamente la nostra abitudine di concentrarci totalmente sulla musica. Sono anche molto legato ai testi, di quel disco. A essere sincero, prima non è che me ne curassi troppo. Per la prima volta ci siamo sforzati di raccontare qualcosa di diverso, forse di aprirci un po’ al mondo. In gran parte quelle canzoni parlano di amore, degli alti e bassi di una lunga relazione tra due persone. Non necessariamente me e Georgia, anzi spero che in quei testi chiunque possa almeno in parte riconoscersi. Qualcuno ha scritto che And Then…è l’anti-Blood On The Tracks, nel senso che racconta la parte positiva del matrimonio; credo che esageri, ma è un bel paragone”.

They are not afraid of you and they will (still) beat your ass
We lied to ourselves for a while
In our usual style
Now I wish we could ride, we wish we could lie to ourselves again
(The Story Of Yo La Tengo)
E siamo così planati sugli ultimi dieci anni nella storia degli Yo La Tengo. Passato prossimo sul quale possiamo cavarcela abbastanza velocemente, perché più fresco nella mente di chi segue le cronache indie rock, e perché in fondo non ci sono svolte radicali o eventi capitali da raccontare. Il gruppo si è ormai assestato nel limbo della sua sofferta e nuova maturità, per citare Battisti e Mogol. E di qui i tre del New Jersey potranno andare avanti all’infinito, con i loro album nuovi ogni tre anni, i dischi “strani” distribuiti solo sul loro sito, i concerti in giro per il mondo, le colonne sonore (in questo momento sono al lavoro su uno score per un film importante, anche se “per scaramanzia” Ira non vuole anticipare nulla), i vari progetti più o meno bislacchi che li tengono occupati nei ritagli di tempo. Dal punto di vista del linguaggio musicale per gli Yo la Tengo non è più tempo di rivoluzioni. Semmai di (piccole) variazioni sul tema, come hanno dimostrato i tre dischi usciti tra il 2003 e il 2009, gli ultimi fino a questo momento. Summer Sun, al di là del perverso umorismo del titolo in netto contrasto con la foto di copertina e il tono medio dell’album, riparte dalle atmosfere del predecessore lasciando tuttavia filtrare un po’ di luce e di leggerezza. Lo testimoniano la morbidezza di brani come Season Of The Shark (pervaso da un sottile aroma Belle & Sebastian), Little Eyes e la quasi bossa nova di How To Make a Baby Elephant Float. Non mancano l’inevitabile cover (una spoglia Take Care, dal terzo dei Big Star) e l’altrettanto inevitabile pezzo-fiume (la quieta, come da titolo, Let’s Be Still), ma da segnalare sono soprattutto le venature black che cominciano ad apparire – peraltro già annunciate dal doppio 7” Nuclear War del 2001, dove rifanno Sun Ra – in alcuni brani. Inflessioni jazzate, sincopi funk (Georgia vs Yo La Tengo, titolo che è tutto un programma), sinuose melodie tra soul classico, Motown e disco: niente di sconvolgente, e tuttavia gustose aggiunte alla solita ricetta.
“La musica nera ci è sempre piaciuta e ne abbiamo sempre ascoltata un sacco, ma è stato solo dopo And Then Nothing… che abbiamo provato davvero a incorporare alcune di quelle influenze nel nostro suono. Un nostro amico frequentava parecchio il giro dei musicisti impro-jazz di New York, che noi non conoscevamo per nulla. Un po’ timidamente gli abbiamo detto di sondare il terreno con alcuni di loro, chiedendogli se avevano voglia di suonare con noi anche se facevamo tutt’altra musica. Così è stato, e da quell’esperienza è nato Nuclear War. Un incontro che ci ha aperto spazi che prima non riuscivamo neanche a cogliere,e che ci ha in un certo senso liberati”.
È anche grazie a questa nuova linfa nera che I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass (2006) e Popular Songs (2009) manifestano vitalità e persino una certa freschezza. Bastino come esempio Mr. Tough sul primo (Yo La Prince?) e il funkaccio Periodically Triple Or Double sul secondo. Per il resto sono due album gemelli, facilmente sintetizzabili con i consueti “tag”: lunghezza spropositata, maratone soniche più (Pass The Hatchet I Think I’m Goodkind e The Story Of Yo La Tengo, da I Am Not Afraid…)) o meno riuscite (The Fireside, And The Glitter Is Gone, da Popular Songs), rock’n’roll garagista, sospensioni folk, psichedelia jazzata (la notevole The Room Got Heavy), notturni country, ballate pop, cavalcate rumorose, svisate vecchio stile sul Farfisa. Aumenta il ricorso alle tastiere, mentre stranamente scompaiono le cover (anche se ce ne sono due “mascherate”, rispettivamente Black Flowers e I’m On My Way: la prima sembra molto più che un omaggio a Paris 1919 di John Cale, la seconda ha sospette assonanze con Didn’t Want To Have To Do It dei Lovin’ Spoonful). Dischi dignitosissimi, comunque, e in gran parte assolutamente godibili. Sarebbe ingiusto chiedere di più, e lecito aspettarsi molto meno da una band in pista da un quarto di secolo.
“Uno dei motivi per cui ci mettiamo tre anni fra un album e l’altro è che ci piace fare un sacco di altre cose, musicalmente parlando. Se ci viene voglia di pubblicare un disco di cover r’n’r tipo quello dei Condo Fucks lo facciamo, senza stare a pensarci tanto su. Se ci chiamano per delle session radiofoniche partiamo e andiamo. Se abbiamo voglia di buttare giù delle idee che magari potranno tornarci utili quando ci commissioneranno una colonna sonora, ci troviamo in studio e registriamo. Non diciamo mai di no a niente”.
Ecco spiegato l’elenco quasi surreale di progetti e stranezze assortite che riempie il curriculum del gruppo, per il quale vi rimando al box che trovate in queste pagine. Oltre all’amore per la musica, c’è un’altra ragione per questa iper-attività. Altrettanto nobile.
“L’ho detto più volte nel corso di questa intervista: gli Yo La Tengo sono un’entità autosufficiente. A volte fin troppo. Quando suoniamo, esistiamo solo noi tre e basta; fondamentalmente suoniamo solo per noi. Io in particolare. A volte, dopo i concerti, James o Georgia parlano di com’era il pubblico, e io non so cosa dire: in genere chiudo gli occhi, suono e non mi accorgo di niente. Alla lunga si rischia di diventare egoisti e forse anche un po’ autistici. Per cui, visto che spesso chiudiamo fuori tutto, ogni tanto cerchiamo di realizzare qualcosa di più inclusivo, di lasciar entrare la gente nel nostro mondo. Ecco perché poi andiamo a fare show in radio in cui suoniamo sul momento le canzoni che ci richiedono gli ascoltatori, o altre piccole follie del genere”.
Genio e amore, di nuovo. E a tal proposito, l’ultima domanda per Ira riguarda Georgia: quale è la sua più grande qualità, come musicista? Dopo qualche secondo di silenzio arriva la risposta: “La sua voce. Ogni volta che canta, mi spezza il cuore”.
Anche a noi, Ira. Anche a noi.

“Le venti giornate di Torino”, quarant’anni dopo.
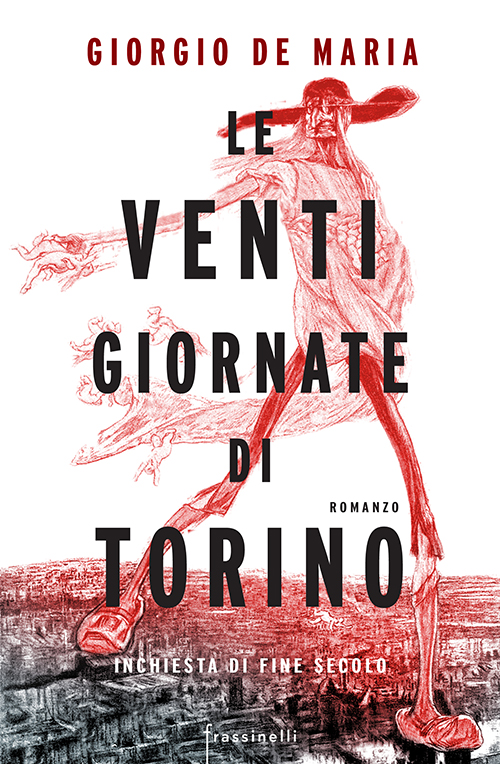
Come mi auguro accada a ogni buon torinese, mi ha sempre ammorbato quella trita, noiosissima menata su “Torino città magica”. Oppure, nella sua versione hardcore, “demoniaca”. Tutto quel bric-à-brac fatto di triangolazioni di magia bianca (con Praga e Lione) e nera (con Londra e San Francisco: certo, qui non potevamo gemellarci per la musica), scacchiere del diavolo, piazzette nelle quali si concentrano energie maligne, teste di capro usate come battenti sui portoni delle palazzine della Crocetta, sacri Graal nascosti nella chiesa della Gran Madre, maledizioni di don Bosco e altre decine, centinaia di fesserie kitsch sulle quali poggerebbe la presunta natura esoterica di Torino. Fa tutto parte della stessa brochure turistica, assieme a grissini, gianduiotti, bollito, Mole Antonelliana e Juve (questa sì, unica presenza demoniaca certificata della città).
Il diavolo a Torino non starà nei dettagli ma neppure in un guazzabuglio di cose senza relazioni tra loro, né storiche né fattuali né culturali, il cui intreccio fantasioso è frutto più che altro dell’antica radice massonica della città mescolata a un perverso senso dell’umorismo, che fa ridere solo i torinesi e stranamente risulta incomprensibile al resto del mondo. D’altra parte, essendo fondata sui contrasti e le antinomie, Torino è anche la città che a questo campionario di ciarpame da mentecatti e babau da film di serie Z ha sempre saputo opporre il suo esatto opposto: un ferreo positivismo scientista che a volte (vedi Lombroso e i suoi allegri scheletri di briganti calabresi) è stato assorbito esso stesso in questa bagna cauda di stranger things.
Con tutto ciò, un libro come Le venti giornate della città di Torino c’entra poco. Quasi nulla. Eppure, questo romanzo dimenticato per quarant’anni e ora in procinto di diventare cult (nei paesi anglosassoni lo è già da qualche tempo) è l’unica testimonianza letteraria in grado di far vacillare, almeno per la durata della sua lettura, le menti più rigidamente razionaliste come quella del sottoscritto.
In queste pagine, Torino fa davvero paura. Torino sembra davvero attraversata da qualcosa di malvagio. Qualcosa che rimane appiccicato addosso anche dopo aver terminato il romanzo, lasciando in testa una sensazione di paranoia umida e malsana come le rive del Po.
A fare la sinossi di un romanzo di neppure 150 pagine (peraltro densissime) si rischia di raccontarlo dall’inizio alla fine e di spoilerare tutto lo spoilerabile. In estrema sintesi, Le venti giornate di Torino è il racconto di una indagine impossibile. Un classico di molta letteratura (e cinema) all’incrocio tra giallo, horror e fantastico, nella quale il protagonista e voce narrante è un detective per caso, intestarditosi a dipanare i misteri di una vicenda messa sotto il tappeto dal resto del mondo. In questo caso, si tratta di un impiegato del quale non conosciamo il nome, che lavora in una non precisata “ditta” (termine che fa già molto travet piemontese), flautista dilettante e ancor più dilettante investigatore. Dilettante ma, come si intuisce dalle prime pagine, non esattamente geniale. Il caso che si è messo in testa di risolvere è quello di un oscuro periodo risalente a dieci anni prima. Quando per venti giorni di luglio Torino venne sconvolta da una epidemia di insonnia, da misteriose premonizioni e – tanto per gradire – da una serie di orribili delitti che sembravano commessi da entità non-umane. Poi, così come l’orrore era nato, si era dissolto. Oppure, più inquietantemente, mimetizzato in una nuova normalità. Nella quale, per esempio, Torino si era in parte spopolata con il prudente ritorno a casa degli emigranti dal sud.
“Il ritrovarci, quasi d’un tratto, ripiegati nella purezza autoctona – un evento sia pure da molti auspicato con acre spirito campanilistico – aveva finito per creare un entrale senso di smarrimento. ‘Oh guarda chi si rivede! Di nuovo tutti insieme fra noi, se Dio vuole!’”.
Un passaggio come questo farebbe oggi la felicità del leghista medio, nell’improbabile caso che sapesse leggere. Ma in realtà coglieva una pulsione più profonda, un improvviso sentirsi fuori posto e fuori di sesto tipico del periodo in cui venne scritto il romanzo, e che chiunque sia cresciuto in una famiglia torinese doc in quegli anni sicuramente ricorda.
Ed è proprio quella Torino a essere protagonista, più che fondale, della storia. La Torino de La donna della domenica e quella (appena visibile) di Profondo rosso. Ma anche quella del derby Toro-Juve che valeva lo scudetto, del PCI al potere, del terrorismo diffuso. Di tutto ciò si avverte un’eco, più o meno esplicita, nel romanzo. Insieme alla Torino più classicamente noir, con i suoi luoghi simbolo e i suoi monumenti, presenze urbane praticamente invisibili all’occhio del passante ma – almeno in questo caso – tutt’altro che benevole. Quella che non c’è, appunto, è la Torino dell’esoterismo cheap. Se ne fa solo un accenno quando viene nominato, con evidente intento sprezzante, il “mago Rol”.
E poi, incastonata in questa cornice sabauda, c’è l’invenzione borgesiana di De Maria, il colpo di genio che ha fatto drizzare le antenne anche all’estero e che rende Le venti giornate di Torino un caso di preveggenza letterario più unico che raro. Si tratta della Biblioteca. Non starò a spiegare cos’è, altrimenti racconto tutto il libro. Chi leggerà si renderà conto che qui, nella mostruosa Biblioteca ospitata (altra intuizione straordinaria) nei padiglioni del Cottolengo- uno dei luoghi in cui la dialettica luce-ombre di Torino si manifesta al massimo della sua potenzialità – De Maria anticipa davvero, come è stato stato notato da chi finora si è preso la briga di parlarne, il nostro presente. Social network, interrelazione, self-publishing, haters, troll, gentismo, condivisione malata e solitudine assoluta: c’è tutto. Messo nero su bianco (molto più nero che bianco), nell’autunno del 1976.
La Biblioteca è una creazione reale che finisce per diventare qualcosa di metafisico. Proprio come le realtà virtuali di oggi, le varie cloud e secret room nelle quali la gente ama disperdersi. O come la pittura di De Chirico, che dalle piazze e dai portici di Torino venne profondamente ispirato. Leggendo il romanzo di De Maria vengono in mente svariati altri riferimenti: l’ovvio Lovecraft (non quello sbrodolone e verboso del ciclo di Ctulhu, semmai quello conciso e davvero terrorizzante di racconti come Nyarlathotep, profeta dell’apocalisse che – coincidenza – suonava anch’esso il flauto come l’investigatore del romanzo), Poe, il Kafka de Il castello.
In questo splendido e competentissimo articolo pubblicato da Not, l’autrice Sara Marzullo ne aggiunge altri ancora – Guido Morselli, La casa delle finestre che ridono – ai quali non avevo pensato ma che in effetti calzano perfettamente. Nel pezzo si delinea con chiarezza il perimetro culturale – cosciente o pre-sciente – de Le venti giornate di Torino, raccontando anche le varie coincidenze e intrecci inquietanti che hanno a che fare con la vita dell’autore – morto alcolizzato e dimenticato più di trent’anni dopo, in preda a crisi mistiche e senza anche avesse più pubblicato una riga – e persino con la ripubblicazione attuale. Tutto molto eerie e molto weird, per usare le parole della Marzullo. Ci sarebbe sufficiente materiale per un altro romanzo, ce n’è comunque stato per un saggio di Giovanni Arduino, che immerge le mani in questa mefitica matassa sciogliendone tutti i nodi, narrativi e biografici.
Ma una lettura che farebbe magnificamente da pendant a Le venti giornate di Torino è anche Il mistero di Torino di Vittorio Messori (in realtà ci sarebbe pure una parte di Aldo Cazzullo, tranquillamente sacrificabile). Uno dei libri più belli e profondi che abbia mai letto sulla mia città, per giunta scritto da un torinese d’adozione e non di nascita. Superata la diffidenza dovuta alla distanza ideologica con l’autore, lo sguardo malizioso da coltissimo flaneur di Messori mi ha davvero portato al centro del mistero di Torino. Un mistero che non è fatto, come detto, di maghi, maghetti, esorcisti, satanismi fumettistici con corredo di orge nelle ville della collina e altre stupidaggini del genere. Sta, appunto, in qualcosa di metafisico. Una corrente sotterranea, elettrica, un imprinting quasi biologico – risultato di un adattamento allo spazio, ai resti monumentali, alle formule verbali, al mescolamento di tradizioni, alle contraddizioni, persino all’aria di Torino – che si nasconde dietro la maschera alla Macario del “torinese falso e cortese”. Metafisico come la paranoia, che è la vera regina del romanzo di De Maria.
Un paranoia incredibilmente moderna. C’era nel 1976, c’è molto di più oggi. Qualcosa che forse solo gli scrittori – o certi scrittori – sanno captare. Come notava Messori, Torino detiene tra le altre cose anche il primato degli scrittori che si sono uccisi. Salgari, Pavese, Levi, Lucentini sono i primi a venire in mente. Nietzsche vi è impazzito. Kafka si era ripromesso di starne alla larga. Chissà cos’è, si chiede Messori, che vedono di così spaventosamente illuminante, in questa città, gli scrittori. La stessa domanda che ci si può fare a proposito di De Maria, visto come è finito. Ma forse nessun scrittore avrebbe mai potuto andare oltre il finale de Le venti giornate di Torino. Uno dei più spaventosi, malsani, visionari, inquietanti finali di romanzo che avrete la ventura di leggere.
Extra files #2. Paisley Underground – I giorni del vino e delle rose.

Nell’autunno del 1982 appariva nei negozi un disco dalla copertina essenziale (un rettangolo turchese in campo bianco) e dal titolo straordinariamente evocativo: The Days Of Wine And Roses. Era il debutto di una band chiamata Dream Syndicate, e contemporaneamente il primo capitolo nel romanzo breve del Paisley Underground. Un romanzo appassionante ma, come dire?, d’appendice, le cui pagine sono state mandate a memoria da molti, irrise da altrettanti, fraintese dai più. E oggi, sostanzialmente, quasi dimenticate. Riaprire quel libro significa riconnettersi a un periodo in cui la parola indie non suonava come l’insulto di oggi. Niente, a dir la verità, “suonava” come oggi: i vinili, le fanzine, i club, le cantine, le etichette discografiche, i concerti, le passioni. Tutto diverso. Non necessariamente migliore. Semplicemente diverso.
Dream Syndicate, Long Ryders, Rain Parade/Opal, True West, Green On Red, Three O’ Clock, Bangles: il Paisley Underground era tutto qui, più qualche occasionale compagno di strada e svariati progetti paralleli. Niente più che un gruppo di amici uniti dagli stessi amori musicali, che riprendendo in mano le chitarre – un gesto quasi sovversivo, in quei tempi – provavano a riprendersi il rock’n’roll. Riportando di nuovo tutto a casa, e inventandosi (forse) una vita migliore.
YEARS LONG AGO
“Ehi, lo sapevate che in questi ultimi anni è uscita un sacco di grande musica?”. “Ah, sì? Quale?” (Jeff Goldblum e Kevin Kline ne Il grande freddo, 1983)

(The Suspects, 1979, con Gavin Blair, Russ Tolman, Steve Wynn e Kendra Smith)
La nostalgia, si sa, è una canaglia. Perché come la memoria è infida e traditrice, soprattutto quando è legata a qualcosa o qualcuno che si è molto amato. L’articolo che state per leggere è nato facendoci letteralmente a pugni, con la nostalgia. Perché va bene sforzarsi di mantenere un minimo di oggettività storica e di neutralità critica, ma se metti uno che ha avuto diciotto anni nel 1986 a scrivere un pezzo sul Paisley Underground non puoi aspettarti asettiche analisi sull’ampiezza limitata del fenomeno o scrupolosi esercizi di riduzionismo. Perché ok, era solo un manipolo di ragazzi californiani con le chitarre elettriche, i pantaloni a sigaretta e i capelli fuori moda, ma a noi che avremmo voluto vedere morti tutti quei cialtroni neoromantici con i loro fottuti synth e la loro fottuta cipria sulla faccia, beh a noi quei ragazzi sembravano l’avanguardia della modernità. E no, non cambiò né il mondo né la storia della musica, il Paisley; però sì, accidenti, qualche vita la cambiò, e anche solo per questo è stato importante. Come qualsiasi altro genere musicale, del resto.
Un momento: quella cosa chiamata da tutti – tranne che da chi ne faceva parte – “Paisley Underground” non fu affatto un genere. Sgombriamo subito il campo dagli equivoci. Fu, semmai, una scena. Un fenomeno compresso nell’arco di pochissimi anni, incentrato intorno a una trentina scarsa di persone in un’area ben definita dello sterminato comprensorio losangelino (North Hollywood, con qualche propaggine a Venice Beach e, su a nord verso la Sacramento Valley, il campus universitario di Davis).

(Dream Syndicate, 1982)
Un attimo perfettamente circoscritto nel tempo e nello spazio, dunque. Questo fu il Paisley. Una brezza pomeridiana alzatasi di colpo e svanita via in un amen, una canzone di tre minuti e mezzo, un sogno lungo un giorno o poco più. Eppure, scambiando la parte per il tutto, la famigerata definizione venne estesa a tutto ciò che nella musica di quel periodo odorava vagamente di anni 60, rock chitarristico, psichedelia, ecc. L’equivoco si è protratto nel tempo, e ancora oggi prestigiose enciclopedie on-line sotto l’ombrello Paisley fanno rientrare di tutto, dai Chesterfield Kings ai Giant Sand, dai Feelies ai R.E.M. (!), dai Replacements (!!) alle band australiane (ho finito i punti esclamativi). Certo, esisteva un sentire comune e innumerevoli fili intrecciati, ma la neopsichedelia fu una cosa e il Paisley Underground un’altra. Affine, ma altra. Così come erano tutt’altra cosa i Thin White Rope, anch’essi spesso associati – in questo caso con qualche ragione – al movimento di Los Angeles. Band grandissima ma appartata, la cui vicenda si è sviluppata tangenzialmente a quella dei gruppi di cui leggerete senza tuttavia mai intersecarsi davvero, se non agli inizi. Dopo aver impiegato qualche migliaio di battute per definire ciò di cui non parleremo, è forse arrivata l’ora di presentare i protagonisti di queste pagine. Per farlo, torniamo indietro nel tempo. Many, many years ago. La didascalia dice: “California, 1982”.
HOLLYWOOD HOLIDAYS
“I dreamed last night/I was born a thousand years ago…” (Dream Syndicate, When You Smile)

(Green on Red)
Scena: un barbecue nel cortile di un caseggiato a due piani sulle colline di Hollywood. La mecca del cinema è lì vicino, ma i partecipanti alla grigliata sono quanto di più lontano immaginabile dalle star che sguazzano in piscina a Beverly Hills. Sono invece ventenni che campano alla giornata, sognando i loro sogni rock’n’roll. Tutti quanti hanno appena messo su una band, o stanno per farlo. I padroni di casa, un tipo un po’ arcigno e tendente alla pinguedine di nome Dan Stuart e un tastierista taciturno chiamato Chris Cacavas, sono già in pista con il gruppo che avevano formato quando ancora stavano a Tucson, in Arizona. Hanno appena deciso di cambiare il nome, da Serfers a un più misterioso Green on Red. Seduti in disparte, un paio di ragazzi allampanati stanno discutendo animatamente di accordature e di vecchie Gibson con un’altra strana coppia, due tizi con i capelli a caschetto e le giacche di pelle, perfetti per fare le controfigure in un documentario sui Byrds. I primi sono Karl Precoda e Russ Tolman. Precoda suona la chitarra nei Dream Syndicate (sono marci per i Velvet Underground, e siccome la sanno lunga hanno scelto come nome quello dell’ensemble sperimentale in cui aveva suonato John Cale prima di incontrare Lou Reed); Tolman è uno studente dell’Univeristà di Davis, dove invece che dare esami metteva dischi punk alla radio del college insieme a una ragazza dal fascino enigmatico, Kendra Smith, e a un giovanotto entusiasta, impallinato dei Creedence e delle garage band di Nuggets, vale a dire Steve Wynn. Insieme i tre avevano formato i Suspects, ma non erano andati da nessuna parte e le poche copie del loro unico 45 giri – Talkin’Loud/It’s Up To You, così riporteranno gli annali – le avevano gettate nel Pacifico per la disperazione. Ora Russ ha una nuova band, i True West, insieme all’ex batterista dei Suspects riciclatosi cantante, l’anglofilo (adora i Pink Floyd periodo Barrett, Echo & the Bunnymen e i Teardrop Explodes) Gavin Blair, e all’altro chitarrista Richard McGrath, con il quale prova fino a farsi sanguinare le dita gli assoli incrociati di Marquee Moon. Kendra e Steve adesso stanno nei Dream Syndicate con Karl.
E i due pseudo-Roger McGuinn? Si chiamano Sid Griffin e Stephen McCarthy: Sid viene dal Kentucky, va fuori di testa per il country-rock e il garage punk (è stato per un po’ negli Unclaimed di quel pazzoide di Shelly Ganz) ma non sa decidere cosa suonare tra i due. Fanculo, dice a Stephen, suoneremo country-rock e garage-punk: ora che ha trovato in lui il contraltare perfetto, è pronto a partire in quarta con la band, i Long Ryders (la “y”, chiaro, è un omaggio ai Byrds). Hanno provato a coinvolgere Wynn, ma lui ha preferito concentrarsi sui ‘Syndicate: meglio così, tanto “non sa fare neanche la seconda voce”. La battuta è di un ragazzetto segaligno, frangia sugli occhi e aria trasognata: è Michael Quercio. Alla high school lo sfottevano a morte perché in pieni anni Settanta si ostinava ad ascoltare i Beatles, cercando persino di convincere i suoi compagni agghindati come Tony Manero che gli unici Bee Gees buoni erano quelli di dieci anni prima. Fortuna che adesso è tra amici. A loro, increduli, sta racontando di come l’Esercito della Salvezza, nientemeno, lo abbia obbligato a cambiare il nome del suo gruppetto psycho-pop: niente più Salvation Army, d’ora in avanti saranno i Three O’ Clock. E che significa? Niente, è psichedelico.

(Three O’ Clock)
A proposito: ma le ragazze? Suona il campanello: eccole qua. Sono Vicky e Debbi Peterson insieme a quella conturbante brunetta di Susanna Hoffs. Manco a dirlo, anche loro suonano in un gruppo ispirato al pop degli anni Sessanta: tutte ragazze, loro tre più Michael Steele, che in confronto a loro è già una veterana per essere stata nelle Runaways di Joan Jett. Si chiamano Bangs. Le sorelle Peterson abitano a un isolato di distanza da due fratelli musicisti che conoscono da una vita, Dave e Steven Roback. Uno serioso e fascinoso chitarrista, l’altro bassista. Tanto per complicare ancora un po’ l’albero di famiglia, intorno al ’78-’79 suonavano con la Hoffs negli Unconscious. Visto che c’erano sono venuti anche loro, insieme al resto della band che guidano da qualche tempo, i Rain Parade.
Si stappano birre, si scherza, si parla di musica, di musica e poi ancora di musica. Lo stereo, naturalmente, è sempre acceso. I dischi li porta Steve, che lavora al negozio della Rhino. Tutta roba strepitosa, come sempre: prima c’erano su i Blasters, poi il nuovo dei Plimsouls, quel gruppo con Peter Case che sta spaccando nella scena dei club, giù a Los Angeles. Ora sta girando il primo degli Electric Prunes, un 1967 di quelli buoni, e quando parte Bangles Susanna esclama: “però, Bangles… come nome è molto meglio di Bangs, non trovate?”.
ALL OVER THE PLACE
“Un secondo dopo che avevo detto a un giornalista quella frase, Paisley Underground, me ne ero già pentito” (Michael Quercio)

Abbiamo romanzato un po’, ma neanche tanto. Doveva essere proprio così, agli inizi, la giornata tipo del nucleo di quella che diventerà la piccola tribù del Paisley Underground. Anzi, di tutto il Paisley Undeground. Un aspetto su cui concordano i ricordi dei membri delle band coinvolte nell’allegra brigata è proprio quella dimensione di famiglia estesa, di comunità anche un po’ naïf, nella quale lo stile di vita era ossessivamente incentrato sul rock’n’roll piuttosto che sugli altri due aspetti della trimurti dello sballo. Come ricordava Quercio in un’intervista del 1993 alla fanzine inglese Ptolemaic Terrascope, “niente sesso, niente droga, niente di niente. Eravamo monaci. Monaci e suore. Una volta andammo all’isola di Catalina, c’erano quasi tutti quelli della cerchia: i Salvation Army, le Bangles, i Dream Syndicate, i Rain Parade e qualcun altro. Campeggiamo sotto le stelle, ascoltammo un sacco di nastri, al mattino io con Steve Wynn e le sorelle Peterson andammo a cercare qualcosa da mangiare, riprendemmo la barca e tornammo a casa. Mi manca quel senso di comunità, non lo ritrovi più nelle band di oggi”. Curiosamente, lo stesso episodio è stato citato a chi scrive da Steve Wynn, per dare un’esempio dello spirito dei good old days, quando “si andava ognuno ai concerti degli altri e tra tutti ci si scambiava idee, sogni e collezioni di dischi”. Russ Tolman si emoziona ancora al ricordo di quell’adolescenza perduta, anche se ammette che “noi True West eravamo un po’ i cugini di campagna. Il nostro contributo stava nel trovare concerti su a nord per i nostri amici di L.A. Non so quante volte abbiamo suonato sullo stesso palco, in quei giorni”. Anche nella memoria di Sid Griffin il ricordo del periodo è quello di “una scena in cui ci si supportava a vicenda, e fondamentalmente ci si divertiva un sacco. Ma era tutto il panorama alternativo di L.A. a essere fantastico, negli ultimi anni Settanta e primi Ottanta. A Hollywood c’erano club favolosi ogni duecento metri, se eri in una band era facile trovare date per suonare e, wow!, avevi pure un’audience. Se non eri in una band, allora mettevi in piedi un’etichetta indipendente che magari stampava solo un paio di 45 giri, oppure scrivevi per una fanzine oppure lavoravi in qualche negozio di dischi figo come Rhino o Aron’s. Non ho mai più visto una scena come quella. La gente faceva dormire le band a casa propria, quando queste non avevano i soldi dell’albergo. Una notte mi ritrovai in casa Debbi Peterson, Eric Burdon, Billy Bremner dei Rockpile e quattro o cinque dei Celibate Rifles! Finché durò, fu un paradiso.”

(True West)
Era un circuito sotterraneo ma esteso, che comprendeva locali come il sempiterno Whisky Au-Go-Go “on the fabulous sunset strip”, il Music Machine a West Hollywood, il Madame Wong a Chinatown, il Penny Feathers su La Cienega Boulevard (i primi concerti delle band del Paisley si tennero quasi tutti lì). E poi riviste underground, label fai-da-te – Pvc, Frontier, Enigma, Slash/Ruby, la Down There dello stesso Wynn – e college radio. Ma a dare una mano ai nuovi gruppi in ascesa c’erano anche personaggi più istituzionalizzati, come i dj Phast Phreddie o il bizzarro Rodney Bingenheimer, il “sindaco del Sunset Strip” che fin dagli anni Sessanta animava il demi-monde pop di LA con i programmi sulla radio KROQ e le serate glam nel suo club English Disco, naturalmente sito sul Sunset. Un milieu scoppiettante, nel quale la musica giocava un ruolo predominante.
Su questo argomento le opinioni di Wynn e Griffin tuttavia divergono. Per quest’ultimo si trattava del miglior periodo dopo i tempi d’oro dei Sixties, secondo Steve invece “non era granché. Ok, a tutti noi piacevano i Gun Club, i Wall of Voodoo, i Black Flag, e personalmente amavo gruppi come gli Human Hands e i 45 Grave in cui suonava Paul Cutler, che qualche anno dopo entrò nei Dream Syndicate. A parte pochi nomi, però, il resto del panorama era noioso, stereotipato. Tutti ammanettati alla loro scena e al loro suono; erano spariti sia il senso del divertimento che il piacere di rompere le regole, quindi l’eredità migliore del punk. Credo che i Dream Syndicate e le altre band del Paisley fossero una boccata d’aria fresca perché eravamo innocenti e non avevamo la minima idea di ciò che stavamno facendo. E contrariamente a ciò che si può pensare, avevamo influenze musicali molto varie, nessuno di noi suonava simile agli altri. Non ascoltavamo solo psichedelia anni Sessanta: per noi sono stati altrettanto importanti i Fall e i Joy Division, così come mille altre cose, dal country al jazz”. Un punto sul quale si ritrovano felicemente, dopo tutti questi anni, è l’orgoglio per aver rappresentato qualcosa che andava consapevolmente contro la corrente di quel periodo. Di essere stati, per così dire, compagni in missione. Per conto, si intende, del rock’n’roll.
Wynn: “I gruppi del Paisley nacquero indipendentemente uno dall’altro, ma ci siamo ritrovati subito. Nessuno, dico nessuno suonava quel genere di cose all’epoca. Non solo garage o psichedelia o roots-rock, parlo proprio di musica con le chitarre! Sembrava così arcaico e old-fashioned. Per non parlare del feedback, dei drone, di tutte quelle stranezze che nessuno si aspettava più da un gruppo musicale e che noi più o meno coscientemente ci divertivamo a mischiare. In realtà non eravamo così intenzionalmente radicali. Volevamo solo fare la musica che ci piaceva e che non sentivamo più in giro. Ci fosse stato qualcuno che già suonava quel genere di cose, forse non avremmo neanche iniziato”. Tolman: “Eravamo militanti, certo. Combattevamo per il futuro delle chitarre! (risate, NdI.). Però era un po’ paradossale: da un lato c’erano queste band inglesi con i synth che dicevano ‘le chitarre sono morte’, dall’altro i gruppi di metal che ti facevano sperare che le chitarre morissero sul serio. Noi pensavamo che il suono chitarristico potesse ancora essere innovativo e vitale. La storia ci ha poi dato ragione, no?” Sid Griffin, da parte sua, la mette giù in modo ancora più “hardcore”: “Sì, eravamo consapevolmente contro le mode di quel periodo. Detestavamo i Kajagoogoo, gli Haircut 100, i Duran Duran, gli OMD, i Soft Cell e tutte quelle altre band di coglioni. Se guardi solo alla fama e alle classifiche hanno stravinto loro, ma io quella gente la odio ancora oggi. Odio il modo in cui suonavano, il modo in cui si vestivano, la loro musica del cazzo. Molte persone, all’epoca, non riuscivano neanche a concepire il fatto che suonassimo le chitarre e andassimo in giro con i capelli mediamente lunghi, giacche sfrangiate, pantaloni stretti e beatle-boots, e io dicevo: guardate i Byrds, guardate i Ramones… non sono infinitamente più eleganti di questa manica di deficienti che dominano le charts?”.

(The Long Ryders)
Visto che siamo in tema di look: il nome appioppato al movimento faceva riferimento ai tipici ghirigori dell’iconografia psichedelica che caratterizzavano una linea d’abbigliamento degli anni Sessanta, il paisley per l’appunto. Quanto all’underground… beh, va da sé. A farsi scappare la definizione fu Michael Quercio, in un’intervista del 1983 al Los Angeles Times che indagava su questa strana progenie di nuove band chitarristiche. Nel giro di poche settimane, con somma disperazione di Quercio, per la stampa musicale e l’intera industria discografica quelle band diventarono tutte, una volta e per sempre, “Paisley Underground”.
SONGS FOR THE DREAMERS
“The Long Ryders wish success and happiness to all bands” (dal retrocopertina di State Of Our Union dei Long Ryders)
Nel suo monumentale Rip It Up And Start Again (nell’edizione italiana Post-Punk 1978-1984, ISBN), Simon Reynolds dedica al fenomeno la miseria di una riga e mezzo, liquidandolo con un sintetico “Il Paisley Undeground losangelino, con band retro-psichedeliche come i Dream Syndicate e i Rain Parade”, giudicandolo evidentemente meno importante di gruppi fondamentali come i Frankie Goes To Hollywood. Un po’ snob, ma essendo il grande critico che è si fa perdonare con una considerazione illuminante sul virus “rétro” che aveva colto la musica alternativa in quel periodo. “Certo, la musica degli anni Sessanta possedeva particolari qualità – apertura cosmica, abbandono dionisiaco, una certa libertà esecutiva – che la rendevano appetibile e rinvigorente per chi usciva da un lungo periodo di musica rigida, iperrazionale e concettuale. Dopo le demistificazioni post-punk e lo schematismo ‘new pop’, era un sollievo riascoltare musica radicata nella soggezione mistica e nell’abbandono trasognato. Il post-punk aveva messo al bando ampi settori della musica, bocciati perché troppo sballati, troppo eccessivi, troppo pirotecnici. Scoprire la possibilità di godersi un assolo di Jimi Hendrix fu un’esaltante rivelazione: il brividio del frutto proibito”. Non solo nostalgico revivalismo, quindi. Il ritorno di interesse verso i Sixties, sorto a cavallo tra Settanta e Ottanta anche in seguito ad avvenimenti casuali e molto diversi tra loro (il decennale di Woodstock, la pubblicazione della biografia di Jim Morrison No One Here Gets Out Alive, la fiammata neo-mod seguita al film Quadrophenia, la morte di John Lennon) si era instillato nella visione musicale nei gruppi della seconda generazione post-punk, soprattutto in California: dagli X ai Blasters, dai Flesheaters di quel personaggio incredibile chiamato Chris D (produttore tra le altre cose di The Day Of Wine And Roses) ai Gun Club, dai Wall of Voodoo al…Paisley Underground. Una forma di reazione, come sostiene acutamente Reynolds, ma anche un riappropriarsi del passato per guardare avanti, come dicevano qualche riga più su Wynn e Tolman. Senza bisogno di “demistificare” alcunché o di ricorrere a sterili provocazioni concettuali. A riascoltare molti dei dischi di quegli anni, e in particolare quelli delle Paisley-band, si respira ancora oggi un’aria di gentile serenità, di voglia di (ri)costruire sulle macerie che non mitiga affatto il fremito elettrico e giovanile che li attraversa. E con una certa eleganza formale che non contrastava affatto con le radici punk di quasi tutti i musicisti coinvolti.
I primi e forse più significativi album del Paisley Underground, quelli usciti tra il 1982 e il 1983, manifestano tutti questo tentativo di unire opposti inconciliabili, ed è perciò che suonano ancora freschi, vitali, emozionanti. Per i Long Ryders del mini 10-5-60 e di Native Sons erano i “Clash mischiati con i Buffalo Springfield”; per i True West di Hollywood Holiday un tentativo di “garage-jazz, una musica chitarristica che traesse spunto dai Television come dai Quicksilver Messenger Service”; per i Dream Syndicate del mini omonimo e di The Days Of Wine And Roses le suggestioni velvettiane unite alla furia del punk; per i Green On Red dell’ep Two Bibles e di Gravity Talks le nuova visione del roots-rock alla X/Gun Club miscelate a memorie Doors; per i Rain Parade di Emergency Third Rail Power Trip il raga-rock byrdsiano speziato di wave (e con inconsapevoli prodromi di dream-pop e shoegazing a venire). Persino le Bangles, che nel loro esordio sulla lunga distanza All Over The Place coverizzavano sia i Merry-Go-Round che Kimberly Rew dei Soft Boys, cercavano un punto di contatto tra i ’60 dei Mamas And Papas e le nuove istanze pop degli ‘80. Ciò che è importante notare è che la neopsichedelia, quando c’è, è spogliata di qualsiasi rimasuglio freak e si rifà comunque alla tradizione della California del sud. Se lo stile di vita comunitario e solidale poteva ricordare vaghissimamente la San Francisco hippy, non vi è traccia alcuna di essa nella musica (tolti forse i Moby Grape, l’unica band di Frisco adorata indistintamente da tutti).
Al di là della musica, le radici culturali dei gruppi Paisley erano tutt’altro che banali, con riferimenti letterari e cinematografici che andavano dal beat degli anni ’50 all’hard-boiled, dall’Hollywood dei tempi d’oro all’immaginario western. Influenze smascherate già dai nomi delle band e dai titoli di dischi e canzoni. Days Of Wine And Roses era un film di Blake Edwards con Jack Lemmon e Lee Remick, The Lost Weekend (Giorni perduti) un indimenticabile Billy Wilder del ’45 che (come il precedente) parla di alcolismo, Long Riders (I cavalieri dalle lunghe ombre) un western crepuscolare di Walter Hill, True West una delle prime commedie di Sam Shepard. L’indizio forse più rivelatorio di tutti è il brano Songs For The Dreamers, dall’album del “supergruppo Paisley” Danny & Dusty, nel quale si citano Pearl S. Buck, Jackie Kennedy, Jim Thompson, Count Basie, Raymond Chandler. Nostalgia, anche in questo caso?
TELL ME WHEN IT’S OVER
“..I can lose everything, in a minute or two…” (Dream Syndicate, When You Smile)

Volendo continuare a baloccarsi, un po’perversamente, con il parallelo tra anni Ottanta e Sessanta, si potrebbe dire che se il biennio 1982-83 è paragonabile mutatis mutandis al 1965-66 – si pongono le basi, si esce allo scoperto tutti assieme con dischi belli e fondanti -, il 1984 e il 1985 sono stati invece il mitico ’67 del Paisley. Il periodo, breve ma intensissimo, in cui si consolida il fenomeno e si raccolgono i primi frutti. Ma anche quello in cui si viene cannibalizzati dalla stampa e dal business, si attirano imitatori e si innescano i presupposti del declino. In quei due anni escono ancora album favolosi (Medicine Show dei Dream Syndicate, State of Our Union dei Long Ryders, Gas Food Lodging dei Green On Red) o comunque più che dignitosi nonostante turbolenze nelle line-up e problemi di varia natura (Explosions In the Glass Palace dei Rain Parade, Drifters dei True West, Arrive Without Travelling dei Three O’ Clock). Ci si permette anche di auto-celebrarsi, con un paio di opere collettive che fungono da veri e propri manifesti dei due aspetti della sensibilità Paisley: quella più incline al torpore lisergico e al culto delle memorie (Rainy Day, una “gita al faro” al suono di canzoni di Hendrix, Who, Velvet, Byrds, Beach Boys, Big Star ecc.) e quella più rude, roots e mondana (il pluricitato The Lost Weekend di Danny & Dusty, ovvero Stuart & Wynn più Long Ryders, Dream Syndicate e Green On Red vari). Il secondo è forse il disco più amato, retrospettivamente, dai reduci del movimento. Persino Tolman, che non vi partecipò, lo ritiene il suo preferito: “un lampo di innocenza, un gruppo di amici che si divertono a suonare insieme solo per il piacere di farlo”. Wynn e Griffin sostengono di averci lasciato il cuore, su quei solchi, ma di non aver troppi ricordi delle session a causa dei “fiumi di alcol che scorrevano”.
È forse qui l’apice della parabola Paisley, termine che nel frattempo ingloba diversi altri gruppi più o meno legati al nucleo originario: da precursori ancora attivi come Last e Droogs ai duri Leaving Trains, dai Naked Prey dell’ex Serfers Van Christian ai Blood On the Saddle che vedono in formazione la cantante Annette Zilinskas già bassista nelle Bangs, dai Romans allo stralunato e geniale popparolo Scott Miller con i suoi Game Theory. Qualcosa però stava cominciando a sfaldarsi. Secondo Wynn “il movimento si dissolse quando iniziammo ad andare in tour tutti quanti. Seconda metà del 1983, più o meno. La cosa sfuggiva dalle nostre mani e diventava proprietà del mondo. Non c’era nulla di male in questo, ma come in tutti i casi in cui aumentano le responsabilità e gli impegni, finisci col perdere lentamente i contatti con gli amici con cui sei cresciuto”.
Iniziano le defezioni e le scissioni. Tolman lascia i True West dopo Drifters, Roback molla i Rain Parade prima di Explosions In The Glass Palace, Precoda se ne va dai Dream Syndicate dopo aver marchiato a fuoco con la sua chitarra Medicine Show. Kendra Smith aveva salutato la band addirittura prima, insofferente dei ritmi crescenti imposti dal music business e desiderosa di seguire la sua idea di psichedelia libera, influenzata più dai Can o da Terry Riley che dal rock tradizionale verso cui si indirizzava sempre più il movimento. Proverà a cercarla nei Clay Allison e poi nei meravigliosi Opal, insieme a Roback. Ma c’erano anche altri fattori negativi in gioco. Ad esempio il bacio mortale delle major. I gruppi Paisley sono i primi, tra i portabandiera del rock indipendente, a finire su grandi etichette – A&M per i Dream Syndicate, Island per Long Ryders e poi Rain Parade, Parlophone per i Green On Red a partire da No Free Lunch; solo i True West rimarranno al palo – precedendo di qualche anno i tanto commentati “cambi di casacca” di Husker Du, R.E.M. e Sonic Youth. Durerà poco, e sarà disastroso per tutti. La differenza tra il prima e il dopo sta tutta in queste parole di Wynn: “Per fare Days Of Wine And Roses, tra incisione e missaggio ci abbiamo messo tre notti. Per registrare Medicine Show, sei mesi”.
In quel periodo, comunque, il Paisley sbarca in Europa – l’”American Invasion of 85”, secondo la definizione velatamente ironica dei giornali britannici – dove li accoglie una rete di fan ricettiva quanto e forse più che negli States. Grazie anche al supporto di fanzine interamente dedicate alla causa del nuovo rock chitarristico come la francese Nineteen e soprattutto l’inglese Bucketfull Of Brains, che seguì maniacalmente l’evoluzione del fenomeno, tanto che nomi di giornalisti come Nigel Cross, Jon Storey e l’ubiquo Jud Cost sono rimasti nella memoria degli appassionati quasi quanto quelli di Dan Stuart o Karl Precoda. In Italia, una volta tanto, non fummo da meno: la stampa musicale specializzata (Mucchio Selvaggio, Rockerilla, Buscadero) riservò sempre molto spazio alla neopsichedelia in generale e al Paisley in particolare, e addirittura il più maistream Rockstar gli dedicò uno special in un numero del marzo 1985.

Griffin: “Suonare in Europa fu un’esperienza magnifica. La maggior parte di noi non ci aveva mai messo piede prima di allora. Molti di coloro che vennero a quei concerti non hanno mai smesso di seguirci. Purtroppo in Inghilterra i Long Ryders erano solo la seconda indie band più popolare, dato che c’erano sempre gli Smiths tra le palle”. Ciò che alle platee europee – Italia compresa – sembrò un movimento compatto si stava in realtà sgretolando.
Il 1986 e il 1987 sono gli anni in cui la china si fa verticale. I Dream Syndicate rimangono senza contratto e sono sul punto di sciogliersi, poi con l’entrata del chitarrista Paul B. Cutler e del bassista Mark Walton pubblicano un disco mediocre come Out Of The Grey (nonostante la presenza di un inno come Boston) e nel 1988 il più solido Ghost Stories, dopo il quale sciolgono le fila. I True West e i Rain Parade si dissolvono ancora prima, mentre i Green on Red continueranno fino a metà anni 90 lungo la strada di un rock sempre più tradizionale e sempre meno ispirato. Il sodalizio tra Sid Griffin e Stephen McCarthy si interrompe invece bruscamente nel 1987, appena terminato quello che rimarrà l’ultimo album di studio dei Long Ryders, il piacevole Two Fisted Tales. E il vecchio Michael Quercio? Lui finisce addirittura – una nemesi! – alla Paisley Park, regno privato di quel Prince che intanto aveva firmato sotto pseudonimo Manic Monday, il pezzo che rese le Bangles delle star. L’unico caso in cui il Paisley diventò “Overground”. Era del resto scritto nel loro destino: le brave ragazze vanno in paradiso, quelle cattive vanno dappertutto, ma quelle carine di sicuro vanno in classifica. L’ultimo grande disco del movimento lo firmano nel 1987 gli Opal, con Happy Nightmare Baby. Nella primavera dell’88, le sparute truppe di fanatici del Paisley si riuniscono per andarli a vedere durante il loro tour italiano. Sul palco con Roback non c’è Kendra Smith, ma una sorta di Nastassja Kinski californiana di nome Hope Sandoval. Sono nati i Mazzy Star. In compenso è finito tutto il resto. Ma c’è ancora tempo per un un ultimo hurrà. Nel 1989, a band ormai sciolta, esce Live At Raji’s dei Dream Syndicate: è il Paisley che svanisce tra il crepitare di chitarre mai così elettriche, libere, devastanti, in un finale di partita di una bellezza quasi straziante. Un concerto che è Last Waltz e Happy Trails e Kick Out The Jams e Live At The Max’s e i Pistols al Winterland e tutto ciò che ci scaldava le viscere e il cuore. Non mi vergogno nel dire che è il mio disco dal vivo preferito di ogni tempo e di ogni genere musicale, nonché quello che consiglierei a un amico per capire cos’è stato il Paisley Underground.
RAINY DAYS, DREAM AWAY
“Guardandomi indietro, credo che quei giorni siano stati il periodo più bello della mia vita. Perché? Ma per la più egoistica delle ragioni: perché ero giovane. Lo eravamo tutti”. (Matthew Broderick in Biloxi Blues, 1988)

(Kendra Smith e David Roback, 1985)
Non ci fu una Woodstock per il Paisley. Grazie a dio, neanche una Altamont. Nessun dramma (a parte la scomparsa prematura del bassista dei True West, Kevin Staydohar), nessuna amicizia tradita. I protagonisti di allora hanno continuato a fare musica, in molti casi eccellente, ritrovandosi di tanto in tanto. Mantenendo a modo loro un legame che in fondo è indissolubile, quello tra vecchi compagni d’armi in una guerra mai iniziata, e che comunque avrebbero perso. O forse no. Lasciamo l’ultimo ricordo a Steve Wynn: “Non posso che avere una percezione meravigliosa di quegli anni. Si bruciò tutto in breve tempo, ma era eccitante essere giovani, ascoltare il master del tuo primo disco, andare in tour per la prima volta, vedere che altre band che amavi e che erano formate da tuoi amici stavano vivendo le stesse esperienze. Il brivido della scoperta, la sensazione che niente può andare storto erano davvero intossicanti. E credo che ciò che facemmo allora, insieme ad altre band in altre città allo stesso tempo, aprì realmente la strada a quello che poi sarebbe diventato l’indie-rock.”
Nelle prime pagine di Our band could be your life, fondamentale storia del rock americano indipendente degli anni 80, l’autore Michael Azerrad ricorda il commento della giornalista Gina Arnold quando i Nirvana di Nevermind cacciarono a pedate Michael Jackson dal numero uno di Billboard. Solo una frase: “Abbiamo vinto”. Una piccola parte di merito per quella vittoria (effimera, ma tant’è) spetta anche a quei bravi ragazzi e quelle brave ragazze del Paisley Underground. A quelle band che, anche solo per un attimo, sono state davvero la nostra vita.
Grazie infinite per la disponibilità a Sid Griffin, Russ Tolman e Steve Wynn.
In memoria di Giorgio Borri, cuore paisley.
(originariamente pubblicato su Mucchio Extra n. 27, autunno 2007)

Paisley Underground: 20 dischi (1982-1987)
DREAM SYNDICATE – The Day Before Wine And Roses (Normal, 1994)
Il Paisley allo stato nascente. Come indica il gioco di parole del titolo, siamo a ridosso dell’esordio dei Dream Syndicate. 5 settembre 1982: negli studi ZZZ di North Hollywood, al cospetto di un pubblico esiguo ma selezionato (presente lo stato generale del movimento, dai Rain Parade ai Green On Red alle Bangles, ma anche i R.E.M in visita di cortesia), Steve Wynn e compagni regalano alla radio KPFK un’anteprima anfetaminica e splendidamente psichedelica di ciò che verrà. Suoni crudi e taglienti come si conviene a quattro ventenni fomentati dall’aver appena finito il loro primo disco, con il punk dietro l’angolo e l’estasi lisergica a un passo. L’”underground” più che paisley è vellutato, come dimostra la narcotica Some Kinda Itch, il noise pronto a deflagrare di That’s What You Always Say e una John Coltrane Stereo Blues in embrione (intitolata Open Hour) che si contorce all’ombra di Sister Ray. Per tacere delle cover allucinate di Mr. Soul (Buffalo Springfield), Outlaw Blues (Dylan) e Season Of The Witch (Donovan), e del chitarrismo tanto rozzo quanto visionario del magnifico Karl Precoda.
THREE O’ CLOCK – Baroque Hoedown (Frontier, 1982)
Il vaso di coccio del movimento? In molti lo consideravano tale, il buon Michael Quercio. Forse perché troppo delicato e sognatore per quei tempi rudi – ehi, si stava facendo una rivoluzione, o almeno si credeva di farla -, forse perché la sua vocina efebica era la prova lampante che il punk dalle sue parti non era mai passato, lasciandolo lì a crogiolarsi in cameretta con le sue fantasie sul Sunset Strip del ’66. In realtà il ragazzo meritava rispetto, e non solo perché in fin dei conti il Paisley Underground lo aveva battezzato lui. Questo delizioso ep prodotto da Earle Mankey, uno che stava negli Sparks, fu a modo suo fondamentale per la scena che stava andando a crearsi, rappresentandone l’ala innocente e delicata, devota al sixties pop più frivolo (per esempio quello degli Easybeats, dei quali si riprende Sorry), così come alle tintinnanti vestigia byrdsiane. E con tanto, tanto, tanto ammmore: a chi non farebbero girare la testa una Cantaloupe Girlfriend o una Marjorie (Tells Me) come quelle cantate da Quercio? Poco a poco la melassa prenderà il sopravvento, ma il successivo Sixteen Tambourines è ancora essenziale.
DREAM SYNDICATE – The Days Of Wine And Roses (Ruby, 1982)
La prima pietra miliare del Paisley. Registrato nel giro di tre giorni sotto la supervisione del luminare punk-roots Chris D (che aveva appena girato le manopole per i Gun Club e i Misfits, e si sente), l’album cattura con una vividezza straordinaria l’entusiasmo di quei giorni, mantenendosi venticinque anni dopo ancora inebriante come il buon vino e profumato come un mazzo di rose. Dall’attacco jangle di Tell Me When It’s Over al delirio che chiude in un vortice di eletticità e feedback la title track (hardcore dal volto umano?), The Days of Wine And Roses è un fluire irrefrenabile di emozioni. Proprio quei brividi che si credeva le chitarre non potessero più innescare, all’alba degli anni 80. Ci sono i Crazy Horse, ci sono i soliti irrinunciabili Velvet (When You Smile), ma a ben guardare si scorgono pure i Fall e i Sex Pistols, nonché un basso tondo di scuola post-punk a coprire le fughe in avanti delle sei corde. Quello che manca è un attimo di respiro: Halloween, Until Lately, Definitely Clean trasmettono una positiva, adolescenziale voglia di perdersi nel rumore, e solo la voce di Kendra Smith in Too Little, Too Late rallenta il tiro. Che disco, che canzoni. Non a caso Steve Wynn se le porta in tasca da un quarto di secolo. Nella ristampa Rhino del 2001 si trova anche il primo ep omonimo e il 45 giri dei 15 Minutes, con la versione grezza di That’s What You Always Say e Last Chance For You.
TRUE WEST – Hollywood Holiday Revisited (Atavistic, 2007)
Altro caposaldo, questo. I True West di Russ Tolman erano, tra gli alfieri del movimento, quelli che forse sapevano coniugare al meglio fisicità e poesia, muscolatura rock e mente libera, gli angoli bui della città e gli orizzonti imprendibili del deserto. Simili, in questo, forse più ai concittadini Thin White Rope che agli amichetti paisley di Los Angeles, con i quali tuttavia condivisero in pieno luoghi, tempi, concerti, buone e cattive vibrazioni. Del tutto singolare, comunque, la sintesi di influenze che animava gli insistiti fraseggi psichedelici della band, nonostante il nome la più “inglese” del lotto. Formidabili davvero, le canzoni dell’esordio Hollywood Holiday: roba che teletrasporta i Pink Floyd dell’Ufo Club nello smog delle notti californiane, e non solo per la cover – molto simile all’originale, complice la voce barrettiana di Gavin Blair – di Lucifer Sam. Ma sono dei Floyd passati al setaccio dei Television (Tom Verlaine avrebbe dovuto produrre il secondo album, ma si defilò subito) e degli Stooges (I’m Not Here è una 1969 riveduta, corretta e inacidita), filtrati da una sensibilità vagamente crepuscolare capace tuttavia di librarsi altissima (la splendida And Then The Rain). Ottimo, benché meno febbrile, anche il successivo Drifters. Questa freschissima ristampa contiene entrambi, insieme ai tre demo incisi con lo schizzinoso Verlaine.
UNCLAIMED – The Unclaimed (Hysteria, 1983)
Facciamo un salto in garage. Genere non molto frequentato dalle band del Paisley, nonostante l’innegabile contiguità con i cugini neo-Sixties che proprio nello stesso periodo stavano impazzando a est (Fuzztones, Chesterfield Kings, Fleshtones) e a ovest (Miracle Workers, Morlocks). Benché la venerazione per i ‘60 li accomunasse, l’attitudine dei gruppi Paisley non aveva i tratti ossessivi dei “garagisti”. Gli Unclaimed di Shelley Ganz sono forse l’unica band che stava a cavallo tra i due ambienti, anche se più per ragioni di “albero di famiglia” (Sid Griffin aveva militato nella primissima formazione) che eminentemente musicali. Il calendario di Ganz, strana figura di monomaniaco, come si evince da questo mini-lp è fermo al ’66. Massimo, toh, al gennaio del ’67. Sei brani comunque molto divertenti, tra Chocolate Watchband, Castaways, frat-rock e pure un goccio di exotica. Da ricordare soprattutto Lost Trails, anche perché darà il nome a una leggendaria fanzine di casa nostra.
RAIN PARADE – Emergency Third Rail Power Trip (Enigma, 1983)
Dove portavano quelle mongolfiere ritratte in copertina? Ma che domanda: otto miglia in alto, dritto nella quinta dimensione. Non c’era alcun dubbio allora e non c’è adesso alla prova del riascolto: sono i Byrds del ’66-’67 i numi tutelari di questo esordio dei Rain Parade. I Byrds che si erano lasciati alle spalle il folk-rock e che, prima di scoprire il country, per un anno o poco più sognano un Oriente dell’anima a tempo di raga-rock e psichedelia. Se c’è un disco Paisley capace di far sognare, in effetti, è proprio questo. Un incantesimo gentile, un profluvio di essenze e aromi che irretisce benevolmente la volontà, ottunde i sensi, appaga il desiderio di fuga verso un altrove inesistente e tuttavia continuamente agognato. Talking In My Sleep, What She’s Done To Your Mind, Kaleidoscope, This Can’t Be Today: i titoli parlano da soli. La musica è allo stesso tempo tramite e conseguenza (com’era quella frase? taking drugs to make music to take drugs to? ecco, appunto…) di uno stato narcotico, non importa se indotto o naturale. Le voci vellutate, gli intrecci rigogliosi di chitarra, il violino di Will Glenn, le melodie avvolgenti: tutto rende questo album un’esperienza sensoriale unica e caleidoscopica. Non siamo poi tanto distanti da quel che David Roback farà anni dopo con i Mazzy Star. E ancor più vicini sono i Clay Allison/ Opal: l’annuncio della nuova band è nella voce di Kendra Smith, ospite in This Can’t Be Today.
GREEN ON RED – Gravity Talks (Slash, 1983)
Tutta un’altra dimensione, invece, quella dei Green On Red. Più terrena, aspra, molto meno disposta alle fughe verso colorati paradisi lisergici. Non inganni l’onnipresente organo di Chris Cacavas: è vero che con quel tappeto continuo sotto i piedi le canzoni possono ricordare i Doors e più ancora i Seeds, ma sono piedi sporchi di polvere e di scarpinate on the road. La mitologia personale di Dan Stuart ha più a che fare con Faulkner; Steinbeck e Dos Passos che con Ginsberg o Burroughs, anche se la sua tendenza all’osservazione del sociale, leggermente venata di romanticismo populista – tipica dell’americano di sinistra: si pensi a un John Fogerty, per dire uno dei modelli (inizialmente non dichiarati) di Stuart – si accentuerà a partire dai lavori successivi. Psichedelia o no, comunque, le canzoni di questo esordio lasciano un segno indelebile: profonde e ipnotiche come gli intrecci di chitarre e tastiere, espressive e alcoliche come la voce del leader, letterarie e cinematografiche come i loro titoli (Brave Generation, 5 Easy Pieces, Abigail’s Ghost). Su tutti, due brani che danno l’idea degli estremi tra i quali si muove il suono dei Green On Red: Cheap Wine (se ne ricorderà qualcuno anche in Italia) e Narcolepsy.
AA.VV. – Rainy Day (Rough Trade, 1983)
Il vero dazebao della sensibilità Paisley. Un manifesto sussurato, una wonderland pastorale dove tutto – la musica, le parole, i ricordi – possiede i colori sfumati dell’autunno. Niente più, in fondo, che un gruppo di amici (membri di Dream Syndicate, Three O’ Clock, Rain Parade, Bangles) che omaggiano un passato mitico e nel contempo fanno i conti con le loro ossessioni. Disco di una semplicità estrema, Rainy Day, ma dalla seduzione e dal potere incantatorio incredibili (e, purtroppo, anche un po’ difficile da trovare oggidì). Fa sorridere, e intenerisce, ascoltare la voce da ragazzina di Susanna Hoffs confrontarsi con lo spettro di Nico nella dylaniana I’ll Keep it With Mine e nella velvettiana I’ll Be Your Mirror, così come commuove quella più profonda di Kendra Smith che in un indovinato gioco delle parti si misura con Alex Chilton (Holocaust, che anticipa di un anno la rilettura dei This Mortal Coil) e Neil Young (Flying On The Ground Is Wrong). Ma tutti sono a loro agio, l’atmosfera è quella giocosa del giorno di vacanza: e così ecco Michael Quercio destreggiarsi perfettamente con John Riley dei Byrds e Sloop John B dei Beach Boys, mentre David Roback lasciare andare la chitarra alle morbide divagazioni hendrixiane di Rainy Day, Dream Away. Una giornata uggiosa, sì. Ma indimenticabile.
LONG RYDERS – Native Sons (Frontier, 1984)
Non ci avevano neanche provato, i Long Ryders, a spacciarsi per psichedelici. Il massimo della concessione all’iconografia Paisley era la camicia indossata dal bassista Des Brewer sulla copertina del mini-lp 10-5-60 (contenuto nelle successive ristampe di Native Sons). Certo, erano amici, anzi fratelli di sangue, di quei bravi ragazzi di Wynn, Roback, Tolman, Precoda ecc., ma la vicinanza era puramente affettiva, non musicale. Decisamente più affine la visione tradizionalista di compadre Dan Stuart e dei suoi Green On Red; eppure, nell’esordio della band di Sid Griffin e Stephen McCarthy non si avverte neanche l’ombra delle trame ipnotiche che si agitavano sul muro di Gravity Talks. La loro musica carbura con le anfetamine e non con l’acido, il terreno di battaglia è il country-rock puro e semplice. Corretto quel tanto dalle ascendenze punk di Griffin, ma senza esagerare. La foto della cover dice già tutto: evviva i Byrds di Sweetheart Of The Rodeo (è la voce di Gene Clark a guidare la bellissima Ivory Tower) evviva i Flying Burrito Brothers di papà Gram Parsons (il produttore è lo stesso dei loro dischi), ma soprattutto triplo hurrà per i Buffalo Springfield, dei quali si “coverizza” la copertina del mitico bootleg Stampede. Quante volte si saranno ascoltati questo disco, Jeff Tweedy e Jay Farrar?
LEAVING TRAINS – Well Down Blue Highway (Enigma, 1984)
Per il Paisley sono transitati anche personaggi che passavano di lì e visto che non avevano niente da fare si sono accodati, ma che con lo spirito del movimento avevano poco in comune. Uno di questi è “Fallin” James Moreland, cazzutissimo boss dei Leaving Trains. Radici punk che affondano all’immediato post-’77, forma i Downers con David Roback (eccola qui la connessione “paisleyana”) e successivamente i Leaving Trains, con i fratelli Hofer (Tom al basso, Manfred alla chitarra) e l’affascinante e misteriosa tastierista Sylvia Juncosa (poi nei To Damascus e per un brevissimo periodo nei Clay Allison). In questo primo album della band, Moreland – che intanto ha sposato un’allora sconosciuta cantante punk chiamata Courtney Love – cerca volonterosamente l’allineamento con le traiettorie psych della scena, tenendo a freno l’istinto da rocker puro e duro. I risultati sono notevoli, ma tempo un paio di anni e i Leaving Trains passeranno alla Sst dando libero sfogo, in album come Kill Tunes e Fuck, all’istinto animalesco del loro leader.
BANGLES – All Over The Place (Columbia, 1984)
Ah, le Bangles! Arduo trovare un lato glamour del Paisley, ma se c’era stava tutto nei visini, nelle minigonne, nelle acconciature tragicamente anni 80 di Susanna Hoffs e colleghe. Molto più vintage quelle della Rickenbacker che sorella Suzie tiene in grembo sulla copertina di questo esordio. Anche la musica, del resto, è invecchiata meglio del look. Il pop, questo genere di pop, non ha data di scadenza: va bene nel 2007 come nell’84 o nel ’67. E benché sul successo mainstream del quartetto avrebbe scommesso chiunque (rimanga tra noi: Different Light, quello con le famigerate Manic Monday e Walk Like An Egyptian, è ancora un gran bel dischetto) le ragazze facevano di tutto per farci capire che erano cresciute con il rock’n’roll. Le Bananarama, per dire, non suonavano certo cover di Emitt Rhodes (Live) o di Kimberley Rew dei Soft Boys (Going Down To Liverpool). E pure l’energia di Hero Takes A Fall (dedicata a Steve Wynn da una avvelenata Hoffs), il powerpop di All About You e Dover Beach e i vocalizzi da beach girls della barocca More Than Meets The Eye ci assicuravano che le Bangles erano dei nostri, nonostante il coiffeur. La via di mezzo tra i Mamas & Papas e le Go-Go’s, tra Riot On Sunset Strip e Cercasi Susan disperatamente.
DREAM SYNDICATE – Medicine Show (A&M, 1984)
Centocinquantanove dollari e novantanove centesimi. È questa la valutazione, secondo l’All Music Guide, di Medicine Show nella ristampa in cd pubblicata dalla A&M agli inizi degli anni ’90 (cui era abbinato anche il successivo mini dal vivo This Is Not The New Dream Syndicate Album… Live!). Per poco meno di un terzo del prezzo, sbattendosi un po’, ci si mette in casa il vinile originale. Pleonastico, quindi, dire che questo disco si deve ascoltare sul sacro supporto, non fosse altro che ascoltarlo diversamente è impossibile. L’irriperibilità del capolavoro dei Dream Syndicate danna l’anima di Steve Wynn da anni, ma paradossalmente può avere contribuito a forgiarne lo status quasi mitico. Ma no, cazzate. Basta la musica ad assicurare qualcosa che assomiglia all’immortalità a canzoni come Bullet With My Nome On It e Merrittville, Still Holding On To You e Daddy’s Girl, l’epica title-track e la jam infinita di John Coltrane Stereo Blues (ispirata, più che dal jazz, dalla Butterfield Blues Band di East/West). Medicine Show è uno di quei dischi che incroci una volta e te lo porti dietro per sempre: you can feel it in your heart/feel it in your soul/feel it go around/till you lose control…don’t you feel it burn?, proprio come canta Steve in una delle sue canzoni più belle di sempre. E dire che all’epoca ci fu chi si lamentò per la svolta rock bollata come “springsteeniana” (vero, ma c’erano anche i Crazy Horse, i Quicksilver, Lou Reed), chi non sopportava il piano di Tommy Zvonchek, chi lanciava strali all’indirizzo del produttore Sandy Pearlman (“quello che aveva già rovinato i Clash!”). Poveretti. Andate alla caccia di questo disco, e se già lo avete mettetelo su. Adesso. Non lo sentite bruciare?
OPAL – Early Recordings (Serpent/Rough Trade, 1989)
Il lascito discografico a 33 giri degli Opal, il progetto messo in piedi da Kendra Smith e Dave Roback dopo le rispettive uscite da Dream Syndicate e Rain Parade, si limita al superbo Happy Nightmare Baby (vedere qualche riga più sotto), ma per completare il quadro è essenziale anche questa raccolta della Rough Trade, pubblicata quando Kendra si era ritirata chissà dove e il gruppo si era già trasformato in Mazzy Star. L’album riunisce i singoli e gli ep, più altre canzoni inedite, incise prima dell’esordio sulla lunga distanza (alcune sotto la denominazione Clay Allison). Con un po’ di elettricità in meno, siamo sugli stessi, altissimi livelli. Psichedelia mistica che ipnotizza senza scampo (Fell From The Sun, meravigliosa), romanticismo acid-folk e languori acustici (Strange Delight, Empty Box Blues), ballate dark ferme a una invisibile frontiera tra Oriente e Occidente (Lullabye, Brigit On Sunday). Incantevole.
RAIN PARADE – Explosions In the Glass Palace (Enigma, 1984)
Come avevano reagito, nel frattempo, i Rain Parade alla dipartita del loro chitarrista principe? Con l’arruolamento dell’eccellente John Thoman e con uno scatto d’orgoglio, destinato tuttavia a esaurirsi in fretta. Explosions In the Glass Palace dura poco più di una ventina di minuti, ma è l’ultimo scampolo di magia regalato dalla band, prima di un live raffazzonato, un terzo album ricco in fatto di budget (approdano anche loro, come i Long Ryders, alla Island) ma poverissimo di idee quale Crashing Dream, e infine il dissolversi e disperdersi in altri progetti. Il ricordo di un gruppo fantastico durato troppo poco resta perciò appigliato alle malìe di Emergency…, ma canzoni come You Are My Friend, Blue e l’esotica No Easy Way Down non hanno nulla da invidiare, con i loro intarsi chitarristici, a quelle dell’esordio.
GREEN ON RED – Gas Food Lodging (Enigma, 1985)
Paradossale a ripensarci, ma l’unica elemento in comune tra la California dei ’60 e l’America di vent’anni dopo aveva un nome e cognome ben preciso: Ronald Reagan. Governatore dello stato californiano nei sixties, presidente degli Usa negli ’80. Era tutta lì, l’eredità dei favolosi anni Sessanta? In un vecchio ex-attore ultraliberista e destrorso? Dan Stuart è il primo a rendersi conto che le nostalgie della summer of love non sono certo il mezzo più idoneo per raccontare una realtà come quella degli States, fatta di impoverimento delle classi medie, reaganomics imperanti e cinismo ai massimi storici. Via le camiciole paisley, allora, e diamoci dentro con un rock proletario e diretto, sulle orme dei Fogerty e degli Springsteen. Gas Food Lodging è un tentativo di trasporre in musica l’epos americano della strada, dei misfits, della solidarietà tra reietti. Qualcuno la chiamò normalizzazione, ma cavalcate appassionanti come That’s What Dreams Are Made For, Sea Of Cortez, Easy Way Out e Sea Of Cortez picchiano ancora duro, grazie anche alla chitarra senza fronzoli del nuovo arrivato Chuck Prophet. L’adesione ai canoni tradizionalisti verrà poi formalizzato, nello stesso 1985, da No Free Lunch, primo disco su major.
DANNY & DUSTY – The Lost Weekend (A&M, 1985)
Venite tutti, voi perdenti e sognatori, fuorilegge e ubriaconi: venite qua al bancone, stasera offrono Danny e Dusty. Frutto di una jam-session ad alto tasso alcolico durata, per l’appunto, un intero weekend, questo disco vede all’opera una sorta di dream-team del Paisley Undeground: ci sono Dan Stuart (Danny) e Steve Wynn (Dusty), Chris Cacavas, Dennis Duck e tre quarti dei Long Ryders. Se Rainy Day era stato il manifesto dell’anima trasognata e psych del movimento, Lost Weekend nè è il contraltare debosciato e rock’n’roll. I modelli, qui, sono la Rolling Thunder Revue (non a caso si riprende la dylaniana Knockin’ On Heaven’s Door) oppure la fiesta tex-mex di album come Doug Sahm & Friends. Buttate giù senza grosse pretese, ballate come Song For The Dreamers e The Word Is Out funzionano proprio per la loro divertita spontaneità, ed è impossibile non farsi trascinare sul pavimento da inni per avvinazzati come Baby, We All Gotta Go Down. American music al suo (sgangherato) meglio. Ventidue anni dopo, inaspetttamente, Danny & Dusty si ritroveranno al bancone del bar. Con un nuovo disco, seguito da un tour e un live.
LONG RYDERS – State of Our Union (Island, 1985)
Lo “stato dell’unione” visto da un quartetto di rockettari, con Gram Parsons e Neil Young come guide ideologiche. Tematicamente simile a Gas Food Lodging dei Green On Red, l’esordio su major vede i Long Ryders impegnati a ripassare la lezione del country-rock e i ricordi dell’”american cosmic music”, mentre al contempo lanciano uno sguardo critico alla situazione sociale del loro paese. Good Times Tomorrow, Hard Times Today, dice il titolo di un pezzo: c’è la consapevolezza che si vivono tempi grami, che il patriottismo serve solo a mascherare porcherie in giro per il mondo (Capturing The Flag), che il potere d’acquisto si è dissolto (You Just Can’t Ride The Boxcars Anymore), ma l’onda lunga dei sixties, in questo caso, oltre che lambire le chitarre porta con sé anche una punta l’ottimismo: domani sarà meglio. Il passato serve invece a Griffin e McCarthy come metafora del presente nell’intensa Years Long Ago e nel singolo Lookin’ For Lewis And Clark. Quest’ultima rappresenta forse i cinque minuti migliori dei Long Ryders, con quel fischio iniziale, quel riff e quel “Louie Louie Louie Lu” che riesce a rendere rock’n’roll persino un esploratore ottocentesco.
GAME THEORY – Big Shot Chronicles (Rational, 1986)
Il Paisley non era tutto bolle di sapone psichedeliche e ruvido roots-rock da veri uomini. Tra i tasselli che componevano il mosaico c’era, immancabile, anche quello del power-pop. L’interprete più convinto della lezione di Badfinger e Big Star era Scott Miller, un tipo sfuggente che sotto una massa di capelli alla Jesus & Mary Chain celava idee melodiche di prim’ordine. Voce delicata e una certa propensione per il folk-pop più zuccheroso (non a caso è pappa e ciccia con Michael Quercio dei Three O’ Clock, che produce uno dei primi ep dei Game Theory e col quale collaborerà a lungo in futuro), tuttaiva sapeva anche velocizzare i tempi e alzare il tiro delle chitarre quando era il caso. Big Shot Chronicles, secondo album di una formazione nella quale Miller fa da padre e padrone, è opera che sta al limitare del Paisley – senza saperlo, ha più a che fare con i Sebadoh e i Guided By Voices di dieci anni dopo – ma si fa ricordare per squisiti bigné pop come Erica’s Word e Crash Into June.
NAKED PREY – Under The Blue Marlin (Frontier, 1986)
Cugini sfigati dei Green on Red, i Naked Prey erano la band di Van Christian, buddy inseparabile di Dan Stuart fin dai tempi di Tucson e batterista nei Serfers, embrione del “verde su rosso”. Anima candida e idealista, Christian ha un’idea di rock vigorosamente proletaria, più incline al fast’n’furious del punk che ai trip psichedelici. Ma è a suo agio anche con la formula della ballata elettrica, e ne scrive qualcuna che non sfigura affatto al confronto con quelle del vecchio amico. Però poi deve metterci a fianco una cover degli Stooges per ristabilire l’equilibrio. Il primo album dei Naked Prey – dopo un ep omonimo pubblicato dalla Down There di Wynn – sta in equilibrio su questo filo teso, senza mollare mai il tiro. Un suono ingenuo eppure volitivo, dimostrazione di come, quando c’è la passione che brucia, il rock’n’roll possa fare miracoli fregandosene dei limiti di chi lo mette in scena. Non un fuoriclasse, Van Christian, ma un arrembante mastino di centrocampo che in questo album si gioca la partita della vita.
OPAL – Happy Nightmare Baby (Sst, 1987)
È un wah wah dai singolari tratti orientaleggianti a introdurre all’ultimo, magnifico spasmo del Paisley Underground, nonché al più grande disco di acid-rock degli anni ’80. Che incipit memorabile, Rocket Machine: un razzo che punta dritto al cuore oscuro del sogno psichedelico. Una volta atterrati dall’altra parte della luna, sono i Floyd di A Saucerful Of Secrets a guidare le danze, in una Magick Power che ghermisce la mente con lampi di luce accecante e spirali di organo, chitarre e tablas. Il vecchio Syd è un fantasma che saluta da lontano in Siamese Trap e A Falling Star, Marc Bolan spunta improvvisamente in She’s A Diamond e si mette a jammare con l’Hendrix di Axis: Bold As Love. Ombre che appaiono e scompaiono, stati di alterazione che si alternano a oasi di quiete (Happy Nightmare Baby), fino a quando ci si ritrova a sprofondare nel buco nero di Soul Giver. Un disco memorabile, che forse avrebbe dovuto uscire tre anni prima. Proprio mentre si approssima il “rompete le righe”, Kendra Smith e Dave Roback suggellano un’intera stagione con un epitaffio che ne celebra al meglio lo spirito romantico e le occasioni perdute.

No (more) fun. A proposito di Gimme Danger, gli Stooges e tutto il resto.

C’è un momento, in Gimme Danger, nel quale quel mito assoluto chiamato Danny Fields ricorda il suo primo incontro con gli Stooges. Era andato, pressato da Wayne Kramer, a un loro concerto in un liceo di Detroit. Fields racconta che mentre era nel corridoio della scuola venne trafitto dal casino mostruoso che arrivava dalla palestra nella quale Iggy e soci avevano già attaccato a suonare. “Iggy e gli Stooges li sentii prima ancora di vederli”. Per me fu l’opposto: li vidi prima di sentirli, e andò avanti così per un paio d’anni. Nel senso che per un paio d’anni, più o meno dai quindici ai diciassette, mi sono rigirato tra le mani la copertina del primo album senza che mi decidessi mai a comprarlo. Il negozio di dischi in cui si svolgeva a cadenze regolari questo patetico tira-e-molla si chiamava piuttosto incongruamente Maschio. Era uno dei negozi storici di Torino, ma a dire la verità il me stesso liceale ci andava perché attirato, più che dal fornitissimo catalogo, dalla presenza di una bella commessa vagamente somigliante a Grace Slick. Una presenza fatata e inarrivabile, che contrastava con l’inquietante virilità del nome del negozio e della quale tutta la Torino che comprava dischi era innamorata. Naturalmente non ebbi mai il coraggio di rivolgerle la parola, tanto meno per chiederle che tipo di musica facessero quelle quattro facce da tossici che puntualmente mi capitavano in mano mentre frugavo nelle vaschette degli lp. A quindici anni ne sapevo ancora poco di storia del rock, Iggy Pop era un nome che avevo vagamente orecchiato da qualche parte ma non sono sicuro, ripensandoci, che avessi colto che era proprio uno dei quattro sulla copertina del disco. Collegare il passato al presente era molto più problematico, allora. Nel 1983 (o era già l’84? boh) il 1969 sembrava distante un millennio, e per quanto ne sapevo quei tizi potevano già essere tutti morti. Viste le facce era anche abbastanza probabile (e su uno, in effetti non mi sbagliavo). Comunque sia, quel disco mi attirava da bestia solo in virtù di quelle due foto del gruppo, in particolare quella sul retro. Mi sembrava che quei quattro avessero il look più figo che avessi mai visto, persino più dei Ramones ai quali un po’ assomigliavano. Il concetto di “proto-punk” per un quindicenne del 1983, alla fine, si fermava a questo.

Comunque sia: mi attirava, quel disco, ma mi faceva anche una paura fottuta. Quei quattro saranno stati pure fighissimi con i loro capelli a caschetto e le giacchette di cuoio, ma avevano uno sguardo luciferino che mi faceva cagare sotto. Lì dentro c’era una forza maligna per la quale – intuivo – bisognava essere pronti. Lo sarei stato, quel tanto che bastava, solo un paio d’anni più tardi. In una intervista Frank Black dei Pixies, alla domanda “qual è la cosa più figa che ti è capitata nella vita?”, aveva risposto “ascoltare gli Stooges per la prima volta su un walkman scassato…ecco, quella è stata una cosa veramente figa”. A me capitò lo stesso. C-90 prestata da un amico, su un lato il primo disco e sull’altro Fun House. L’amico aveva avuto l’idea geniale di registrare quella rottura di coglioni di We Will Fall al fondo del disco, per cui dopo il wah wah tribale di 1969 e il sabba di I Wanna Be Your Dog arrivavano subito la batteria e l’handclapping di No Fun per non spezzare il ritmo. Al primo “oh c’mon!” la mia vita era già cambiata, il mio mondo sottosopra, l’idea stessa di cosa fosse “musica rock” trasfigurata per sempre. Penso sia successo a quasi tutti quelli che hanno ascoltato la prima volta gli Stooges, o forse a chi lo ha fatto quando ancora non c’erano troppe sovrastrutture – il mito codificato, i luoghi comuni critici, i video su youtube, persino la reunion – a gravare sopra quell’esperienza primale e animale. Alla fine di Little Doll avrei voluto scendere in strada e spaccare tutto. Ci misi una settimana prima di decidermi a girare lato della cassetta, e…va beh, ma cosa volete che vi racconti sull’impatto di Fun House? È una botta dalla quale non mi sono ancora ripreso dopo trent’anni. Dato che non mi ricordo dove ho lasciato la macchina ieri sera ma posso citare a memoria, parola per parola, articoli di Rockerilla del 1989, mi torna in mente una recensione di Claudio Sorge del primo album dei Mudhoney nella quale per metà parla della sua prima volta con gli Stooges, avvenuta – fortunato lui – in tempo reale. “C’erano gli scioperi spontanei e l’aria era bollente…”. Ecco, quando li ho sentiti io invece non stava succedendo un cazzo – another year with nothing to do, come tutti gli anni 80 – ma l’effetto devastante è stato identico. In quel momento non avrei saputo spiegarmelo in questi termini, ma in un certo senso è come se gli Stooges mi avessero dettato le regole d’ingaggio. Non avrei più saputo ascoltare il rock’n’roll (quello che era venuto dopo gli Stooges, quello a loro contemporaneo e persino quello che c’era stato prima) senza parametrarlo a quella scossa. E la prova ulteriore e finale l’avrei avuta una sera d’estate del 2004 alla Pellerina di Torino, quando Iggy, Ron, Scott e quel grand’uomo di Mike Watt si sarebbero esibiti al Traffic Festival. Uno degli organizzatori, prima del concerto, mi aveva detto: “mah, speriamo bene…Iggy ha dei problemi a un’anca, e poi oh, ha cinquantasette anni”. Certo. A metà del secondo pezzo si era già arrampicato su tre metri di amplificatori. Quel concerto è e resterà in eterno nella mia top 5 di esperienze più emozionanti in una vita di appassionato di musica. Quella sera mi parve che tutto il rock’n’roll che avevo ascoltato in quei vent’anni – tutta la sacra litania che delimita il mio perimetro magico: Chuck Berry e Jerry Lee-le girls band e la Motown-la british invasion-i gruppi garage-Velvet/MC5/Flamin’Groovies/New York Dolls/Modern Lovers- i Pistols e i Ramones-tutto il punk-i Radio Birdman e le band australiane-tutto il rock sotterraneo degli anni 80-i Sonic Youth, i Dinosaur Jr, Seattle, i Mudhoney e quello là che si è sparato-ecco, che tutto ciò convergesse esattamente in quel momento. Tutto aveva senso, Dio era nei cieli e Iggy a rotolarsi sul palco. Il rock’n’roll era lì, davanti ai miei occhi, come non lo sarebbe stato mai più.

Ingenuamente, ho pensato che la visione di Gimme Danger avrebbe – fuori tempo massimo, ok, ma chi se ne frega – attivato ancora una volta quella scossa. Non è stato così. Anzi, la sensazione è stata forse quella opposta. Il che non significa che non mi sia piaciuto. Tutt’altro. Sono contento che alla fine esista un documentario sugli Stooges, e che a farlo sia stato uno come Jim Jarmusch. Ci sono abbastanza aneddoti spassosi da giustificare gli undici euro di biglietto – i miei preferiti: Iggy che tenta di essiccare la pianta di marijuana in lavanderia, la telefonata di Ron Asheton a quello dei Three Stooges per avvisarlo che si sarebbero chiamati come loro, la faccia dell’Iguana quando ricorda che Tony Defries voleva fargli fare Peter Pan a Broadway – e anche quel tanto di commozione e nodo in gola che ti prende qui e là con gli occhi che si inumidiscono a tradimento (il volto sofferente del moribondo Scott Asheton, Watt che racconta le vicende che hanno portato alla reunion, James Williamson che dice “hey, they were my buddies” quando spiega perché un ex CEO della Silicon Valley e manager della Sony in pensione decide di tornare a farsi il mazzo suonando la pennata di Search and Destroy in giro per il mondo). Con la scarsezza di materiale video a disposizione – imparagonabile, giusto per fare un esempio, alla quantità di materiale d’archivio che riguarda gli MC5 – Jarmusch ha fatto tutto quel che poteva e pure qualcosa in più. Ho anche trovato apprezzabile la decisone del regista di non voler dare un taglio troppo “autoriale” al film, rischiando tuttavia di adagiarsi un po’ sugli stereotipi del genere “rockumentary”, in particolare quelli imposti dallo stile di Julien Temple. Avrei forse gradito che ci soffermasse di più su alcuni momenti della vicenda Stooges – il periodo a Londra, l’ultimo concerto al Michigan Palace che viene evocato solo all’inizio – e se da un lato si può intuire la ragione per cui a Bowie si accenna il minimo indispensabile dall’altro non viene neppure fatto il nome di Don Gallucci, il produttore di Fun House. E poi diciamolo: se hai a disposizione un archivio umano di ricordi e lercissimi aneddoti r’n’r come Danny Fields dovresti sfruttarlo un po’ di più, come sa chiunque abbia letto Please Kill Me. Ma forse queste sono solo minuzie e pretese da fan. Nel suo concentrare il focus esclusivamente sui protagonisti della storia, il racconto funziona e trasmette anche un piacevole senso di intimità. Il punto, però, è che trasmette anche qualcos’altro di meno piacevole, anche se tutto sommato inevitabile. È una sensazione da end of the season, definitiva e malinconica. Alla fine ciò che ci rimane è una vecchia rockstar che, pur con tutta l’intelligenza, il talento e il senso dell’umorismo di cui Iggy è dotato, ci racconta probabilmente per l’ultima volta una storia che in fondo conoscevamo a memoria e che ci siamo raccontati migliaia di volte come fanno i bambini con le fiabe. Il ritmo, come dire?, stranamente “sedato” e sobrio del documentario si abbina perfettamente, e anche un po’ dolorosamente, alla visione di un uomo sopravvissuto a tutti tranne uno dei suoi vecchi compagni di band, a David Bowie, a Lou Reed, a tre quinti degli MC5. Un uomo di granito, ma che ormai deve fare i conti con la consapevolezza che il ciclo di quella vicenda si è esaurito nella sua interezza: gioventù, caduta, resurrezione, crescita della leggenda, riunione in extremis. Ora è davvero tutto finito. Quella storia l’abbiamo consumata fin dove abbiamo potuto, ora è impacchettata in uno scatolone, pronta per la soffitta della cultura popolare. Iggy andrà avanti e farà il cazzo che vuole come ha sempre fatto, come quando a ventidue anni spiegava a John Cale che voleva mischiare il r’n’r con Harry Partch e John Coltrane. Ma la malinconia rimane.
In un certo senso, Gimme Danger è un esempio perfetto di quella che gli americani chiamano “closure”. Una sorta di veglia per l’avventura di quattro disgraziati di Ann Arbor (cinque con Williamson). Per una piccola garage band come migliaia di altre che per una inspiegabile concomitanza di circostanze e di personalità, per un clinamen impossibile da definire, ha colto miracolosamente l’essenza stessa di questa musica diventandone la rappresentazione ideale. Ma è anche una closure su un mondo che gli Stooges hanno definito – quella cascata di dischi che si vede alla fine: ecco, quel mondo – e che non tornerà mai più. O semplicemente non tornerà mai più in quelle forme. Essendo un appassionato di musica e un ottimista, sono convinto nonostante tutto che da qualche parte altri quattro rifiuti della società saranno capaci di crearne un altro. Accadrà, ne sono sicuro.
Nell’attesa? Well…maybe go out, maybe stay home, maybe call mom on the telephone.


